Ha colmato una lacuna e aperto una strada, presentato in tutta Italia, dal Conservatorio di Milano a quello di Palermo, già adottato come testo in molti istituti, e il prossimo anno sarà ancora al centro di diversi appuntamenti, ad esempio al Conservatorio di Torino e in quello di Castelfranco Veneto. Il manuale di Giusy Caruso dal titolo La ricerca artistica musicale. Linguaggi e metodi edito da Libreria Musicale italiana (Giusy Caruso, La ricerca artistica musicale. Linguaggi e metodi, Lucca, LIM 2022, pp. XXII+315, 28,00 €) è diventato in brave tempo il testo di riferimento che sta accompagnando in Italia la formazione della figura dell’artista ricercatore, nello specifico in campo musicale, che si distingue dalla figura del musicologo perché l’artista ricercatore è innanzitutto un artista che sviluppa la sua riflessione teorica a partire dalla sua stessa pratica, dalla sua stessa performance creativa. A differenza della ricerca portata avanti da teorici della musica e dai musicologi che ha come oggetto creazioni già compiute, l’artista ricercatore, infatti, crea e studia la creazione allo stesso tempo, aggiungendo alla ricerca teorica un nuovo punto di vista e una nuova prospettiva, quella dell’artista creatore, capace di generare nuove informazioni e riflessioni cruciali per una più esaustiva comprensione della creazione stessa.
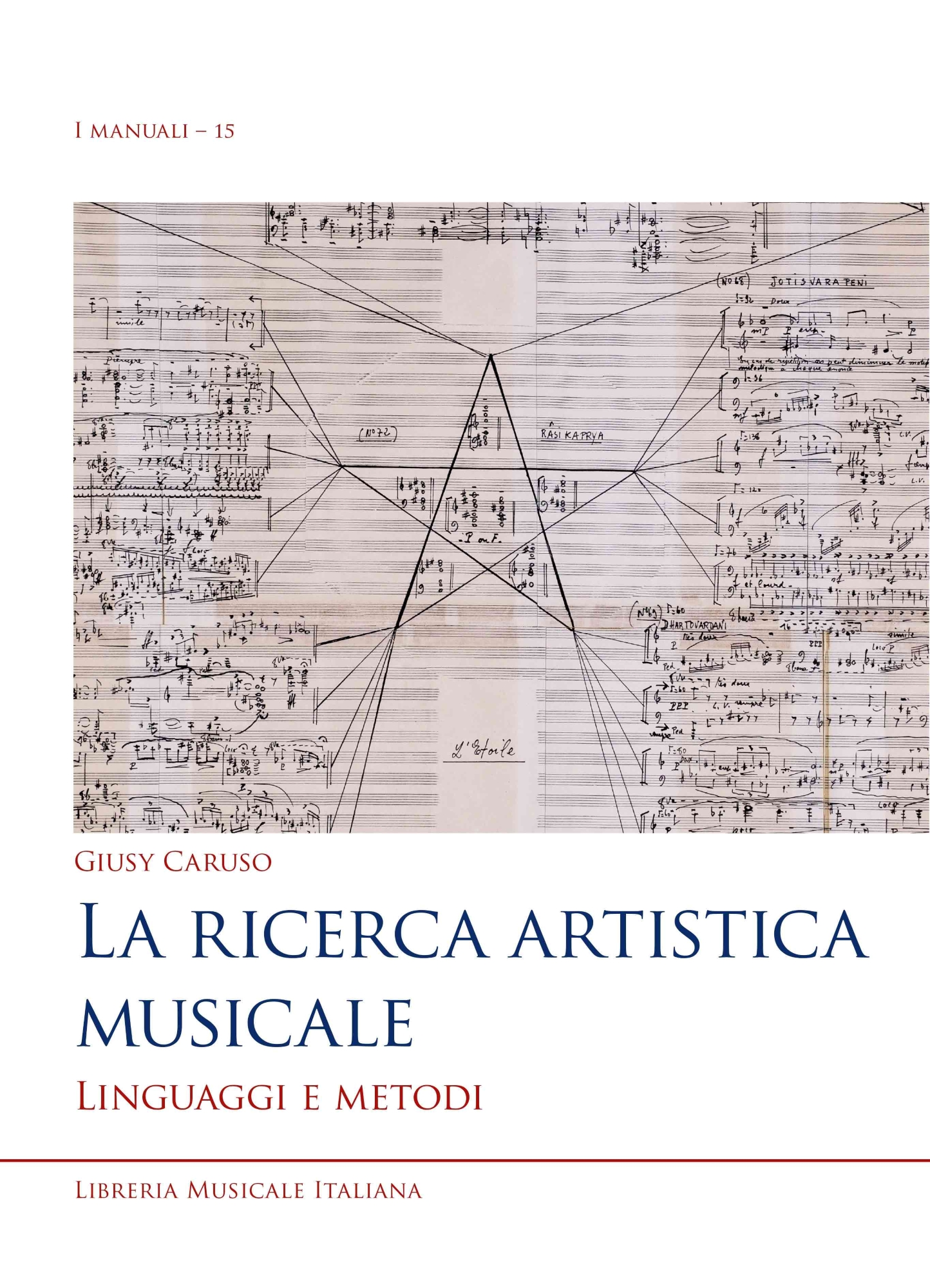
Pubblicato nel 2022, il volume ha anticipato la nascita dei dottorati nel campo della “artistic research” anche nei Conservatori italiani, dottorati che in Nord Europa esistono già da una ventina d’anni, nati in Inghilterra e poi sviluppatisi soprattutto in Svezia, Finlandia e nella parte fiamminga del Belgio. Ed è proprio in quest’ultimo Paese, a Gand, che la pianista Giusy Caruso, nata in Calabria ma da anni residente a Bruxelles, ha iniziato nel 2012 il suo percorso di ricerca artistica nel cui ambito è nato poi il manuale. Un testo quindi che è nato proprio per contribuire alla nascita anche in Italia del nuovo percorso di alta formazione che coniuga l’approfondimento, contemporaneamente, delle competenze strumentali e quelle legate alla ricerca. Già poco dopo la sua pubblicazione, ad una presentazione a Roma, Giovanna Cassese, presidente del CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, lo ha definito un testo di riferimento per elaborare la nuova normativa disciplinante i dottorati di ricerca musicale in Italia.
Come scrive il musicologo Renzo Cresti nella sua nota di presentazione: «La trattazione segue un percorso ben delineato, con argomentazioni particolareggiate ma che si comprendono con chiarezza, utili allo studioso e allo studente». Il testo è suddiviso in tre parti: il primo è dedicato alla ricerca artistica in generale; il secondo alla ricerca artistica musicale in particolare; il terzo è un esempio concreto di ricerca artistica musicale dato che ripercorre lo studio condotto con tale approccio dalla stessa Giusy Caruso sui 72 studi carnatici per pianoforte del compositore francese Jacques Charpentier (1933-2017) di cui la pianista è uno specialista sia a livello performativo che di studio, analizzando in particolare l’intenzionalità e il gesto nella performance pianistica di tale compositore. La Caruso incarna lei stessa, quindi, tra i primi in Italia, la nuova figura del musicista ricercatore che parte dalla pratica musicale per approfondire la riflessione teorica, senza trascurare anche un’attenzione alla divulgazione indispensabile per non restare chiusi nella propria torre d’avorio e contribuire invece alla diffusione della conoscenza nella comunità tutta. Dal punto di vista delle esperienze concrete, molto interessante anche la prefazione al volume dello storico delle arti fiammingo Kevin Voets che ripercorre le tappe che hanno portato ad una nuova configurazione dei Conservatori moderni, anche analizzando gli effetti della cosiddetta Dichiarazione di Bologna del 1999 che ha segnato l’avvio di una profonda riforma dell’alta formazione in Europa, in particolare richiamando il percorso fatto nelle Fiandre pure sul concetto di scuola delle arti, tra l’istruzione accademica e quella professionale, e sull’artista considerato pure come artigiano.
Per quanto riguarda la metodologia di ricerca, nella nuova figura dell’artista ricercatore l’indagine di tipo qualitativo è sempre più affiancata da quella di tipo quantitativo, facendo dialogare sempre più arte e scienza in un’ottica multidisciplinare, avvalendosi delle più recenti ricerche sulle neuroscienze quanto delle più antiche credenze di discipline orientali quali lo yoga, e grazie agli apporti anche delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale vista in modo positivo come un mezzo che può amplificare la propria creatività. Non è un caso che Giusy Caruso è pure vincitrice del premio S+T+Arts 2023 assegnato dalla Commissione Europea ai progetti pionieristici che uniscono arte, scienza e tecnologia.
Il testo comunque non è solo per addetti ai lavori, ma un appassionante riflessione sui rapporti tra arte e ricerca, infatti, “se c’è arte, c’è sempre ricerca?” è la domanda che apre la prima parte del volume, ma anche assai intrigante e applicabile ad altri ambiti pure l’approfondimento di come i metodi scientifici moderni sono applicabili anche alle arti.. Particolarmente originale in tale approccio multidisciplinare, la riflessione sul ruolo del corpo nella performance creativa e l’ultimo capitolo della terza parte è intitolato significativamente “in corpore...sonus” e qui la Caruso indica delle piste per ulteriori ricerche e approfondimenti definendo, con un’immagine assai felice, la ricerca artistica come una “fuga”, come “contrappunto” di voci . Una nutrita postfazione è poi di Antonio Grande che torna sui rapporti e sulle differenze tra interpretazione e performance, sulle pratiche artistiche e sul ruolo delle tecnologie anche per fini analitici e di documentazione.
Oltre alle interessanti riflessioni storico-sociali-filosofiche e sulle metodologie di ricerca, il volume contiene anche un utile per tutti glossario dei termini utilizzati nella ricerca musicale, spesso in modo impreciso od improprio, in italiano ed in inglese, il cui significato è definito nel manuale nelle sue eventuali diverse sfumature sulla base di una precisa bibliografia. Un’appendice fornisce infine anche suggerimenti per l’ideazione e stesura di un progetto di ricerca artistica in generale.
La Caruso adesso sta pure pensando alla versione francese del suo manuale, che non sarà una semplice traduzione ma una contestualizzazione alla normativa del Belgio francofono e della Francia dove pure, come in Italia, si sta avviando ultimamente un percorso di ricerca artistica.
Sull’argomento, la Caruso tiene anche un corso online una volta al mese per l'Associazione Musicale G.B Pergolesi e è ideatrice e direttrice del Campus Internazionale sulla Pratica e Ricerca Artistica che si tiene da due anni in Calabria, a Cetraro, col patrocinio del Royal Conservatoire Antwerp dove la Caruso lavora come artista ricercatore post-dottorato ed è capo del gruppo di ricerca CREATION. E tra gli studiosi italiani c’è già anche chi ha chiesto all’autrice di andare ad approfondire il nuovo approccio come visiting researcher proprio con lei in Belgio, al Conservatorio d’ Anversa.


