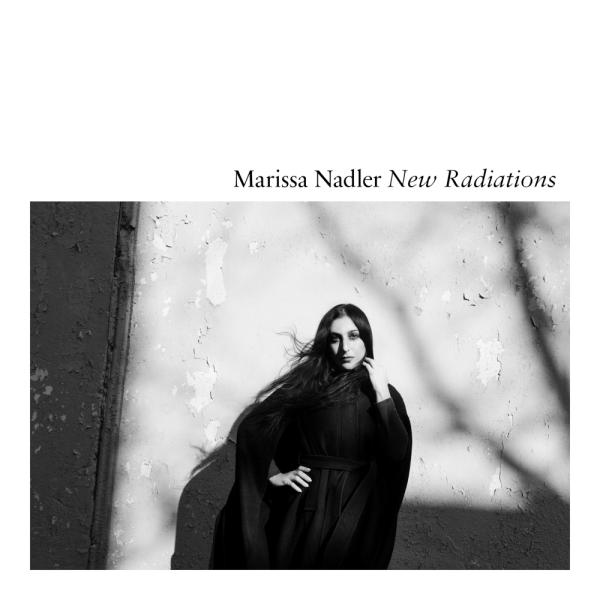Quale St. Vincent?
All Born Screaming è il “brutale” settimo album di Annie Clark, una nuova incarnazione di St. Vincent

Che cosa sappiamo di Annie Clark, dal 2006 in arte St. Vincent? Benché abbia varcato la soglia dei 40 anni (“In effetti non penso all’età, perché come musicista devi essere un po’ Peter Pan”, ha specificato a proposito su “The Guardian” poche settimane fa) e sia in carriera da due decenni, la sua identità rimane sfuggente.
– Leggi anche: St. Vincent negli anni Settanta
Cantautrice sui generis, con voce da mezzosoprano, e chitarrista virtuosa, agisce ai margini del mainstream, senza disdegnarlo (ha messo la firma sul singolo “Cruel Summer” di Taylor Swift, ad esempio), né tuttavia assoggettandovisi.
Non aveva chiarito alcunché il finto documentario The Nowhere Inn (2020), venuto dopo lo sfacciato glam da dominatrice ostentato in Masseduction (2017), cui era seguita discograficamente l’ambientazione anni Settanta di Daddy’s Home (2021), dove – mimetizzata da una parrucca bionda – esplorava la relazione contraddittoria con il padre.
A differenza del passato, in All Born Screaming – settimo album della serie: una decina di canzoni in poco più di 40 minuti – mette in mostra sé stessa anziché un altro cosplay. Lo spunto è un imprecisato evento traumatico: “Mi sono ritrovata sul precipizio tra la vita e la morte”, ha confessato preliminarmente. Ecco allora “il mio disco meno divertente, affamato di vita, anche se brutale, perché la vita è brutale”.
In senso musicale potremmo dire, grossolanamente, che ha riscoperto l’originaria attitudine rock: parte delle registrazioni arriva dagli studi Electrical Audio di Steve Albini, dei cui Big Black interpretava tempo fa dal vivo “Bad Penny” e “Kerosene”, e giova ricordare che lo pseudonimo scelto proveniva da “There She Goes, My Beautiful World” di Nick Cave e in gioventù – mentre studiava al Berklee College of Music – aveva strimpellato grunge in una band chiamata Skull Fuckers, cosicché nel 2014 non fu casuale il suo cammeo in “Lithium” al momento dell’ammissione dei Nirvana nella Rock’n’Roll Hall of Fame.
Ritrova ora Dave Grohl in un paio di scorci del nuovo lavoro: lo ascoltiamo percuotere i tamburi da par suo in “Broken Man”, spigolosa ballata elettrica che riecheggia il periodo blues di PJ Harvey sfoderando versi minacciosi (“Sulla strada sono un assassino formato gigante, posso far sì che venga il tuo regno, in piedi sono un terremoto che sussulta”).
Com’è noto, Grohl ha ceduto ad altri il ruolo di batterista nei Foo Fighters, occupato attualmente da Josh Freese, anch’egli ospite nell’iniziale “Hell Is Near” (folk dai tratti vagamente gotici con paesaggio da natura morta: “Una tazza vuota e un barattolo pieno di calendule, candela mezza bruciata, una foto appuntata al muro, lettere, dischi e cenere sul linoleum”, oggetti definiti però “segni di vita”) e nello strampalato reggae “So Many Planets”, venato di ansia a dispetto delle apparenze (“Sostanze chimiche che fanno cilecca e idee spaventose, questa rivoluzione non è divertente, mamma, sono fuori moda, ho Dio alle calcagna”).
La sequenza include inoltre il morboso electro funk in stile Prince “Big Time Nothing”, scandito da una tiritera prescrittiva (“Non battere le palpebre, non aspettare, non camminare, sei in ritardo, non cadere in disgrazia, comportati bene, non inciampare”), l’elegante esercizio di scuola John Barry epoca 007 in “Violent Times” (frase chiave: “Tutte le notti sprecate a combattere la mortalità, quando nelle ceneri di Pompei si scoprono gli amanti abbracciati per l’eternità”), il mesto valzer di stampo apocalittico “The Power’s Out” (“È saltata la corrente in tutta la nazione, signore e signori sembra che abbiamo un problema, disse l’uomo sul mio schermo, proprio mentre qualcuno gli sparava”), la commemorazione coerentemente “hyperpop” di Sophie in “Sweetest Fruit” (“È salita sul tetto per vedere meglio la luna, poi – mio Dio – un passo falso l’ha fatta precipitare, ma per un minuto, che vista!”) e persino il vezzo “prog” espresso nell’insidioso “Flea” (“Sono come una piccola pulce affamata, che salta sul corpo caldo di qualcuno, quando inizi a sentire prurito, grattarti e urlare”).
Manca dunque un centro di gravità. Dovendo cercare il bandolo della matassa, ci si potrebbe soffermare sul titolo: “Comunica insieme l’estasi e l’agonia e tutto ciò che significa essere vivi”, ha dichiarato lei in un’intervista radiofonica.
Corrisponde all’episodio conclusivo, che sviluppa un discorso autobiografico (“Ero la pantomima di una ragazza moderna, bei tempi, ma ero infelice, una versione karaoke dell’‘Hallelujah’ di Leonard”) in un contesto condiviso (“Tutti siamo nati strillando”).
Qui compare l’amica e collega Cate Le Bon, già in azione fra le quinte in tre altri brani, per quanto onori e oneri della produzione spettino interamente – novità assoluta – a St. Vincent: “Volevo essere il primo e ultimo filtro di questo materiale”, ha spiegato, aggiungendo di essersi sentita “un Dio che gioca con i fulmini e imbriglia il caos”.
Ciò rafforza la sensazione che All Born Screaming sia il suo album più personale, non necessariamente il migliore, ma di gran lunga quello infuso di maggiore schiettezza.