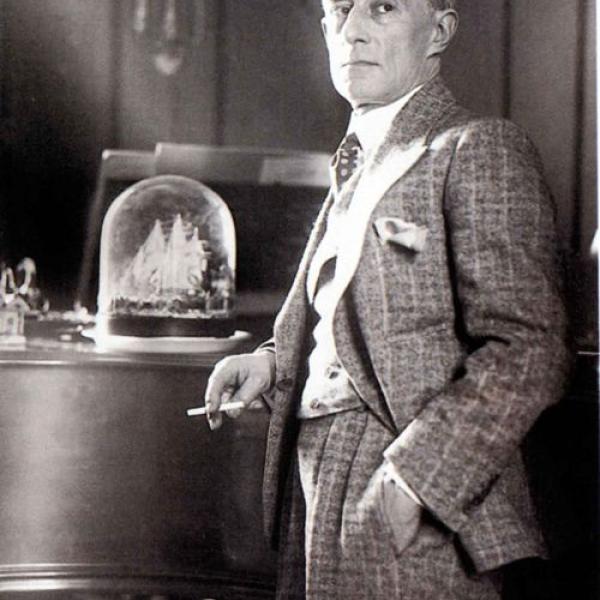A pochi giorni dall’avvio ufficiale della XXXVI edizione di Ravenna Festival, che verrà inaugurata sabato 31 maggio da Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Cherubini con Giuseppe Gibboni violino solista – e un programma che prevede il Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra K 218 di Wolfgang Amadeus Mozart incastonato tra l'Ouverture in do minore op. 62 “Coriolano” e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven – Angelo Nicastro, direttore artistico della manifestazione “a quattro mani” con Franco Masotti, ci illustra quella parte di programma che si riferisce a un repertorio che possiamo definire di ambito più “classico”, nel quadro del tradizionale approccio multidisciplinare del festival.
– Leggi anche: Ravenna Festival 2025, il coro come voce di un’anima collettiva
– Leggi anche: Lo sguardo contemporaneo di Ravenna Festival

Quest’anno in un certo senso avete eletto come testimonial Sancho Panza, scegliendo quale motto di Ravenna Festival 2025 la sua frase “Donde hay música no puede haber cosa mala” (“dove c’è musica non ci può essere alcun male”). Perché Don Chisciotte?
«Quest’anno si concluderà il progetto triennale realizzato in collaborazione con Ravenna Teatro dedicato al folle Hidalgo di Cervantes – che fa seguito al Cantiere Dante che avevamo dipanato nelle quattro edizioni precedenti di Ravenna Festival. La frase in questione, oltre che suggellare la conclusione del percorso del Don Chisciotte ad ardere, condotto con la consueta maestria da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari con il coinvolgimento di centinaia di cittadini ravennati che hanno risposto a una chiamata pubblica, ha una forte valenza intrinseca nel ribadire il potere, che potremmo dire eversivo, della musica, rispetto ad un mondo che vediamo sempre più dominato dalla violenza, dall’odio e dalle guerre. La folle visionarietà di Don Chisciotte che afferma una realtà che va oltre le apparenze, è un forte richiamo a non smettere di sognare, e di sperare in un mondo diverso e migliore. La musica e l’arte, come ogni espressione di bellezza, tengono desto questo desiderio di cambiamento e di bene, l’essenza del nostro essere umani, oggi fortemente minata alle sue stesse radici. In qualche modo la frase che abbiamo scelto come titolo dell’edizione 2025 di Ravenna Festival, riassume lo spirito e la tensione che animano il ricco calendario di eventi in programma e l’aggregazione che attorno ad essi si crea: la visionarietà diventa visione e concreta esperienza di un bene e di una bellezza condivisi».

Il 31 maggio Riccardo Muti inaugura con la sua Orchestra Cherubini questa XXXVI edizione, poi su podio saliranno Zubin Mehta e Daniel Harding rispettivamente con le orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: qual è il filo conduttore che lega i direttori e le orchestre protagonisti del versante sinfonico del programma?
«La programmazione sinfonica è uno dei cardini della nostra programmazione da sempre, sia per la costante presenza del maestro Muti che ogni anno abbiamo il privilegio di ospitare per più di un appuntamento – quest’anno dopo il concerto inaugurale sarà protagonista di un secondo concerto sinfonico il 5 luglio e del progetto Cantare amantis est che porterà a Ravenna oltre 3.000 cantori professionisti e non – sia per la presenza delle più illustri compagini sinfoniche del panorama internazionale e dei più grandi direttori che abbiamo ospitato negli anni. Quest’anno abbiamo scelto di affiancare all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dal Maestro Muti, due fra le più prestigiose formazioni sinfoniche italiane, quali l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con il suo direttore onorario Zubin Mehta e l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia con il suo direttore musicale Daniel Harding. Un tratto che contraddistingue i primi due concerti è la presenza di due giovanissimi violinisti, Giuseppe Gibboni – che sarà solista nel quarto concerto di Mozart diretto da Riccardo Muti – e Amira Abouzahra, non ancora ventenne, che interpreterà il concerto per violino di Beethoven diretto da Zubin Mehta».

Anche quest’anno avete riservato uno spazio all’ambito contemporaneo con proposte che vanno, tra le altre, dalla ripresa di Anita – opera di Gilberto Cappelli su libretto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli che ha debuttato lo scorso anno a Spoleto – a un omaggio a Luciano Berio nel centenario della nascita…
«L’attenzione al contemporaneo si conferma anche quest’anno tassello imprescindibile della nostra programmazione. L’opera Anita di Gilberto Cappelli sarà significativamente riproposta nel contesto ideale e suggestivo della fattoria Guiccioli – dove Anita Garibaldi spirò durante quella che è nota come la trafila romagnola; l’omaggio a Luciano Berio, nel centenario della nascita, è affidato al Duo Aria, formato dal fisarmonicista Carlo Sampaolesi e dal contrabbassista Pietro Elia Barcellona, che proporrà le Sequenze per fisarmonica e per contrabbasso del grande compositore di Oneglia, per completare il programma con il duo “In bianco e nero” di Francesca Venturelli. Oltre a questi 2 eventi da lei citati, segnalerei la commissione della sacra rappresentazione alla giovane compositrice Marianna Acito su testo di Francesca Masi, Rut – raccolti di speranza, dedicata ad una figura biblica femminile fortemente simbolica ed evocativa. Affidata alle voci di Laura Zecchini, Daniela Pini e Angelo Testori con l’Ensemble La Corelli e il Gruppo Vocale Heinrich Schütz sotto la direzione di Mattia Dattolo, è in programma nella Basilica di San Giovanni Evangelista dal 10 al 16 giugno e sarà replicata al Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone e al Pergolesi Spontini Festival. Da non dimenticare poi i significativi appuntamenti con Surrogate Cities di Heiner Goebbels il 7 giugno e In A Landscape Tour di Max Richter – illustrati da Franco Masotti nella sua precedente intervista».
Un altro filone ormai distintivo che viene riconfermato è quello dedicato alla musica sacra o comunque di matrice spirituale offerta nelle basiliche e nelle chiese della vostra città e provincia: qual è la proposta di quest’anno?
«La proposta è assai ricca e varia e non poteva prescindere dalla circostanza singolare del Giubileo della Speranza che si celebra quest’anno. Il 4 giugno, nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe, presenteremo l’oratorio di Alessandro Stradella “San Giovanni Battista”, commissionato 350 anni fa in occasione dell’anno giubilare 1675 dalla Confraternita di San Giovanni de’ Fiorentini a Roma. Capolavoro di un grande compositore quale Stradella – che meriterebbe certamente maggiore considerazione e spazio nella programmazione dei teatri e delle società di concerti – sarà diretto da uno dei suoi più accreditati interpreti, Andrea De Carlo, alla guida dell’Ensemble Mare Nostrum».

«La splendida Basilica di Sant’Apollinare in Classe, la più antica e rappresentativa delle basiliche giubilari ravennati, sarà anche sede delle tre solenni liturgie (domenica 1, 8, 15 giugno alle ore 11) animate da The Tallis Scholars, l’Ensemble Vocale Odhecaton e il Gruppo Vocale Heinrich Schütz: saranno presiedute da illustri personalità ecclesiastiche quali Padre Mauro-Giuseppe Lepori – Abate Generale dell’Ordine Cistercense -, Dom Gianni Giacomelli – già Priore del Monastero di Fonte Avellana - e Mons. Massimo Camisasca – Vescovo Emerito di Reggio Emilia-Guastalla – relatori anche in tre conferenze legate da un unico filo conduttore, “Giubileo 2025: la speranza nelle sfide del presente”. Significativo che, nella prima conferenza, Padre Lepori abbia voluto rifarsi alla celebre frase di Dostoevskij sulla bellezza, mettendola al centro di un titolo emblematico: “Se la bellezza salverà il mondo, chi salverà la bellezza?”. A completare il ciclo In Templo Domini delle 3 liturgie – che da tempo proponiamo, convinti della necessità di ricollocare e assaporare le grandi espressioni della musica sacra nel contesto da cui sono sgorgate – i mitici Tallis Scholars, nella stessa domenica 1 giugno in cui canteranno nella S. Messa, terranno un concerto nella Basilica di San Vitale alle ore 21,30. In programma musiche di Palestrina – nei 500 anni dalla nascita – e di Arvo Pärt – nel suo novantesimo compleanno. Gli Odechaton, dopo la liturgia dell’8 giugno, dedicheranno un concerto ad Alessandro Scarlatti – nei 300 anni dalla morte – e a Palestrina, sempre a San Vitale. Gli Schütz saranno invece impegnati nella Sacra Rappresentazione Rut – raccolti di speranza, su cui ci siamo già soffermati. Sempre legato ai percorsi delle sacre rappresentazioni, che abbiamo messo da alcuni anni al centro della nostra attenzione attraverso nuove commissioni e la riscoperta e la riproposizione di grandi oratori, va segnalato il capolavoro di Dietrich Buxtehude Membra Jesu Nostri, diretto da Antonio Greco a capo del Coro & Ensemble 1685 del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, con le video proiezioni curate dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, appena presentato con grande successo nelle anteprime di Ravenna Festival».
Il resto del cartellone è animato dalla presenza di alcuni solisti e complessi da camera da un lato e dall’altro lato dall’appuntamento con la Trilogia d’Autunno: ci può illustrare brevemente i caratteri dell’uno e dell’altro versante del vostro programma?
«Per quanto riguarda i solisti e la musica da camera, abbiamo voluto, da una parte, presentare e premiare giovani di sicuro talento, quali il pianista bolognese Pietro Fresa che il 6 giugno presenta un impegnativo quanto vario e accattivante programma che spazia da Mozart a Chopin a Skrjabin a Brahms, il pluripremiato trio Orelon, il pianista goriziano Alexander Gadjiev, musicista di cultura e formazione mitteleuropea, vincitore di prestigiosi concorsi internazionali e ambasciatore culturale della sua città natale; dall'altra, proporre al nostro pubblico musicisti che si distinguono anche per un nuovo approccio alla musica, un modo innovativo, originale ed autentico di ripensare i repertori e le modalità con cui presentarli. Primi fra tutti il Vision String Quartet, che alterna una prima parte dedicata al repertorio classico per quartetto d’archi, ad una seconda di composizioni originali e improvvisazioni, con strumenti amplificati, lo sfavillante Signum Saxophone Quartet, che con grande virtuosismo, rigore e nello stesso tempo grandissima libertà, si muove con disinvoltura in stili, epoche e contesti musicali lontanissimi, il poliedrico Alessandro Tampieri, che si presenta alla guida di Accademia Bizantina passando con assoluta padronanza dal violino alla viola d’amore, il cantante, sopranista e ballerino Vincenzo Capezzuto, che accompagnato da un trio di mandolini propone il meglio della canzone d’autore napoletana, fino alle incursioni nella musica etnica proposte da Marco Albonetti con “Terra madre (Migrations)” su musiche raccolte e reinventate da Fred Sturm, per concludere con il viaggio visionario nel quale ci conduce la ricerca dello sloveno Trio Širom».

«La Trilogia d’Autunno ripropone il collaudato binomio Dantone – Pizzi che lo scorso anno ha mirabilmente condotto il progetto sul ‘600 coronato da grande consenso e successo. Il focus si sposta quest’anno sul ‘700 e su uno degli autori più rappresentativi e significativi di quel periodo aureo della musica e del teatro musicale: Georg Friedrich Händel. Abbiamo scelto due titoli ispirati all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto – con l’evidente intento di creare un collegamento con l’altro folle Cavaliere della Mancia che ha ispirato il titolo di questa edizione di Ravenna Festival – Orlando e Alcina, titolo quest’ultimo che Pizzi mette in scena per la prima volta. A completare la trilogia uno dei lavori più celebri ed amati di Händel, il Messiah, che vedrà Dantone dirigere, per la prima volta, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, mentre accosterà i due titoli d’opera con la sua Accademia Bizantina».
In chiusura propongo anche a lei la domanda che ho posto a Franco Masotti – con lei l’altra anima della direzione artistica del festival – guardando al futuro. Nella nostra prima intervista Anna Leonardi e Michele Marco Rossi si sono delineati come i futuri direttori artistici di Ravenna Festival: come vede questa prospettiva?
«La direzione artistica di Ravenna Festival è sempre stata anomala rispetto a quella di altre istituzioni musicali, per il fatto di essere composita. Io e Franco Masotti fummo chiamati da Cristina Mazzavillani Muti ad affiancarla nella conduzione di Ravenna Festival nel 1998, e per anni abbiamo costituito una direzione artistica a tre, fino a quando Cristina Muti decise, alcuni anni fa, di mantenere solo la carica di Presidente Onorario. In tutto questo lungo periodo, abbiamo lavorato in simbiosi e concordia, sempre con grande sintonia e affiatamento, cosa rara se pensiamo che il mondo attuale è sempre più indirizzato verso l’idea del self-made man, autoreferenziale e autonomo. Nel nostro ambiente poi, in cui tutti soffriamo un po’ di narcisismo e smania di protagonismo, ha quasi del miracoloso. Tutto credo dipenda dal fatto che, ciascuno, è sempre stato innanzitutto motivato dall’amore disinteressato per la musica e dalla passione per la realtà, dalla quale ci siamo sempre lasciati guidare. E la realtà, oggi, dice che gli anni passano… Personalmente, pur continuando a lavorare con la passione e l’entusiasmo di sempre, sento il bisogno di prepararmi a una nuova stagione della vita, avendo più tempo a disposizione per me stesso e per la famiglia. Da alcuni mesi ho comunicato la mia intenzione di non mantenere più, già dal prossimo anno, la direzione artistica della stagione di opera e danza del Teatro Alighieri. Nel frattempo Anna Leonardi e Michele Marco Rossi hanno iniziato, dallo scorso anno, a collaborare su progetti importanti di Ravenna Festival e si preparano ad entrare nella direzione artistica. Sono felice di fare un tratto di strada assieme a loro fino al naturale avvicendamento».
Tutto il programma di Ravenna Festival 2025 è disponibile qui.