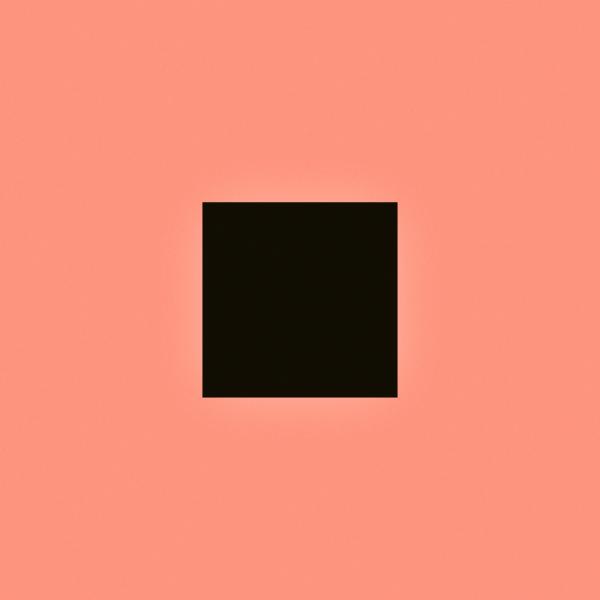Il disco perduto di Kruder & Dorfmeister
Affiora dopo 25 anni il materiale registrato dal duo viennese, pietra filosofale del “chill out”

Musica d’altri tempi, letteralmente: fa fede la data del titolo, infatti. Dal momento delle registrazioni è trascorso dunque un quarto di secolo e l’habitat sonoro frattanto è assai mutato. Il duo costituito a Vienna da Peter Kruder e Richard Dorfmeister stava salendo allora sulla cresta dell’onda: reduce dall’EP d’esordio G-Stoned, uscito per la quasi omonima etichetta discografica da loro stessi creata, e in procinto di pubblicare due “mixtape” – diremmo oggi – destinati a fare epoca, uno inserito nella collana Dj-Kicks (1996) e l’altro – The K&D Sessions (1998) – confezionato associando a una ventina di remix di brani altrui – dai divi Depeche Mode ai gangsta del rap Bone Thug ’N Harmony – un paio di composizioni originali.
La coppia austriaca aveva un tocco magico, essendo sintonizzata sulla medesima frequenza di chi dettava regola in termini di stile: Massive Attack, Air e Dj Shadow, per intendersi. Non esattamente un “genere” (“trip hop”, “downtempo” o “chill out”, si usava distinguere in quei giorni), piuttosto una situazione: la decompressione dopo un rave o una nottata in un club, ossia ciò in cui poi si è specializzato, facendo fortuna, la primula rossa Burial. Ecco, Kruder & Dorfmeister si muovevano in quel solco con eleganza sublime e noncurante, insaporendo la ricetta mediante farina del proprio sacco: essenzialmente uno svagato gusto esotico e un esasperato languore dopato da massicce dosi di THC.
Fatto sta che diventarono delle star, o appena poco meno: ricordo un DJ set al Castello Visconteo di Pavia nell’estate del 2000, di fronte a tremila persone, in un’atmosfera incantevole. E tuttavia, a dispetto del successo, rimasero appartati: si concessero il lusso di rispedire al mittente richieste di remix da parte di giganti quali Bowie e U2, dedicandosi in compenso ai progetti individuali – Peace Orchestra (Kruder) e Tosca (Dorfmeister) – con alterne fortune, mentre di un “vero” album si favoleggiò a lungo, senza che la pietra filosofale si materializzasse.
Difficile stabilire se avessero deciso di vivere di rendita o stessero coltivando una sorta di purezza. E perché mai adesso, varcata la soglia anagrafica dei 50 anni, hanno cambiato idea e mettono in commercio gli scampoli tenuti nascosti nel cassetto? Certo è che fa uno strano effetto ascoltare questi 15 episodi raggruppati in una settantina di minuti: tipo distorsione spazio-temporale. Ma è come sentirsi di nuovo a casa: quei ritmi pigri, le profonde vibrazioni dub, gli arrangiamenti vaporosi, uno sfumato aroma latino, le voci captate chissà dove e rese in forma di ectoplasmi, una sensazione subliminale di jazz. Ad esempio “Johnson”, che apre la sequenza, oppure “King Size”, con andamento indolente da bossa nova e improvvisi guizzi di tromba.
Tutto ciò è diventato irrimediabilmente vintage, ormai, eppure esercita ancora un fascino ammaliante: gli anglofoni lo chiamerebbero guilty pleasure.