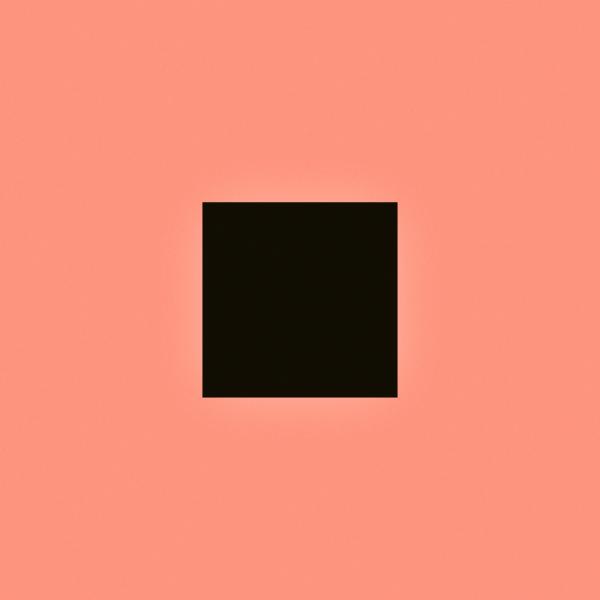L'insopportabile leggerezza di Tame Impala
The Slow Rush mette in vetrina la pochezza di Kevin Parker (alias Tame Impala), divo australiano da hit parade

Non c’è oggigiorno “gruppo rock” più di moda dei Tame Impala. Peccato che i vocaboli siano inappropriati. Davvero poco “rock”: attributo derivante forse dalle esibizioni dal vivo, in particolare durante festival da Premier League quali – lo scorso anno – il californiano Coachella e il Primavera Sound di Barcellona. E poi “gruppo” non è, trattandosi di un progetto individuale del trentaquattrenne tuttofare australiano Kevin Parker, che solo quando si tratta di portare la sua musica in concerto chiama accanto a sé gli strumentisti necessari alla bisogna.
Servirà se non altro a smascherare definitivamente l’equivoco il nuovo album, quarto in una serie avviata nel 2010 da Innerspeaker e decollata con il seguente Lonerism (2012), distante quasi un quinquennio dal precedente e celebratissimo Currents. Chi la sa lunga a proposito di music biz, ossia “Billboard”, dedicandogli la copertina del numero di febbraio, ha decretato nell’intestazione: «La prossima arma segreta del pop».
Che The Slow Rush sia destinato a trionfi commerciali, non v’è dubbio alcuno: Tame Impala ha fama globale, è in grado di affollare grandi arene (ad esempio il Madison Square Garden a New York per due sere di fila, appena sei mesi fa) e vanta estimatori di altissimo bordo, da Kanye West a Lady Gaga. Ogni tassello sta al posto giusto, insomma. Parker è ovviamente compiaciuto, tanto che qui canta nell’episodio d’apertura, “One More Year”: «Ciò che una volta facevamo per capriccio è diventato piano piano la norma». Voce filtrata elettronicamente, groove ascendente ed effetti psichedelici: suona insieme modernissimo e antiquato, mollemente sospeso nell’iperspazio («Ricordi che un anno fa stavamo qui, le nostre menti correvano e il tempo passava lento, e se nel mondo c’erano problemi non ne eravamo consapevoli, e se mai lo fossimo stati non lo dimostravamo»), ricordando i Daft Punk di “One More Time” senza averne però verve e humour.
La sua ossessione attuale sembra sia lo scorrere del tempo, visto che in chiusura arriva “One More Hour”: «L’ho fatto per amore (tutto ciò che ho), l’ho fatto per divertimento (un’ora ancora), non mi basta mai (tutto ciò che ho), l’ho fatto per la gloria (un’ora ancora), ma mai per il denaro», ci rassicura, preparandosi a un epico crescendo in chiave “prog”, formalmente affine all’ampollosità barocca del francese Anthony Gonzalez, alias M83. E sempre su scala cronologica, ecco muoversi “It Might Be Time”, in cui il “mansueto impala” si concede addirittura il vezzo dell’asteismo («Non sei più giovane com’eri, è il momento di rendersene conto, non sei figo com’eri di solito») ondeggiando fra Supertramp e Hall & Oates.
Che abbia a cuore certe lustre levigatezze pop datate anni Ottanta è confermato – già nel titolo – da “Lost in Yesterday”, simile alle canzoncine che Beck confeziona quand’è a corto d’ispirazione.
Di che pasta sia fatto il giovanotto è dimostrazione eloquente “Posthumous Forgiveness”, scritta in memoria del padre, con il quale – spiegano i biografi – ha avuto un rapporto complicato: «Vorrei dirti della volta in cui ero in Abbey Road, o del tempo passato al telefono con Mick Jagger», intona con indisponenza da divo su languida cadenza R&B modello The Weeknd.
Congratulazioni per il successo, dunque, ma la leggerezza di The Slow Rush è francamente insostenibile.