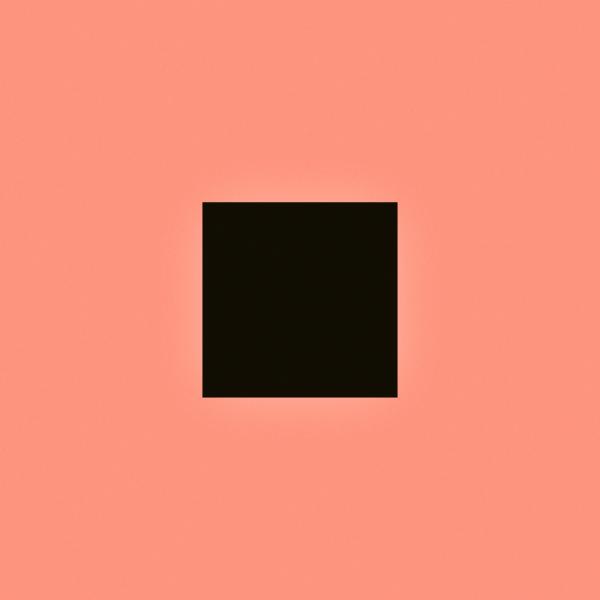Il suono grosso del Muro del Canto
L'amore mio non more è il quarto disco per il gruppo romano, un folk rock possente e profondo

Un serpente, un pettirosso, un orologio antico da panciotto che segna l'una meno dieci. Se è giorno è quasi presto per pranzare, a Roma. Se è la notte appena sboccata nel giorno che segue è spazio aperto per la pulsazione della città. Minaccia o gratificazione, non è dato saperlo. Il pettirosso potrebbe essere indizio di capacità di resistenza. Contro tutto e contro tutti, come De André cantava: un “pettirosso da combattimento”. Il serpente un male antico che avvolge nelle spire la città eterna e la stritola in cerchi suadenti e mefitici.
Ecco la cover del nuovo disco del Muro del Canto, il quarto, parecchio atteso da chi crede che le storie delle canzoni che hanno senso non finiscano mai: cambiano e si adattano, trovano nuove nicchie abitabili, non promettono nulla e poi, a saperle ascoltare, ti trovi lì che batti il piede e ti viene l’impulso di imparartele a memoria, certe strofe. Il Muro del Canto è cresciuto, e bene. Un nuovo livello di consapevolezza sui propri (notevoli) mezzi sembra essere attrezzatura comoda per Daniele Coccia Paifelman, voce amara, grande e grossa del gruppo, e autore di testi che qualche unghiata nell'anima sanno ancora imprimerla.
Il Muro del Canto, lo sappiamo, ha un suono gonfio, pieno, mai retorico: esattamente come la voce di Coccia. Molto western e morriconiano. E con qualche novità di rilievo, che non stravolge ma neppure lascia intatta tutta la grana del suono. Che è, come da nome di gruppo, un “muro” di “canto”. E dunque dev'essere spesso, possente, e lasciar spazio a una declinazione vocale che lasci tracce melodiche di rilievo. Sembra un suono riempito con tutti quegli espedienti popolari che servono per gonfiarti la pancia quando hai poca sostanza e troppa fame. E alla fine la sostanza c'è, anche se è di (magnifica) risulta, come lo scavo di un cantiere. E allora qui ecco i monologhi amari e disperati di Alessandro Piervanti, voce narrante e batteria, e alcune “prime volte” di rilievo: due testi in italiano, e "Al tempo del sole", che introduce ritmiche in levare, La vita è una, infettata da uno ska che cede il passo a un quattro quarti furioso, e gli echi mariachi di "Senza 'na stella", che racconta la stanchezza di una donna.
Il resto è quel folk rock possente e filante che acchiappa nella sua corrente anche l'agrodolce: vedi ad esempio alla voce "L'amore mio non more", che così narra: “Er male che m'hai fatto nun è gniente / no m'è sembrato poi così speciale/ er bene resta a me è robba mia/ e lascia lavorà la fantasia”. È poi raccattare da una moto in corsa sulle buche il fantasma di Lando Fiorini, e torcere un tre quarti in furibondo quattro. E poi la voce grande come quella di Coccia e speculare dell’ospite Lavinia Mancusi, e molto altro. Che gran disco.