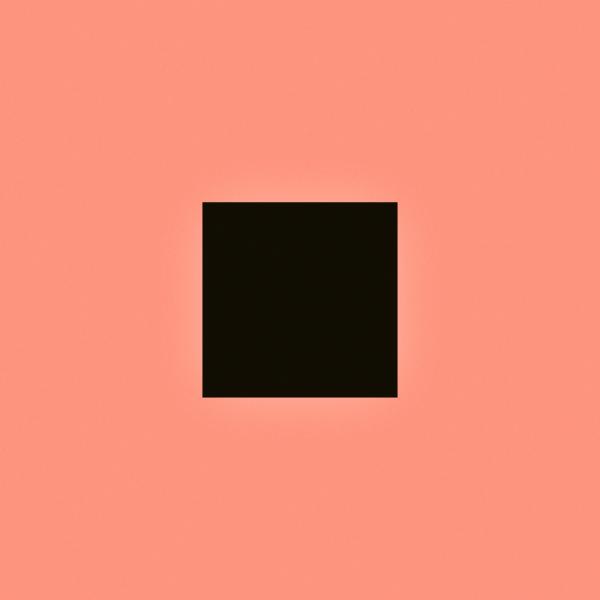Sufjan Stevens: fede, speranza, malattia
Con il nuovo album Javelin Sufjan Stevens torna alla forma canzone, a otto anni da Carrie and Lowell

Sufjan Stevens, dove eravamo rimasti?
La produzione di quello che è ormai indiscutibilmente uno dei cantautori americani più importanti della sua generazione (è nato nel 1975) è sempre stata bulimica, e spesso ha messo alla prova anche i fan più duri e puri, quelli che non si fanno domande.
– Leggi anche: L'ascensione di Sufjan Stevens
Stevens era partito con una sequenza di album di songwriting cristallino di quelle che vale una carriera: dall’esordio del 2000 di A Sun Came attraverso, soprattutto, Michigan (che ha compiuto da poco vent’anni), Illinois (2005) con in mezzo Seven Swans, un certo numero di canzoni natalizie e gli outtakes di The Avalanche (2006) che, quando si tratta di Sufjan Stevens, spesso valgono quanto le canzoni “ufficiali” (in effetti, credo che The Avalanche sia uno dei suoi album migliori).
Si era poi in parte disperso in una serie di progetti strumentali intriganti ma non sempre a fuoco: quasi lo sfogo per una creatività evidentemente totale, debordante, impossibile da rinchiudere negli angusti limiti di una traccia di tre minuti.
Il ritorno alla forma-canzone di The Avalanche (2010) aveva convinto a metà: all’epoca quell’album – che ricordo di aver atteso con ansia, e recensito tiepidamente – sembrava aprire la fase della inevitabile maturità di un talento giovanile ormai over 35. Poi, nel 2015, era arrivato Carrie and Lowell: era quella l’opera struggente di un formidabile genio che stavamo tutti aspettando. Un concept acustico, di arpeggi e sporcature elettroniche, che ruotava intorno a una personalissima e dolorosa saga familiare. La consacrazione di una carriera.
Gli anni successivi, ancora, erano andati avanti fra alti e bassi: musica per il teatro, musica per il cinema, musica ambient. Un disco di esercizi di stile cointestato con il cantautore Angelo De Augustine, in cui ogni brano era ispirato a un film, alcuni decisamente improbabili. Tanta musica davvero, forse troppa da metabolizzare per i ritmi di ascolto contemporaneo (con la punta dei 150 minuti strumentali in cinque parti di Convocations, elaborazione del lutto per la morte del padre).
C’era dunque attesa per questo Javelin, primo disco solista di canzoni da The Ascension – comunque spalmato su 80 minuti – e primo vero album “da cantautore” da Carrie and Lowell. Per l’occasione Stevens non solo si è allineato a un minutaggio umano (appena 42 minuti) ma è tornato – come ai buoni vecchi tempi – a fare tutto da solo: salvo un paio di chitarre registrate dal prezzemolino dell’alt-pop americano Bryce Dessner in un brano, e un po’ di angelici cori femminili, il resto è tutto farina del suo sacco.
E si sente. Gli amanti di Sufjan Stevens ritroveranno in Javelin tutto il suo repertorio più usuale: gli arpeggi di chitarrini che si incastrano l’uno nell’altro, i fiati eccentrici, la voce supercompressa, le lunghe code elettronico-ambient con i pezzi che poco a poco si sfrangiano. Javelin sembra in sostanza essere l’album della sintesi, della consapevolezza di sé: non ha l’urgenza di Carrie and Lowell o la freschezza dei primi episodi, ma neanche l’eccesso e lo sbrodolamento di altri momenti. Non è neanche solo maniera – anche se il sospetto viene, al quinto arpeggio che ti fa dire “Ma questa comincia come…”.
Stevens incarna piuttosto il ruolo del cantautore maturo, che sa come si scrive una bella canzone pop e lo fa. Manca – e anche questo particolare sembra andare in quella direzione – quel name dropping continuo che era una delle cifre distintive della sua scrittura, con le canzoni che erano cataloghi di personaggi, di luoghi, di riferimenti che (immaginavano) personali, non veramente decodificabili da noi che ascoltavamo qui, a migliaia di chilometri da Chicago, dal Wallowa Lake o da Springfield (uno dei pezzi più belli di The Avalanche, da recuperare).
Le canzoni di Javelin scelgono un registro meno idiosincratico. Sono piene di immagini poetiche luminose. Sono canzoni d’amore (“A Running Start”, l’instant classic “Will anybody ever love me?”), canzoni di fede (“Everything that Rises”).
A volte, come già in passato, sono entrambe le cose e non è facile decidersi (“Genuflecting ghost”). Sembrano in fondo brani meno da cantautore, meno personali – almeno per lo standard di Stevens, che ci ha abituato a un tipo di canzone con cuore e budella in mano.
E però, quando si sceglie di scrivere in un certo modo, la vita vera, quella che sta dietro l’io che canta (che è bene ricordarlo è sempre un personaggio, mai una persona) si infiltra nelle canzoni, che lo si voglia o no.
Da sempre molto riservato sulla sua vita privata al netto di quello che sceglie di rielaborare nei suoi brani, Stevens ha rivelato qualche settimana fa di essere nel mezzo di una lunga riabilitazione. Gli è stata infatti diagnosticata la sindrome di Guillain-Barre, una forma di polineuropatia autoimmune che lo ha lasciato in parte paralizzato nelle braccia e nelle gambe. Il suo blog su tumblr (ironicamente intitolato Jar Jar Binks Fan Club, mi piace pensare in omaggio a qualcuno che non riesce a ricordare il nome Sufjan) si è popolato di foto di ospedale e di quadretti di terapia deliziosamente ironici. «Questa esperienza, in realtà, è stata una benedizione. So di essere stato spesso un testimonial del dolore, della perdita e della solitudine, e a volte un misantropo», ha scritto Stevens, parlando della riabilitazione e dei medici che lo seguono. «Ma gli scorsi mesi hanno rinnovato la mia fede nell’umanità».
Successiva alla registrazione dell’album, la malattia e la speranza entrano così nei nostri ascolti di Javelin dalla porta sul retro del nostro cervello, e lì rimangono.
In attesa del prossimo disco, della prossima metabolizzazione pubblica, Javelin si chiude con l’ultima traccia: una cover di Neil Young (“There’s a World”, da Harvest) che suona come la quintessenza di un brano di Sufjan Stevens.
There’s a world you’re living in
No one else has your part
All God’s children in the wind
Take it in and blow real hard.