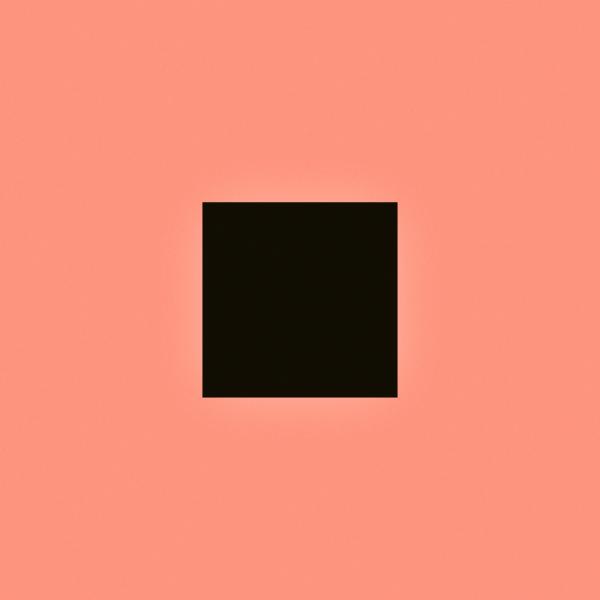L’isola dei Gorillaz
Cracker Island è il nuovo album della band a cartoni animati di Damon Albarn

Concepita ormai 25 anni fa da Damon Albarn in coppia con l’amico fumettista Jamie Hewlett, l’avventura dei Gorillaz si è tramutata nel tempo da divertissement occasionale in vera e propria “carriera”, arrivando addirittura a surclassare in termini di successo globale – e penetrazione in un pubblico anagraficamente più giovane – le imprese dei Blur, i quali del resto stanno per tornare a esibirsi dal vivo.
– Leggi anche: L'invecchiamento dei Gorillaz
A proposito di concerti della band madre, in Cracker Island – ottavo album della serie – ne viene rievocato uno del novembre 1997 a Bangkok: accade in “Baby Queen”, su armonizzazioni di sintetizzatore vintage, raccontando della principessa thailandese – allora quattordicenne – che assisteva allo show seduta su un trono, spinta però a un inopinato stage diving sulle guardie del corpo dall’impeto rock di “Song 2”.
Storia curiosa, vero? Tanto più che svela l’osmosi fra le due sfere, il carne-e-ossa a braccetto con il cartoon, tipo certe ospitate dei Simpsons.
Indizio di quanto il progetto aderisca ultimamente alla personalità del creatore, come già si era notato nel 2018 in The Now Now: quasi un disco da solista del Nostro, benché nascosto dietro il solito avatar 2-D. Sensazione che si prova pure qui in qualche episodio: ad esempio nella canzone dedicata all’“influencer annoiato”, dove nel caratteristico stile vocale – languido, in apparenza svagato e ineffabilmente malinconico – Albarn duetta con Siri, oppure in chiusura nell’elegiaca “Possession Island” (non a caso avanzo di magazzino da The Nearer the Fountain…, lavoro edito a suo nome nel 2021), in cui ha per compagno di spleen Beck.
Ad aprire la sequenza di cammei è viceversa il californiano Thundercat, al basso e al microfono nel brano che introduce la raccolta e le dà titolo: numero di techno pop con allure da Daft Punk.
Eccoci dunque in visita su quest’isola abitata da bianchi villani (cracker ha quel significa nello slang d’oltremanica), “un paradiso posticcio, dove la verità era in Auto-Tune”. Là ha preso forma una setta, suggerisce la trama, e non serve molta immaginazione per intravedere in controluce l’ombra inquietante di QAnon: “Potrebbe essere una camera d’eco dell’alt-right”, ha ammesso infatti l’autore, intervistato dal magazine canadese “Exclaim”.
Nel mirino, di conseguenza, finisce l’abuso bulimico dei canali social, incubatori dell’infezione: “In tendenza su Twitter, è ciò per cui vivono alcuni di noi”, ammonisce in “New Gold” a ritmo di funk il rapper dei Pharcyde Bootie Brown, mentre la melodia sognante del ritornello è affidata all’australiano Kevin Parker, mister Tame Impala.
Nel parterre dei convitati troviamo poi, ai capi opposti, la diva Stevie Nicks, chiamata ad alleviare con levità californiana alla Fleetwood Mac i malumori esistenziali di 2-D (“Ho inserito i miei codici nella macchina, ma ho ricevuto un mondo di sogni guasti”), e il peso massimo portoricano Bad Bunny, che imprime cadenza reggaetón a “Tormenta”. Meno appariscente è la figura del corista Adeleye Omotayo, affiancato al protagonista principale nell’accattivante e confidenziale “Silent Running”.
“È come se avessi navigato in silenzio tra le pagine infinite che ho scarabocchiato, in cerca di un mondo nuovo, in attesa dell’alba”, lo si ascolta cantare durante quel pezzo con un’intonazione autobiografica che conferma il corto circuito in atto fra le varie incarnazioni del suo estro irrequieto.