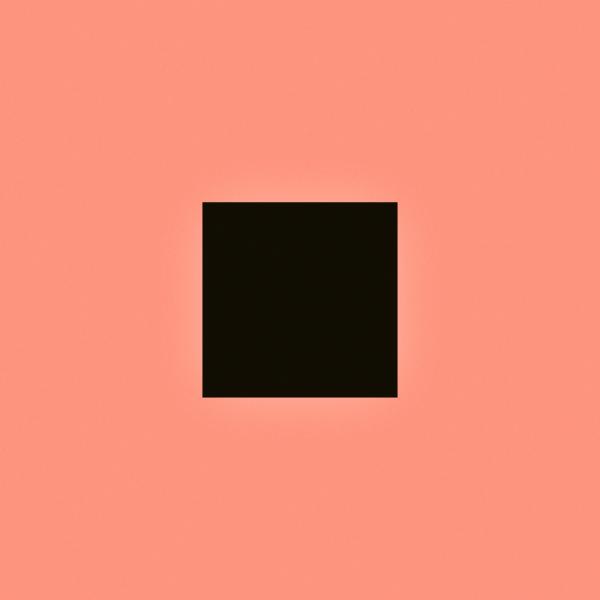La California in chiaroscuro di Jessica Pratt
Here in the Pitch della cantautrice statunitense è un anacronistico gioiellino pop

Scriveva quasi mezzo secolo fa Greil Marcus in Mystery Train: «Non c’è modo di separare la sorridente libertà dei Beach Boys dal coltello di Manson». Affermazione che torna in mente scrutando le premesse a Here in the Pitch, nuovo album della 37enne Jessica Pratt, il cui cammino artistico procede – per sua stessa ammissione – avendo Pet Sounds quale “stella polare”, mentre al capo opposto incombe “il lato oscuro del Sogno Californiano”, esplorato di recente e rappresentato appunto dalla sanguinaria Family dell’“Anticristo hippie”.
Scorrono su quel fondale in mezz’ora scarsa i nove brani del disco, quarto in una serie avviata nel 2012 registrando in cameretta canzoni fatte soltanto di voce e chitarra acustica. Nella circostanza la dotazione strumentale è molto più articolata e include fiati, archi, sezione ritmica, glockenspiel e addirittura un mellotron.
Benché definito dall’autrice “false flag”, l’episodio iniziale – “Life Is” – vale a chiarirne le intenzioni: l’ambientazione dal gusto vintage, tipo i girls group della scuderia Spector, la melodia intonata su un registro fragile, alla Karen Dalton, e un alone di smarrimento esistenziale (“La vita non è mai come pensi che sia e sembra che io non riesca a farla funzionare”) generano un’atmosfera da Mulholland Drive.
C’è dunque qualcosa del manierismo postmoderno di David Lynch fra le pieghe di questo lavoro – precisa il titolo – immerso “nella pece”.
Più di Julee Cruise, chanteuse prediletta dal regista statunitense, sono tuttavia altri i modelli femminili che informano la personalità dell’artista californiana, dichiarata ammiratrice delle donne attirate nell’orbita della Factory di Warhol (“Edie Sedgwick, Candy Darling e ovviamente Nico”) e d’altra parte influenzata – per banali ragioni geografiche – dall’eco persistente della mitologia del Laurel Canyon, evidente in particolare durante “World on a String”, ballata brumosa aperta dalla ferita del tradimento (“Lei ha il mondo in pugno, almeno nel momento in cui arriva qui, ed è durato appena un po’, nient’altro che un luccichio sulla marea”).
Un senso di perdita aleggia anche su “Nowhere It Was”, quando la voce regna sovrana, esasperando la dimensione intimista: “Mi dicono che sai dove le cose sono andate storte e dopo il tuo incantesimo non ho fatto che sognare le tue autostrade”.
Altrove la cifra poetica tende invece all’allegoria: “Antigene, alba astrale e ladri al crepuscolo nella pioggia”, la si ascolta cantare – accompagnata dal pianoforte – con profondità timbriche alla Marianne Faithfull nel mesto paesaggio impressionista di “Empires Never Know”.
Parla d’“innocenza malvagia” poi “By Hook or Crook”, evocativo a parole (“Un gesto affidato alla memoria dell’estate, l’autunno è venuto a cercarlo ed ecco di nuovo la fine dei sogni”) e seducente nello svolgimento dal vago sapore “tropicalista”, garantito dalle percussioni di Mauro Refosco: caratterizzazione che ritroviamo pure in “Get Your Head Out”, zuppo di saudade (“Continuo a tornare a ciò che ho lasciato alle spalle”).
A rischiarare il panorama emotivo giunge, all’epilogo, “The Last Year”: “Credo che andrà bene, penso che saremo insieme e la trama proseguirà all’infinito”, annuncia la protagonista con tono finalmente rasserenato e portamento leggiadro, sostenuta da un arrangiamento essenziale.
All’apparenza piccino, Here in the Pitch è in realtà un gran disco: come una versione stilizzata dello spleen da Ocean Boulevard di Lana Del Rey.