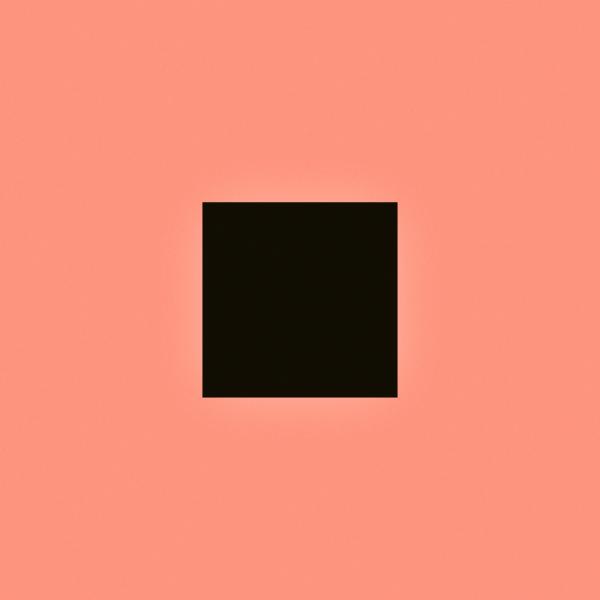Il lungo addio dei Pere Ubu
Ispirandosi a Raymond Chandler, David Thomas ha confezionato un capolavoro che sa di congedo per i Pere Ubu

Nel dicembre 2017 i Pere Ubu dovettero sospendere il tour statunitense a causa dei problemi di salute del fondatore e indiscusso capobanda. Allora la prognosi dei medici pareva infausta, cosicché – mentre affrontava le terapie – David Thomas si mise al lavoro su ciò che immaginava potesse rappresentare il capitolo conclusivo dell’avventura artistica cominciata nel 1975 a Cleveland, tale da rendere leggendario il gruppo devoto all’Ubu Roi creato a fine Ottocento dal “patafisico” francese Alfred Jarry.
«È un riepilogo di tutte le storie e le canzoni proposte in maniere differenti dai Pere Ubu nell’arco di 40 e passa anni».
Esemplare il titolo scelto, The Long Goodbye, mutuato dall’opera omonima di Raymond Chandler, ed esplicita l’intenzione: «È un riepilogo di tutte le storie e le canzoni proposte in maniere differenti dai Pere Ubu nell’arco di 40 e passa anni, pertanto fornisce risposte alle domande formulate da noi stessi durante questo tempo, consegnandole a quella che io considero sia la loro destinazione definitiva», ha scritto l’autore introducendolo. Fonte d’ispirazione dichiarata: la musica pop, ma – ipse dixit – «come dovrebbe essere». La serie è aperta così da “What I Heard on the Pop Radio” con voce nevrotica, riff contagioso e insolente asimmetria.
Incredibile: sembra di tornare al tagliente “avant garage” di “The Modern Dance” e “Non-Alignment Pact”. La band al massimo del suo splendore, dunque: lo ribadisce poco dopo – una volta reso omaggio a “Marlowe” con movenze lunatiche – “Flicking Cigarettes at the Sun”, trainato da un cupo groove post punk e segnato da agghiacciante determinismo («Ieri perseguita tutti i tuoi domani»).
Il suono è marcatamente elettronico, quanto mai in precedenza, poiché Thomas aveva preparato il materiale grezzo in cameretta armeggiando con sintetizzatori, drum machine e aggeggi simili, per espandere quindi gli arrangiamenti in studio con strumentazione eterogenea (troviamo theremin e clarinetto, oltre a chitarra, basso e batteria). Confessa al principio di “Who Stole the Signpost?” a chi possa essersi riferito per dargli forma: «Sono venuto qui in cerca di Harry Partch», annuncia citando il geniale compositore e inventore californiano cui molto deve persino Tom Waits. E in “Fortunate Son” conferma di aver attinto a piene mani alla scuola dell’hard boiled: «Qualcosa degli anni Quaranta, tipo un romanzo di Jim Thompson», declama quasi fosse un audiolibro da ospedale psichiatrico.
È in fondo un Sogno Americano andato a male, quello che trapela dallo spoken word in atmosfera surrealista “The Road Ahead”: l’episodio più esteso, prossimo alla soglia dei dieci minuti.
Chiudono il programma “Skidrow-on-Sea” e “Lovely Day”: l’uno spettrale e inquietante, l’altro a suo modo solenne nell’incedere scandito dallo spleen desolato della fisarmonica.
Al disco principale si aggiunge un bonus registrato dal vivo lo scorso dicembre a Montreuil, nei dintorni di Parigi, dove alla decina di brani di The Long Goodbye – eseguiti in sequenza – se ne sommano quattro supplementari, tra i quali il classico d’inizio carriera “Heart of Darkness” e una versione di “Running Dry” di Neil Young.
La formazione – un quartetto in cui figura l’ex Henry Cow Chris Cutler alla batteria – è la medesima attesa a metà novembre in Italia. Sarà l’ultima tournée? È questo l’album dell’addio? Chissà… Nell’incertezza conviene godersi entrambe le cose: si tratterebbe di un congedo in grande stile.