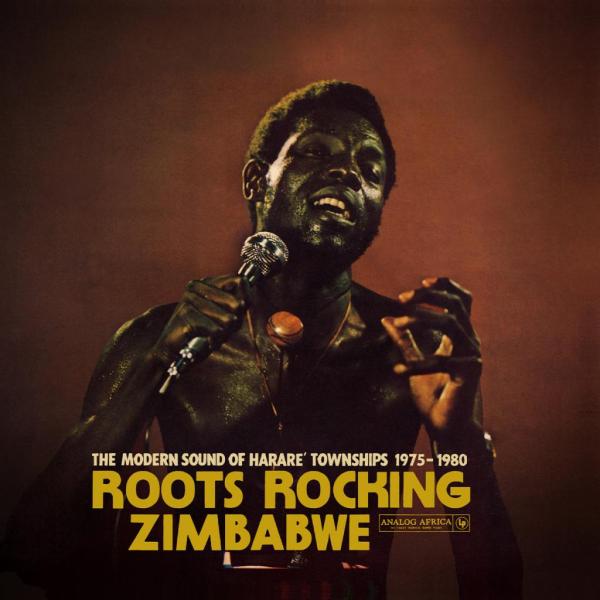Il ritorno di Oumou Sangaré
Un disco politico della diva del Mali, dopo otto anni di silenzio

Armonizzare tradizione e modernità è un esercizio complicato: il rischio di combinare pasticci si nasconde dietro l’angolo. Va ammirato dunque il modo nel quale l’ha affrontato Oumou Sangaré: personaggio leggendario in Mali per più di una ragione. Divenuta cantante per necessità (dovendo sostenere la madre, cantante anch’ella, abbandonata dal marito con quattro figli a carico), appena ventenne già era un caso, esportato poi con successo oltre i confini del continente dall’etichetta londinese World Circuit, su consiglio del “guru” Ali Farka Touré, grazie agli album Ko Sira (1993) e Worotan (1996).
E ciò per mezzo di canzoni dal fiero temperamento femminista, in cui poligamia e infibulazione diventavano barriere da abbattere sulla strada dell’emancipazione. Non fosse bastato, si è tramutata in imprenditrice, aprendo un hotel, lanciando un modello di automobile e avviando un’azienda agricola.
Questo il motivo di un silenzio discografico durato otto anni: tanti ne sono trascorsi da Seya al lavoro edito in questi giorni dall’indipendente parigina No Format. Francese è anche il trio musicale A.l.b.e.r.t. che l’ha affiancata nelle sedute di registrazione, in parte organizzate a Stoccolma con il produttore locale Andreas Unge: le sfumature “occidentali” del suono arrivano di là, ma sono amalgamate in maniera equilibrata con la strumentazione africana. Esemplare in quel senso è “Kamelemba” (che esorta le ragazze a cautelarsi dalle maternità precoci), brano dove lo ngoni dialoga con naturalezza insieme alla chitarra elettrica e al sintetizzatore.
Altrove, in “Yera Faga” (scritta pensando alla piaga dei suicidi) e nell’incalzante “Fadjamou”, complice la presenza alla batteria dello statuario Tony Allen, si percepisce nitidamente l’eco dell’afrobeat.
Il dosaggio degli ingredienti è quasi ovunque impeccabile, cosicché gli accenti acustici dell’ammaliante episodio che conclude e intesta il disco possono convivere senza attrito con lo slancio afro pop di “Djoukourou”. Radicato nell’esperienza familiare (“Minata Waraba” è dedicato alla figura materna, simboleggiata nel titolo dal vocabolo “leonessa”) e consapevolmente attento alla difficile condizione del proprio paese (“Miali Niale” invoca la riconciliazione nazionale), Mogoya – espressione in lingua bambara traducibile come “la gente oggi”, in termini di relazioni umane – è un album al tempo stesso denso di contenuto e lieve nella forma. Un nitido ritratto dell’autrice, insomma.