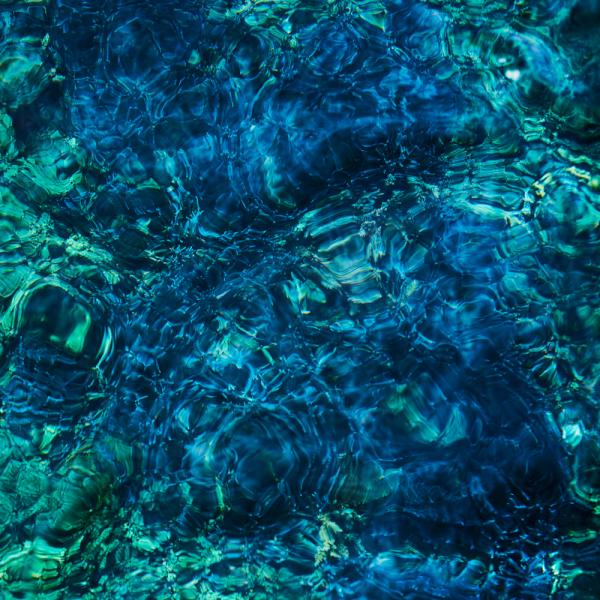Nel tunnel dell’amore con Lana Del Rey
Spleen e glamour in osmosi in Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, nuovo album di Lana Del Rey

Dieci anni fa Lana Del Rey debuttava in Italia con tre concerti, primo dei quali al Palaolimpico di Torino, in verità semivuoto: ci andai accompagnato da madame Curiosità e monsieur Pregiudizio, attirato da quella cantante giovane e conturbante, ma diffidente per la nuvola di hype che ne stava accompagnando l’ascesa, dal botto di “Video Games” su YouTube all’immediato rendimento da best seller di Born to Die, il suo album d’esordio.
Ora, otto dischi dopo, ne contemplo l’evoluzione da femme fatale in stile vintage (disse allora David Lynch: «Ha un carisma fantastico, sembra nata in un’altra epoca») al rango di «una delle cantautrici più influenti del XXI secolo», secondo “Variety”.
Strada facendo è divenuta fonte d’ispirazione per artiste della generazione seguente: ad esempio Billie Eilish, con cui dialoga nell’ultimo numero di “Interview”, rivelando che il nuovo lavoro «in larga misura riguarda i miei pensieri più intimi».
Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd è quasi un affare di famiglia, addirittura: in “Fishtail” l’interlocutrice è la sorella minore Caroline Grant, detta “Chuck”, nel corso di “Fingertips” affiora in maniera poco edificante la figura materna (“Che razza di madre era per dire che avrei dovuto essere rinchiusa?”), poi c’è l’eloquente “Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing”, mentre ad aprire la serie è un brano intestato al patronimico anagrafico, “The Grants”, dove compaiono “il primogenito di mia sorella” e “l’ultimo sorriso di mia nonna”, dopo una falsa partenza in modalità gospel e il dolente sviluppo sottolineato da un avvolgente crescendo d’archi.
In sequenza arriva quindi l’episodio che dà titolo all’opera, elevando a metafora il tunnel – ormai inaccessibile – che dal Jergins Trust Building conduce all’arenile di Long Beach. Qui la protagonista si mette in mostra con pathos malinconico alternando impudenza (“Aprimi, dimmi che ti piace, scopami fino a morire, amami finché non amerò me stessa”) e fragilità (“C’è una canzone di Harry Nilsson dove la sua voce si spezza al minuto 2’ 05”, qualcosa nel modo in cui dice ‘Non dimenticarmi’ mi fa sentire come se non volessi altro che avere un amico come lui, qualcuno che mi dia il cinque”).
Fra quelle polarità ondeggia la sua identità, un’osmosi decadente di spleen e glamour: elementi costitutivi della dialettica che regge il mondo da lei costruito e nel quale abita, confrontandosi con ciò che ha intorno e interrogandosi sulla condizione femminile ai giorni nostri («Nel femminismo ci dev’essere un posto per le donne con il mio aspetto e il mio comportamento. Il tipo di donna che dice No, ma gli uomini sentono Sì, il tipo di donna che viene criticata senza pietà per essere autentica e sensibile, il tipo di donna a cui donne più forti o uomini che odiano le donne rubano le storie e la voce», scriveva nel maggio 2020 su Instagram).
E all’età di 37 anni si confronta con l’assillo della maternità (“Il pupo starà bene? Ne avrò uno mio? E se lo avessi, saprei gestirlo?”, in “Fingertips”) e sulle relazioni che potrebbero generarla (“Vuoi dei figli? Mi vuoi sposare? Vuoi correre la maratona sul lungomare di Long Beach? Se vuoi una puttana qualsiasi, vai al Beverly Center e cercatela”, canta in “Sweet”).
Ma il pezzo chiave, una sorta di bignami autobiografico, è “A&W”, ossia “American” e “Whore”: “Lo chiamo: ‘Vieni nella mia camera da letto’. Finisce che scopiamo sul pavimento dell’hotel. Non si tratta di avere qualcuno che mi ami più di tanto. Ecco cosa significa essere una Puttana Americana”.
La natura musicale di quella canzone, che nasce folk per prendere in seguito una piega elettronica fra trip hop e R&B, descrive il profilo discontinuo di un album – parola sua – “verboso”, articolato in 16 tracce per un’abbondante ora e un quarto di durata.
L’assortimento è vario: ci sono due interludi (uno consacrato al controverso predicatore di Seattle Judah Smith), un vezzo autoreferenziale (l’epica “Venice Bitch” da Norman Fucking Rockwell rielaborata in coda a “Taco Truck x VB”), qualche caduta di tono (il rap svogliato sul jet set californiano di “Peppers”: “Sballarsi, calare acidi, non morire mai”), citazioni per Wim Wenders (“Paris, Texas”, gioiellino con limpida voce da contralto su cadenza di valzer) e Leonard Cohen (“Kintsugi” riprende un verso da “Anthem”: “Ecco come entra la luce”) e cammei più (Father John Misty nel country idilliaco di “Let the Light in”) o meno (i Bleachers del produttore di fiducia Jack Antonoff in “Margaret”) azzeccati.
Eppure l’effetto d’insieme è ammaliante: senza dubbio superiore all’ambiziosa doppietta costituita da Chemtrails over the Country Club e Blue Banisters, usciti a sette mesi di distanza nel 2021, dopo che nel 2020 aveva pubblicato la prima raccolta di poesie Violent Bent Backwards over the Grass (anche su disco spoken word).
Lana Del Rey ha scelto di esporsi qui più di quanto abbia fatto mai in passato, offrendo così un veritiero ritratto da diva problematica: “Non sono così intelligente, ma ho cose da dire” (“Fishtail”), “So che mi odiate” (“Taco Truck x VB”), “Sono una principessa, sono divisiva, chiedimi perché sono così” (“A&W”).