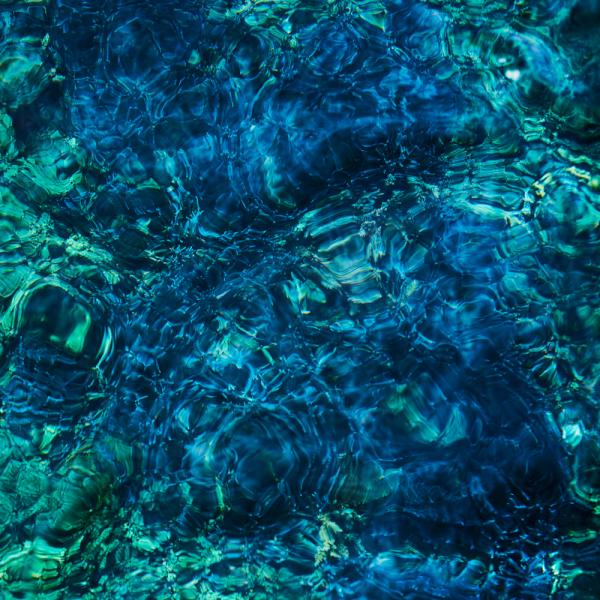Fleet Foxes da spiaggia
Nel nuovo disco Shore Robin Pecknold distilla bellezza in assenza di gravità nel nome dei Fleet Foxes

Ricordo tuttora con nitidezza quando li vidi esibirsi dal vivo nel novembre 2011 a Milano, sul palco dello Smeraldo, teatro smantellato pochi mesi dopo per fare spazio a Eataly: i Fleet Foxes erano meravigliosamente naïf nel modo in cui mettevano in scena il materiale dei primi due album. Nel 2017, invece, interrompendo un lungo silenzio, il successivo Crack-Up rappresentò una sorta di perdita dell’innocenza, simboleggiata da maggiori ambizioni formali e arrangiamenti ampollosi. Ed ecco adesso, come fulmine a ciel sereno, il quarto atto, Shore: pubblicato allo scoccare dell’equinozio d’autunno in versione digitale, posticipando a inizio febbraio l’oggetto discografico. In un minuzioso testo introduttivo, Robin Pecknold – da sempre autore esclusivo delle canzoni marchiate Fleet Foxes, ma in questo caso anche unico membro del quintetto coinvolto nella realizzazione dell’opera – ne racconta la gestazione resa travagliata da «preoccupazione e ansia», dissoltesi però nell’urgenza del momento, determinata dalla pandemia e dai conflitti che scuotono gli Stati Uniti. «Possa l’ultimo lungo anno essere perdonato», recita a un certo punto “Featherweight”: prezioso esercizio folk dal sapore antico.
Si tratta di uno degli apici nella sequenza di 15 episodi che si estende per 54 minuti abbondanti, corredata da un film in 16 millimetri realizzato ad hoc dalla cineasta Kersti Jan Werdal: road movie d’impronta paesaggistica visibile su www.fleetfoxes.co. La serie è aperta da “Wading in Waist-High Water” in maniera sorprendente: al microfono non compare infatti il protagonista bensì la giovanissima Uwade Akhere, carneade di origine nigeriana che fa poi capolino in altri due pezzi.
L’atmosfera è idilliaca e tale rimane nella seguente “Sunblind”, ballata dal portamento classico ma lieve nella quale Pecknold disegna un Pantheon musicale dove brillano le sue stelle polari: Richard Swift e David Berman, Judee Sill ed Elliott Smith, Arthur Russell e John Prine, “angeli perfetti nella neve”.
Duo di loro – Berman e Prine – riappaiono inoltre nel brano che dà titolo al disco e lo conclude su un registro di quieta malinconia: “Spaventato dal vuoto, eppure al sicuro sulla spiaggia”.
Quel luogo, esposto agli umori alterni delle maree e tuttavia accogliente con la sua malleabile consistenza sabbiosa, raffigura il senso espressivo dell’album, che – spiega ancora l’artefice – “intende celebrare la vita a dispetto della morte” e “offrire sollievo”. Anziché avvalersi degli abituali compagni d’avventura, con cui promette comunque d’impegnarsi a breve in un’impresa complementare a questa, il trentaquattrenne di Seattle si è circondato di un’ampia platea di collaboratori, fra i quali David Rossen (Grizzly Bear), il quartetto di fiati Westerlies (in evidenza nella dimensione cameristica di “Thymia” e nello sviluppo di scuola minimalista di “Cradling Mother, Cradling Woman”, che per incipit ha un campionamento della voce di Brian Wilson captata durante la lavorazione di Pet Sounds) e Aaron Dessner (The National), che l’ha ospitato nel suo studio Long Pond: uno dei quattro in cui si sono svolte le sedute di registrazione, fra New York, Parigi e Los Angeles. In precedenza Pecknold aveva trascorso un mese a scrivere in Portogallo (l’eco dell’esperienza è racchiusa in alcuni versi di “Going-to-the-Sun Road”, interpretati nella lingua del posto dal brasiliano Tim Bernardes), affacciandosi in Spagna (“Maestranza” allude all’omonima arena da corrida di Siviglia) e volgendo infine lo sguardo in direzione del Cile (“Jara” è in onore del cantautore assassinato dai fascisti di Pinochet: “Ora segui Victor nella sua scala verso il cielo”). Shore ostenta dunque densità di argomenti da età adulta, benché riproponga l’immediatezza cristallina degli esordi (si ascolti “Can I Believe You”) senza rinunciare d’altra parte alle complessità esplorate la volta scorsa, qui però ridimensionate e messe al servizio di un’attitudine all’empatia.
Un equilibrio ammirevole, esemplificato dal leggiadro andamento ascendente di “Quiet Air/Gioia”: scorcio di bellezza in assenza di gravità.