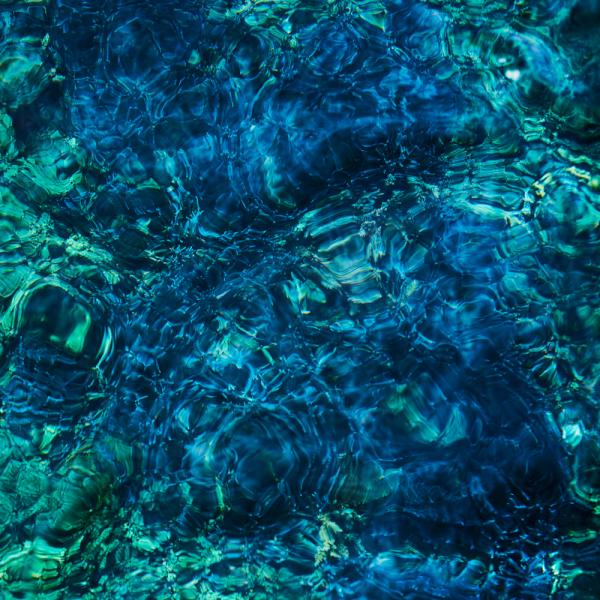Phoebe Bridgers, cantautrice millennial
Il talento di Phoebe Bridgers sboccia nel nuovo Punisher, che aggiorna i singer-songwriters americani all'epoca dei social

Nei giorni immediatamente precedenti l’uscita dal nuovo disco del Maestro, annunciato dalle avvisaglie come capolavoro, risaltava il titolo di un’intervista pubblicata su “The Guardian”, ricavato da una frase della protagonista: «A 12 o 13 anni ero tipo: "Wow, sarò il prossimo Bob Dylan!"». Parola di Phoebe Bridgers, venticinquenne cantautrice californiana (pre)destinata al successo.
Nonostante la giovane età, Phoebe Bridgers ha un curriculum vitae denso di avvenimenti: nel 2014 al centro di uno spot dell’iPhone con la sua band di allora, Sloppy Jane, impegnata a rifare “Gigantic” dei Pixies, con cui finanziò i provini che accesero l’interesse di Ryan Adams, autocandidatosi al ruolo di mentore, salvo abusare poi di lei (caso denunciato clamorosamente nel febbraio 2019 sul “New York Times”). Dopo di che – superando il trauma – Bridgers realizzò il proprio album d’esordio, Stranger in the Alps, edito nel 2017, nel quale metteva in mostra una limpida grafia musicale associata a uno stile poetico tagliente ed essenziale, che i commentatori accostarono al folk “emotivo” del compianto Elliott Smith, da lei indicato per altro fra le principali fonti d’ispirazione al pari della Joni Mitchell epoca Laurel Canyon. Ed ecco quindi le divagazioni con il trio femminile Boygenius, accanto a Julien Baker e Lucy Dacus, e in duo con Conor Oberst (Bright Eyes) sotto l’intestazione Better Oblivion Community Center.
Artisti che ritroviamo al suo fianco nel secondo lavoro Punisher, all’ascolto assai più ambizioso del predecessore: registrato negli studi Sound City, da mezzo secolo mecca della produzione discografica dove fra i tantissimi hanno preso forma classici del rango di After The Gold Rush e Nevermind. Se lo spleen country di quel Neil Young sembra riecheggiare qui fra banjo e violino in “Graceland Too” (riferito in verità a Elvis: “ribelle senza scopo” che “credeva che le canzoni potessero avverarsi”), all’estro ispido ma vulnerabile di Kurt Cobain potrebbe appartenere il brano che chiude la sequenza, “I Know the End”, in cui – su un’epica costruzione orchestrale in crescendo, culminante nel caotico finale quasi rumorista – scorrono immagini di un’apocalisse incombente: un tornado, suoni di sirena, droni del governo, astronavi aliene e un cartellone con la scritta “La fine è vicina”.
– Leggi anche: Fiona Apple: Capolavoro? Anche no…
Non paia fuori luogo evocare arcani maggiori di simile portata: il talento di Phoebe Bridgers è davvero cristallino, dunque nitido e aguzzo. Prendiamo ad esempio l’episodio dalle attrattive pop più marcate: dietro apparenze deliziose da canzoncina indie rock, “Kyoto” espone il quadro di un fallimento sentimentale (“Volevo vedere il mondo attraverso i tuoi occhi, poi è successo e ho cambiato idea”) e le rabbiose conseguenze (“Ti ucciderò, non ti perdono”).
Esercitano fascino in maniera analoga gli altri due pezzi incaricati di aprire la strada all’album, descrivendo situazioni opposte: “Garden Song”, con morbido fingerpicking e voce di seta (che afferma con orgoglio: “Ho tutto quello che volevo”), e “I See You” (ancora sulla catastrofe amorosa: “Non so ciò che voglio finché non lo mando a puttane”).
Apice dell’opera è tuttavia “Chinese Satellite”, ballata che nasce brumosa e fiorisce cammin facendo, addentrandosi nella disillusione: “Ho fatto un giro fuori per vedere le stelle, ma stanotte non c’erano, così ho vagheggiato un satellite cinese, volevo credere e invece guardavo il cielo senza sentire nulla”. Se canzone d’autore dev’essere, partendo dall’archetipo dylaniano, si tratta della versione “millennial”, allineata pertanto all’era di internet – non a caso l’autrice è una vivace presenza su Twitter e Instagram – e posizionata sul piano espressivo al crocevia fra Billie Eilish e Fiona Apple. E anche oltre, siccome in “Halloween” canta: “Possiamo essere qualsiasi cosa”