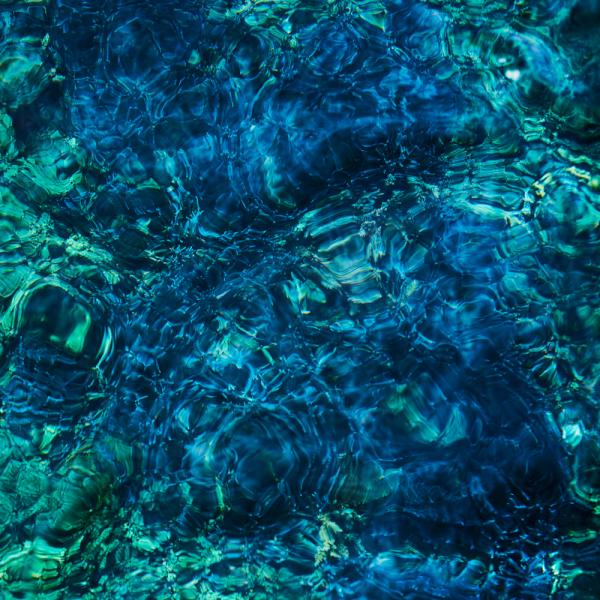Le canzoni a lume di lampada dei Dirty Projectors
Il pop arzigogolato di Dave Longstreth nel nuovo album dei Dirty Projectors, Lamp Lit Prose

Usare la canzone pop come forma su cui applicarsi con metodi d’avanguardia è impresa meritevole di ammirazione, anche se all’ascolto i risultati possono suonare talora indisponenti. Esemplare il caso del laboratorio chiamato Dirty Projectors, del quale è principale – e a volte unico – responsabile il trentaseienne Dave Longstreth.
Dopo un apprendistato punteggiato nella prima metà dello scorso decennio da opere bizzarre (con tributi divergenti all’“aquila” Don Henley, in The Getty Address, e ai radicali punk californiani Black Flag, in Rise Above), l’avventura raggiunse il suo apice – a oggi insuperato – nel 2009 con Bitte Orca: capolavoro asimmetrico che diede lustro – insieme ai lavori concomitanti di Animal Collective e Grizzly Bear – alla “scena di Williamsburg”, ambientata appunto nella porzione di Brooklyn allora epicentro della bohème newyorkese.
Quel disco e il successivo Swing Low Magellan, quasi altrettanto convincente nel modo in cui equilibrava intenzione comunicativa e attitudine sperimentale, erano tuttavia frutto di un’alchimia provvisoria, legata alla partnership sentimentale – oltre che artistica – fra il capobanda e Amber Coffman. Sia chiaro, non è per farsi i fatti altrui: Longstreth stesso ha posto esplicitamente il trauma della separazione al centro del cervellotico album – “Una fantasia cubista”, a suo dire – uscito senza titolo al principio dell’anno passato.
E siamo dunque a Lamp Lit Prose, dove trapela maggiore serenità, dovuta a una nuova relazione amorosa: “Lei è la mia epifania”, dichiara fra spasmi elettronici la voce carezzevole del protagonista in “Break-Thru”, alludendo versi facendo al cinema di Fellini e al Palinsesto di Archimede.
Il tono è quello, in genere: raffinatezze narrative a un passo dal birignao, sfacciati ammiccamenti pop e – all’opposto – dispettose astrusità concettuali negli arrangiamenti. Quando l’artificio non funziona, l’esito indispettisce: “Zombie Conqueror” è una goffa simulazione di metal “mentale” e “I Feel Energy” sembra il sottoprodotto di un David Byrne giù di ispirazione. Altrove la situazione migliora: l’iniziale “Right Now” tramuta un madrigale country in soul avveniristico e “That’s a Lifestyle” – con la sua melodia arzigogolata su arpeggio acustico – fa tornare in mente certi vezzi sofisticati dei Prefab Sprout di Paddy McAloon (anch’egli apprendista stregone nel reame della musica leggera).
Il trittico conclusivo, mostrandosi conciliante, risolleva infine le sorti dell’impresa: “What Is the Time” inocula malinconia in un sobrio groove R&B (e qui la sensazione è di risentire nel falsetto di Longstreth quello del britannico Green Gartside, ossia mister Scritti Politti), “You’re the One” è un’aggraziata polifonia intonata con i compagni di merende Robin Pecknold (Fleet Foxes) e Rostam Batmanglij (Vampire Weekend), mentre “(I Wanna) Feel It All” modula l’epilogo su un registro rarefatto da jazz “progressivo”. Cosicché, per quanto non esattamente affabile, questa “prosa a lume di lampada” restituisce almeno a tratti smalto ai Dirty Projectors.