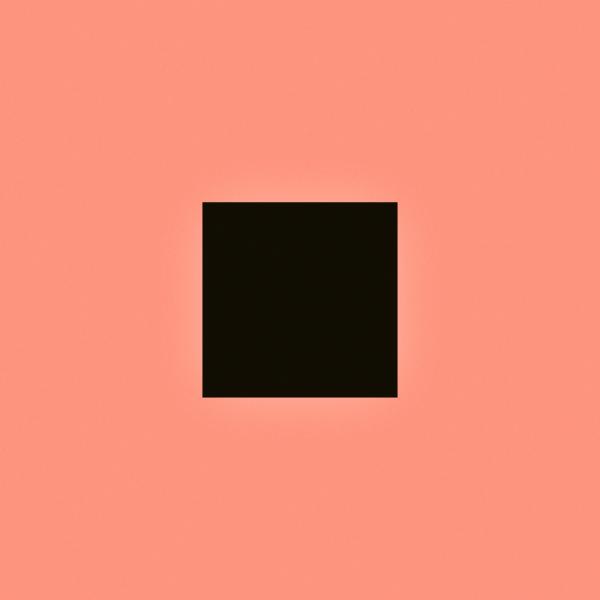Jlin: l’avant-garde del ghetto
Le musiche a forma di origami della produttrice afroamericana Jerrilynn Patton

In ciò che produce la trentenne Jerrilynn Patton – alias Jlin – convergono fattori diversi. Tra questi, l’appartenenza geografica: nativa di Gary, cittadina dell’Indiana edificata a inizio Novecento dall’U.S. Steel Corporation e battezzata con il cognome di chi ne era allora presidente, durante gli anni Cinquanta diede i natali ai fratelli Jackson, ultimo e più celebre di tutti Michael. In epoca recente, la crisi dell’industria siderurgica – dove la stessa Patton era impiegata in giovane età come manovratrice di carrelli – l’ha spopolata, esasperando il malessere sociale (nel 1994 si guadagnò la nomea poco lusinghiera di “capitale americana degli omicidi”).
Un habitat problematico, insomma. Quanto al contesto musicale, invece, essendo prossima a Chicago, distante una quarantina di chilometri, ne ha metabolizzato gli influssi, in particolare l’evoluzione della cosiddetta “ghetto house” in footwork: sorta di techno funk ipercinetico divenuto colonna sonora delle sfide di ballo fra crew rivali, di cui sono stati pionieri RP Boo e lo scomparso Dj Rashad. In quell’alveo, incoraggiata appunto dai due artisti citati, è cresciuta Jlin, che dichiara inoltre ammirazione per Stravinskij (modello La sagra della primavera) e Aphex Twin (con il quale ha fraternizzato via internet). Risultante di tali vettori è una personalità espressiva audace e originalissima.
Già il precedente Dark Energy l’aveva resa visibile nello scenario attuale del suono elettronico, schiudendole vie d’accesso sia al mondo della danza contemporanea (sta collaborando con l’affermato coreografo britannico Wayne McGregor, ad esempio) sia alle passerelle della moda (su invito di alcune “grandi firme”). Un’ascesa vertiginosa, di cui l’album nuovo rappresenta il coronamento. Il titolo descrive in senso metaforico la genesi dell’opera: «Un origami comincia da un semplice foglio di carta, che pieghi e ripieghi, ottenendo cose splendide e complesse: prendere la semplicità e renderla complessa è un pensiero che ho mutuato da Coco Chanel», ha spiegato a “The Guardian”. Del footwork rimane un’eco lontana: Black Origami è un funambolico esercizio di astrattismo, sviluppato in ammirevole equilibrio fra impulsività corporea e arzigogolo avant-garde. Quasi non vi sono tracce di melodia, e quando affiorano (l’arpeggio sintetico nel brano che apre il disco e gli dà nome, oppure le voci di un coro baltico femminile – su imbeccata del newyorkese William Basinski – aleggianti nell’ambient nevrotica di “Holy Child”) mostrano apparenze da ectoplasmi.
Si percepiscono piuttosto riverberi di poliritmie che evocano di volta in volta l’Oriente (“Kyanite”), l’Africa (“Nyakinyua Rise”) e l’America Latina (“Challenge (To Be Continued)”), senza cedere mai alle lusinghe dell’esotismo. E d’altra parte si coglie in controluce una dimensione politica, appena suggerita a parole: “1%” (realizzata insieme alla californiana Holly Herndon) usa una terminologia numerica da Occupy Wall Street, mentre “Hatshepsut” e “Nandi” rendono omaggio a figure femminili dell’antichità (rispettivamente regina egiziana della XVIII dinastia e icona leggendaria nella tradizione Zulu). Un lavoro così denso di contenuto e incalzante all’ascolto da togliere il fiato.