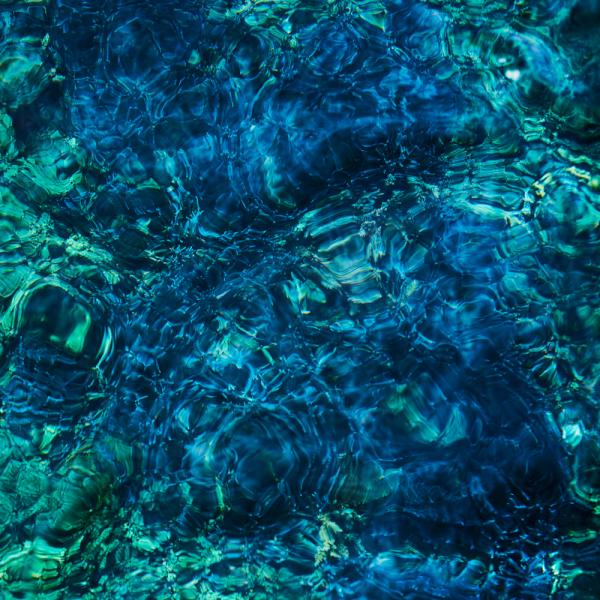Fleet Foxes, un disco a forma di rompicapo
Il ritorno dei Fleet Foxes dopo sei anni di silenzio, tra Francis Scott Fitzgerald e Donald Trump

Sei anni di silenzio: un’eternità sulla scala del metabolismo ipercinetico della musica pop. Tanto è trascorso dal disco precedente dei Fleet Foxes, Helplessness Blues, il cui brano di chiusura – “Grown Ocean” – sembrava incompleto, a tal punto da spingere un fan a ipotizzare che l’accordo mancante, in Fa, avrebbe aperto il nuovo lavoro. E così è stato. Si tratta di un tassello degli innumerevoli impiegati nell’edificare l’architettura quasi enigmistica di Crack-Up, intitolato come un saggio scritto nel 1936 da Francis Scott Fitzgerald per “Esquire” (curiosamente ripubblicato online tre mesi fa): testo nel quale l’autore esamina le contraddizioni e i traumi che comporta il trapasso verso la condizione adulta. Del resto, l’espressione va tradotta in “crollo” o “cedimento”: noi diremmo “esaurimento nervoso”.
Da simili premesse deriva un tracciato narrativo zeppo di riferimenti storici e mitologici della più varia specie: "Cassius,-", dove pure ci si riferisce all’attualità (l’indignazione civile per la violenza della polizia statunitense nei confronti della comunità afroamericana), cita ad esempio il traditore di Cesare, che ricompare in “I Should See Memphis” (ma forse è Cassius Clay/Muhammad Alì, vista la collocazione a Kinshasa), subito prima della rievocazione di Manassas e Appomattox, sedi di storiche battaglie durante la Guerra di Secessione (un passato che rispecchia tensioni del presente marchiato Trump).
E aggiungiamo al fitto intreccio concettuale il molteplice significato di “Third of May/Ōdaigahara”, titolo dell’episodio maggiormente ambizioso – anche solo per la durata: poco meno di nove minuti – dell’intera opera: la data – che incidentalmente designa altresì un celebre dipinto di Goya – allude sia al giorno del 2011 in cui uscì Hopelessness Blues sia al compleanno di Skyler Skjelset, inseparabile partner del capobanda Robin Pecknold, mentre il vocabolo esotico indica un monte del Giappone, nazione che ospitò nel gennaio 2012 gli ultimi concerti dei Fleet Foxes con alla batteria Josh Tillman, poi uscito dal gruppo in modo piuttosto acrimonioso e tramutatosi in cantautore glamour con lo pseudonimo Father John Misty.
Tantissima roba, insomma: persino troppa. E dire che l’avventura delle Volpi di Seattle era cominciata nel segno di canzoni dalla limpidezza naïf, appena un po’ intorbidata in seguito dal “blues dell’inadeguatezza”. Crack-Up, viceversa, oltre alla densità di contenuto fin qui descritta, espone una complessità musicale al limite del rompicapo. Certo, rimangono le alate melodie vocali, in alcuni casi di folgorante bellezza, su tutte quella che affiora in “Fool’s Errand”, sovente troncate inopinatamente, però, o lasciate incompiute.
Alla semplicità degli esordi si sono sovrapposte un’ampollosità negli arrangiamenti che sa di progressive (“Kept Woman”) e un’intenzione sperimentale sconfinante nel free form del jazz (“Mearcstapa”, già creatura mostruosa nel poema epico Beowulf). Così facendo i Fleet Foxes si sono distanziati nettamente dal neo folk da ipermercato degli epigoni Mumford & Sons e Lumineers, ed è una buona notizia. Quel cammino, tuttavia, li ha condotti dentro un labirinto di suoni e suggestioni nel quale per l’ascoltatore diventa difficile orizzontarsi. È ciò a rendere il loro terzo album al tempo stesso grandioso e irrisolto.