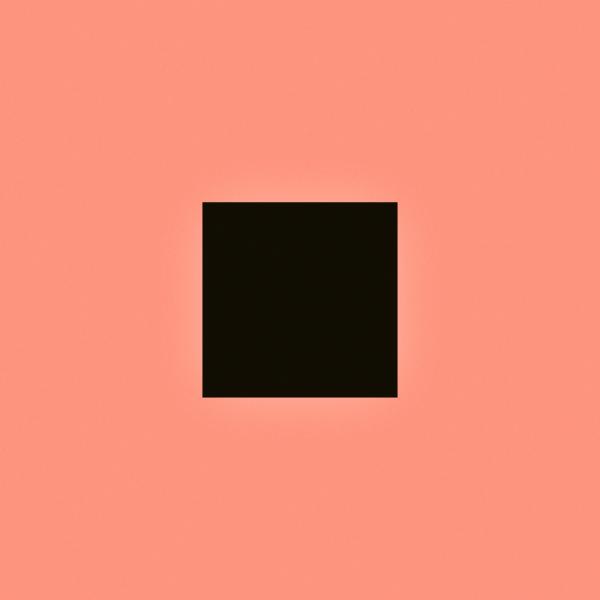Yo La Tengo, la quiete nella tempesta
L’indie rock al tempo dei populismi: There’s a Riot Goin’ On è il nuovo album degli Yo La Tengo, all'insegna della serenità

Dicono che nell’occhio del ciclone regni la quiete. Paradosso meteorologico in qualche modo riprodotto musicalmente dal nuovo disco degli Yo La Tengo, There’s a Riot Goin’ On.
Introducendolo, lo scrittore e saggista newyorkese Luc Sante l’ha definito «un’alternativa alla rabbia e alla disperazione». Sono tempi cupi e minacciosi, si sa, e la “rivolta” menzionata nel titolo ha prerogative opposte a quelle della ribellione cui alludeva – era il 1971 – l’omonimo e leggendario album di Sly & The Family Stone.
Se allora il contesto veniva determinato dal riflusso dei fenomeni che avevano scosso il decennio precedente, ossia l’utopia hippie (a quel punto in frantumi) e l’insurrezione afroamericana (repressa annientando le Black Panthers), ora il quadro degli eventi è disegnato con tratto brusco dall’onda transoceanica dei populismi. Intossicato dalle droghe e ostaggio di una megalomania paranoica, Sly Stone ne ricavò una visione distopica: il diario personale di una crisi collettiva. L’approdo raggiunto in questa circostanza, viceversa, è una forma di serenità all’apparenza inspiegabile. “Scaccia i momenti brutti con una risata, menti su ciò che sta arrivando”, recitano i versi di “Forever” su un’astratta melodia insinuata fra coretti doo wop.
A farsene portavoce sono tre individui poco appariscenti: facce da persone qualsiasi, nome dal sapore nonsense e lunga parabola artistica senza fuochi d’artificio. Esemplari di una normalità insolita nei territori dell’indie rock. In attività da 34 anni, con la stessa formazione da 26, strada facendo gli Yo La Tengo hanno capitalizzato un seguito solido ancorché circoscritto: la tipica band di culto.
E tuttavia There’s a Riot Goin’ On sorprenderà gli appassionati, differente com’è da quanto fatto nei 14 lavori antecedenti. Diversa è stata la procedura, anzitutto: un taglia-e-cuci digitale di registrazioni varie, sia nuove sia datate, realizzato con Pro Tools. E dunque il risultato li ha condotti altrove. Suona come un flusso di coscienza che scorre tra due sponde: una abitata dall’elettronica del “dopo scienza” di Brian Eno e l’altra dal folk narcotico dei Velvet Underground all’epoca del terzo long playing. Nell’arco di 63 minuti e mezzo sfilano 15 episodi, accomunati da un’atmosfera onirica e impressionista, benché dotato ciascuno di vita propria: l’esperimento da Quarto Mondo – ritmica africana, basso dub, narrazione oppiacea – di “Above the Sound” e l’impalpabile pop “exotico” di “Let’s Do It Wrong”, per citarne due particolarmente stravaganti. All’epilogo, in “Here You Are” (speculare allo strumentale iniziale “You Are Here”), cantano: “Siamo fuori dal tempo, credete al peggio”.