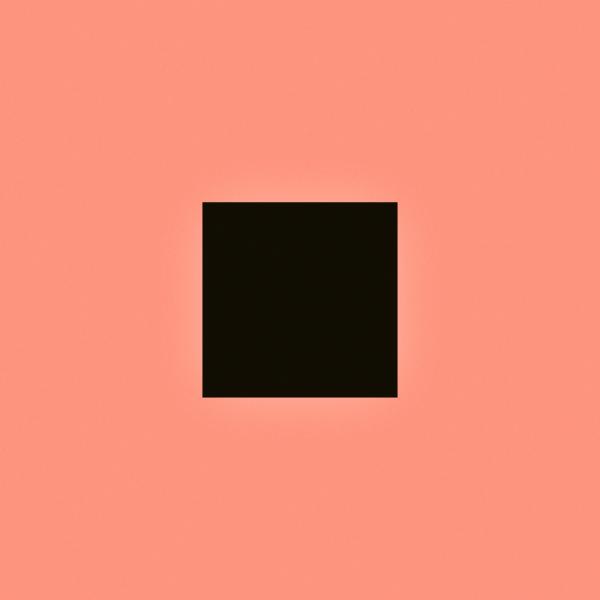Nella Selva di Marta Del Grandi
Il secondo album di Marta Del Grandi, cantautrice italiana da esportazione

Italiana di nascita ma cittadina del mondo, avendo soggiornato in Cina, India, Nepal e Belgio, Marta Del Grandi – avvistata di recente anche nei ranghi dei Casino Royale – è cantautrice sui generis per gli standard nostrani: non a caso ingaggiata dalla fiammeggiante etichetta discografica con base a Londra, già editrice del precedente Until We Fossilize (2021).
Dovendo intitolare il nuovo lavoro, tuttavia, ha scelto un vocabolo in madrelingua: Selva. Evocazione dantesca che lei stessa in qualche modo ammette: «È una parola dalla forte valenza letteraria, un topos, un luogo archetipico, uno scenario per miti e fiabe, dov’è facile perdersi».
Ha però tinte meno fosche di quella in cui ci s’imbatte “nel mezzo del cammin di nostra vita”, presumibilmente per banali ragioni anagrafiche, vista l’età della protagonista, ancora nei suoi trent’anni. Il brano omonimo, unico non anglofono della dozzina inclusa nell’album, ha fattezze da madrigale astratto e ripete con insistenza mantrica la frase: “Sentieri tortuosi s’intrecciano stretti, in forme mai viste, il cuore si perde”.
Addestrata in gioventù al canto jazz presso il conservatorio di Milano, Del Grandi si domanda adesso: “La mia voce suona differente?”. Accade in “Mata Hari”, che apre la sequenza su mesto arpeggio di sintetizzatore e trova poi sbocco in un’emotiva melodia pop contrappuntata in coda dal fraseggio dei fiati.
“Se non per l’amore, per cosa viviamo?”, s’interroga al culmine della canzone, scritta – come tutte le altre – con l’intenzione di “rivelare alcuni dei miei pensieri più profondi”.
Eccola allora affrontare addirittura la “fine del mondo”, articolata in due atti: collocato in posizione centrale, il primo ha tono elegiaco (“Il silenzio riempiva l’aria e negli occhi delle persone brillava una certa luce”), mentre il secondo – all’epilogo – definisce un orizzonte (“Nuotando, anelando a una riva luminosa e soffice, calda e rilassante, da raggiungere per riposare le mie membra”) sul fondale imbastito con solennità liturgica da una tastiera.
Sempre a proposito del sentimento amoroso: “Detesto implorare, ma vuoi restare, per favore?” indirizza il discorso svolto accompagnandosi alla chitarra in “Stay”. Al contrario, parlano di separazione sia “Chameleon Eyes” (“Io sono una stagione passeggera e tu una quercia con radici robuste, forti e profonde, quindi portami per un ultimo ballo in un posto dove brilleremo, sarò il tuo tutto per un’ultima volta, prima di andarmene”), sia l’evanescente “Marble Season” (“Abbiamo fallito come sapevamo di dover fare”), con l’accento malinconico creato dall’archetto sulle corde del contrabbasso.
Il ventaglio delle possibilità esplorate è piuttosto ampio: dal canone della ballata folk, sul quale si adagia con eleganza “Two Halves” (“Sono divisa in due metà, una canticchia tra sé e sé, l’altra ha bisogno di mettersi in mostra”), agli echi del jazz che risuonano – fra rullar di tamburi, volteggi di sax ed elastica inflessione vocale – in “Snapdragon” (“Sarai il mio alibi? Mi coprirai le spalle?”, dice rivolgendosi appunto a una bocca di leone).
Punto di sintesi fra quegli elementi è “Eyes of the Day”: distillato di pura grazia da cui apprendiamo che “la bellezza sta nello spazio tra la fiducia e la paura”.
Di sicuro la troviamo pure in Selva: un disco ingegnoso e squisito. Prova del nove saranno i prossimi concerti a Torino, Bologna, Roma e Milano, in programma a novembre.