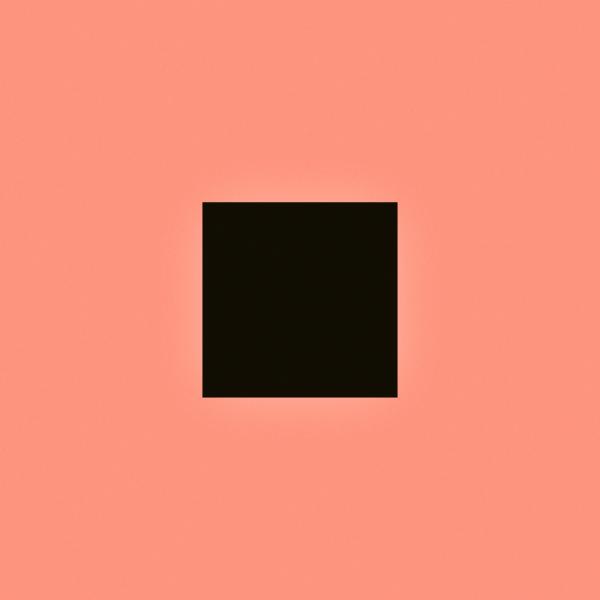Lo scabroso cyberpunk dei Mandy, Indiana
I’ve Seen a Way, primo album del quartetto di Manchester, è un’allarmante istantanea del nostro tempo

Esercita un fascino scabroso I’ve Seen a Way, primo album dei Mandy, Indiana, quartetto allevato nel sottobosco di Manchester.
Leggenda vuole che la cantante Valentine Caulfield, parigina emigrata oltremanica, abbia incontrato Simon Catling – l’uomo dei sintetizzatori – quando lui faceva il buttafuori in un club e una notte la cacciò dal locale a causa del suo stato di alterazione alcolica.
Siccome da cosa nasce cosa, in circostanze meno turbolente la mise poi in contatto con Scott Fair, chitarrista e produttore in cerca di complici: così prese forma il gruppo, completato infine dal batterista Alex Macdougall.
Dalla chimica dei quattro è scaturita una strana creatura dotata di ispida corazza post punk e metabolismo technoide, influenzata in ugual misura dalle vicissitudini dei Nirvana (“C’è qualcosa di molto poetico nella storia di quella band, come se fosse stata scritta da uno Shakespeare maldestro”, ha dichiarato Fair) e dalle suggestioni suscitate da film controversi quali Titane di Julie Ducournau e Climax di Gaspar Noé.
In verità, però, l’incipit del disco è collocato in uno scenario da Blade Runner, fra scrosci di pioggia e allusione nel titolo – “Love Theme (4K VHS)” – al brano più celebre della colonna sonora firmata da Vangelis, benché qui lo strumentale riecheggi piuttosto – nei toni da “prog” gotico – certe taglienti imprese di The Knife.
In sequenza segue “Drag (Crashed)”, trainato da cadenza incalzante su un fondale di scuola “industriale” degno dei Throbbing Gristle. Al centro dell’azione sta comunque la voce di Caulfield: “Sono stanca, non sai quanto stanca, questo mondo di merda mi ha sfinito (…) Niente mi fa venire voglia di andare avanti, in questa società del cazzo”. E ancora: “Quando lasciamo morire la gente nel mar Mediterraneo, in edifici non riscaldati, nei nostri paesi incasinati, quando scegliamo i nostri rifugiati, gli unici che lasciamo entrare sono biondi”, declama con acredine in madrelingua.
«Scrivo esclusivamente in francese e molte persone non capiscono quello che dico, perciò uso allitterazioni e consonanze: cerco di creare musica con le parole e di trasmettere un messaggio efficace», ha spiegato a proposito, citando addirittura ad esempio i canoni dell’opera lirica, in grado di «comunicare attraverso le proprietà emotive della voce, senza che si debba conoscere necessariamente il tedesco o l’italiano».
Ciò provoca all’ascolto un curioso straniamento esotico, rendendo enigmatico un tracciato narrativo altrimenti esplicito: “Nulla è vero, tutto è permesso, finisci il tuo avversario”, recitano fra spasmi ritmici e muggire di bassi i versi di “Pinking Shears”, in bilico fra assiomi situazionisti e dialoghi da Spid Games.
L’intelaiatura musicale deriva da un procedimento in cui all’hi fi delle registrazioni in studio corrisponde la bassa fedeltà di input forgiati in luoghi insoliti, da una grotta nel Somerset alla cripta di una chiesa sconsacrata, o captati per mezzo dello smartphone dentro un ipermercato e in un pascolo delle Alpi Svizzere.
L’insieme è funzionale alla creazione di un pathos allarmante: ecco allora, all’epilogo, il passo marziale di “Sensitivity Training”, sincronizzato sull’inquietudine generata dalla recrudescenza dei fascismi (“Senti il rumore degli stivali che rimbombano sul marciapiede, vengono da noi, gli stivali, vengono a prenderci”). E anche in “Peach Fuzz”, dove un insidioso groove elettronico sfocia in un claustrofobico martellamento techno, l’ammonimento concede poche speranze: “Non è una rivolta, è una rivoluzione, loro vincono e noi perdiamo”.
I’ve Seen a Way è figlio dei giorni nostri, insomma, e non fornisce risposte, tutt’al più suggerisce un’attitudine: “Abbracciamo il caos”, ha detto Fair a “NME”.