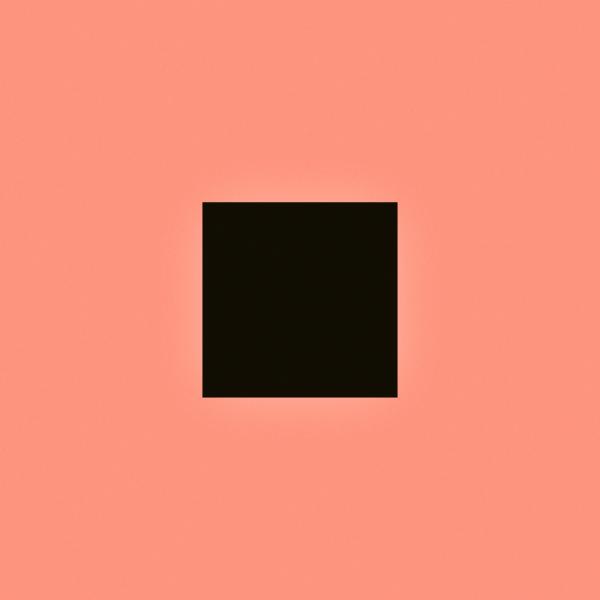La raffinatezza dell’Orso Grigio
Il ritorno in grande stile degli statunitensi Grizzly Bear, dopo cinque anni di silenzio discografico

Appartenente alla nidiata bohémienne di Williamsburg che a metà del decennio scorso ricollocò New York al centro delle mappe musicali, con il tempo la banda dell’Orso Grigio ha messo una distanza fra sé e il resto di quella scena: sia in termini banalmente geografici (dei quattro, soltanto David Rossen abita ancora in zona: gli altri – a cominciare dal fondatore Ed Droste – si sono trasferiti in California) sia – soprattutto – in senso stilistico, allontanandosi man mano dall’impostazione folk originaria per affermare una vocazione pop aristocratica (di ciò prese atto l’influente magazine online “Vulture”, definendola “la famiglia reale dell’indie rock”).
Nonostante la complessità formale del proprio linguaggio, i Grizzly Bear sono diventati un caso di successo grazie al terzo lavoro, Veckatimest (2009), dove spiccava “Two Weeks”, brano sfruttatissimo dai cacciatori di canzoni delle agenzie pubblicitarie, e al seguente Shields (2012), mentre la colonna sonora di Blue Valentine (2010) ne allargava il raggio d’azione verso il pubblico cinematografico.
Tornano ora a farsi vivi dopo un silenzio quinquennale, mettendo in vetrina l’opera più ambiziosa dell’intera carriera, corrispondente al passaggio nei ranghi di una major. Costruito con raffinata perizia artigianale e ammirevole maestria strumentale (dalle ritmiche intricate ma fluide scandite dal batterista Christopher Bear alla propulsione dinamica impressa al suono dal bassista Chris Taylor, produttore del disco e di tutti i precedenti, eccezion fatta per il primo, Horn of Plenty, in pratica una prova da solista di Droste), Painted Ruins ostenta qualità che lo estraniano dall’attualità (e dunque dalle mode del momento), rendendolo classico.
Si tratta di un album alla “vecchia maniera”, meritevole di essere ascoltato cioè da cima a fondo, cogliendone via via le sfumature pregiate, dai cori in chiave Beach Boys al gusto da jazz “progressivo” degli arrangiamenti, tale da avvalorare l’accostamento agli Steely Dan suggerito da Rossen. La sequenza si apre in ambiente quasi cameristico con la soffusa malinconia di “Wasted Acres”, affine alla sensibilità dei Radiohead (il cui chitarrista Jonny Greenwood, reduce da un tour statunitense condiviso, lo elesse nel 2008 suo gruppo preferito), e termina – 48 minuti più tardi – avvolta nella solennità orchestrale di “Sky Took Hold”, infilando lungo il cammino perle quali “Mourning Sound”, “Three Rings” e “Neighbors”.