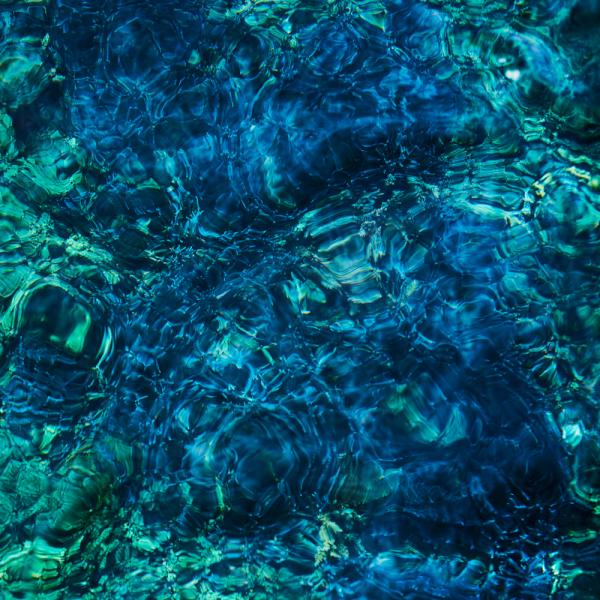La Grande Macchina Rossa di Bon Iver e Aaron Dessner
Il progetto Big Red Machine vede affiancati Justin Vernon (Bon Iver) e il chitarrista dei The National

Un progetto che covava da un decennio, nominato con il titolo della canzone da cui ha preso spunto, inclusa allora nella compilation Dark Was the Night. Lo animano due pesi massimi della scena indipendente d’oltreoceano: Justin Vernon, celebre per le imprese compiute come Bon Iver, e Aaron Dessner, insieme al gemello Bryce – qui ovviamente implicato – forza motrice in senso musicale dei National.
Fra le tante cose, sono altresì curatori in tandem del festival Eaux Claires in Wisconsin, uno degli ambiti nei quali la Grande Macchina Rossa è stata rodata dal vivo, prima ancora di essere ultimata in sala di registrazione. In realtà, attraverso la piattaforma web PEOPLE, intorno al duo si è aggregato un collettivo di artisti (l’altro “nazionale” Bryan Davendorf e Richard Reed Parry dei canadesi Arcade Fire i più noti) e dunque l’opera rivela una natura da esperienza condivisa. Lo conferma Dessner: «Abbiamo guardato al disco e alla sua lavorazione da un punto di vista comunitario».
Detto questo, l’impronta di chi l’ha avviata è nondimeno evidente. In particolare quella di Vernon, il cui tipico stile vocale (un falsetto trattato elettronicamente) contrassegna alcuni degli episodi chiave, conferendo loro un carattere al tempo stesso malinconico e avveniristico. Esemplare è il raffinato spleen intimista di “Forest Green”, che unito al binomio iniziale, “Deep Green” e “Gratitude”, definisce il canone al quale l’album si attiene, violandolo in maniera occasionale nel portamento country – ma in modalità valzer futurista – di “Hymnostic” (con retrogusto gotico: “Non sono un’apparizione, eppure ti tormenterò”) e, in tutt’altra direzione, nel groove sincopato di “Lyla”, quasi al confine dell’hip hop.
Se viceversa dovessimo cercare tracce dei National, le troveremmo in “I Won’t Run From It”: ballata dal tono piuttosto classico, dove significativamente la voce non è filtrata.
Della decina di brani, quello che ostenta maggiore ambizione (ed estensione, oltre i sette minuti e mezzo) è “OMBD”, sviluppato con andamento pigro ma screziato poco dopo la metà da una struggente impennata melò. Non sempre alle intenzioni dei protagonisti corrispondono esiti soddisfacenti quanto ci si aspetterebbe, considerandone il rango (“Air Stryp” suona cervellotica e, in chiusura, un eccesso di enfasi compromette “Melt”), però la qualità superiore degli arrangiamenti e il trasporto emotivo di certe composizioni (citiamo “People Lullaby”, guidata dal piano) pongono comunque il risultato finale ben al di sopra della media corrente.