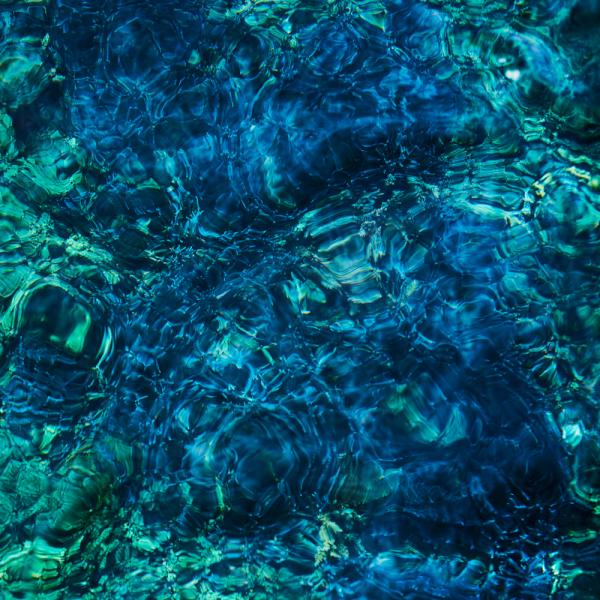La fioritura di Susanne Sundfør
Il nuovo album della cantautrice norvegese, blómi: un antidoto all’oscurità

Nativa di Haugesund, cittadina portuale affacciata sul Mare del Nord, la 37enne cantautrice Susanne Sundfør in Norvegia è una celebrità da hit parade.
Oltre confine, invece, si era fatta notare una decina di anni fa, interpretando il tema principale del film Oblivion, composto dal francese M83, e successivamente con l’album del 2015 Ten Love Songs, seguito nel 2017 da Music for the People in Trouble.
Da allora, un lungo silenzio dovuto agli impegni della maternità, ed è appunto alla figlia primogenita che si rivolge nella canzone dalla quale il nuovo lavoro prende nome: “Custodisci il dono che ti ha consegnato tua madre, dalle ceneri del dolore risorgeremo”, intona in “blómi” – “fioritura” in lingua norrena, impiegata nella maggioranza dei titoli, benché i testi siano in prevalenza anglofoni – adagiandosi sul canovaccio blues dettato dal pianoforte, dove s’insinua poi mellifluo un sassofono da jazz nottambulo.
L’esperienza da cui è reduce l’ha indotta a riflessioni di ampio respiro sulle remote civiltà matriarcali e il relativo asse matrilineare di culti e religioni: a ciò allude “ashera’s song”, avveniristico canto devozionale intestato alla Dea Madre della mitologia semitica, materia di studio e ricerca per suo nonno, il teologo e linguista Kjell Aartun, raffigurato nella fotografia di copertina accanto a lei bambina e citato nel recitativo in tedesco di “ṣānnu yārru lī”, che procede claudicante su un groove “exotico” degno del canzoniere di Tom Waits.
Altre sono però le fonti d’ispirazione dichiarate dall’artista norvegese: Carly Simon, Carole King e Joni Mitchell, in particolare. Ne sono dimostrazione gli episodi più convenzionali del lotto: una ballata folk come “rūnā”, oppure “náttsǫngr”, sorta di ninnananna consacrata all’“amore di un uomo che conosco a malapena”. Da quel sentimento scaturiscono emozioni contrastanti: “fare thee well” descrive a tempo di valzer una separazione (“Addio, questa è l’ultima volta che mi guardi in faccia, non c’è più grazia qui, solo amarezza, i tempi stanno cambiando, la storia sta finendo, nuovi inizi si stanno rivelando”), mentre “alyosha” cita uno dei fratelli Karamazov per salutare una relazione nascente (“Sei tutto ciò in cui credo, amore mio”).
Aperto e chiuso da brani nei quali in voce compare Eline Vistven, musicista anch’ella e terapista, dispensando pillole di saggezza dal vago sapore “new age” (“Il buco nero è buio, ma è un buio luminoso, bellissimo, quasi scintillante, ed è fatto di intelligenza fluida, è ciò che sei, e il corpo non è separato dallo spirito”, declama nell’enigmatico ambiente glitch dell’iniziale “orð vǫlu”), il disco raggiunge l’apice in “leikara Ijóð”: idilliaco gospel artico scandito da battimani e segnato in coda dal timbro arcaico del violino di Hardanger. Là si coglie in maniera nitida l’intenzione che ha animato l’autrice: creare “un antidoto all’oscurità che oggi domina la nostra cultura”.