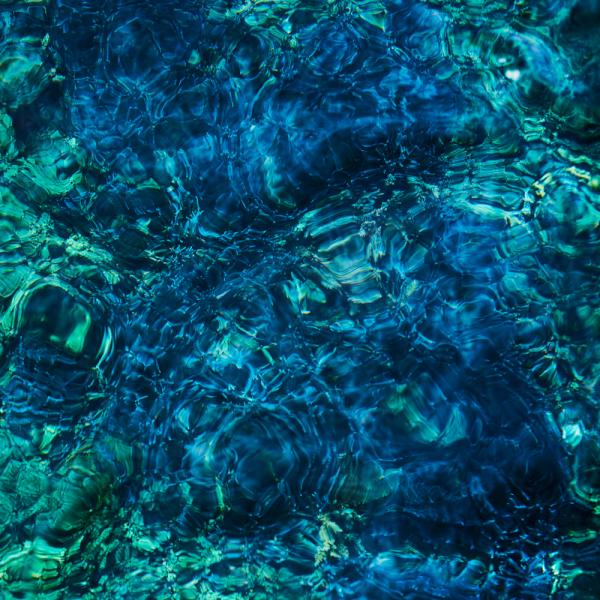Janelle Monáe, una diva afroamericana per il nuovo millennio
Dirty Computer è l’album della consacrazione per Janelle Monáe, un capolavoro di black music audace ed empatica

Musica pop figlia del nostro tempo, ingegnosa e seducente, però ancorata ai temi forti della cronaca politica e sociale: ecco Dirty Computer di Janelle Monáe.
Anzitutto la questione femminile: “Tutto è sesso, eccetto il sesso, che è potere, il potere è solo sesso, capisci, e adesso domandati chi frega chi”, canta dialogando con Zoë Kravitz in “Screwed”, vocabolo equivalente sia a “fregare” sia a “scopare”. È la stessa donna che a gennaio, durante la cerimonia dei Grammy Awards, ha tenuto un fiero discorso sulla parità dei diritti, dopo essere intervenuta già un anno prima al culmine della marcia su Washington organizzata in concomitanza con l’insediamento alla presidenza di Donald Trump.
E poi ecco il problema razziale: “Non sono l’incubo americano, sono il sogno americano”, afferma in “Crazy, Classic, Life”, rivolta a una “polizia come Rambo”. Per disegnare il proprio ritratto, invece, ha creato l’alter ego protagonista in “Django Jane”, ruvido numero hip hop nel quale mette in scena l’orgoglio autobiografico (“Ricordi quando dicevano che sembravo un maschiaccio?”), esorta a una pussy riot e intima: “Lascia che la vagina faccia il suo monologo”.
Detto fatto, nel videoclip di “Pynk”, dove lei e le altre indossano pantaloni a forma di grandi labbra.
Il programma di rivendicazioni è riassunto nell’epico epilogo “Americans”: “Finché le donne non otterranno una paga equa per un lavoro equo, questa non sarà la mia America, finché innamorati dello stesso sesso non potranno essere sé stessi (…) finché i neri non potranno tornare a casa da un posto di blocco della polizia senza prendersi una pallottola in testa (…) finché i bianchi poveri non avranno l’opportunità di avere successo”.
Tutto ciò espresso con l’autorevolezza di un’artista che ha sconfinato già nel cinema, interpretando ruoli di primo piano in film quali Moonlight e Hidden Figures: capisaldi dell’attuale Black Power culturale. Proprio quegli impegni sul set hanno ritardato il completamento di Dirty Computer, distante cinque anni dal precedente The Electric Lady, seguito del folgorante debutto del 2010 The ArchAndroid, il cui slancio afrofuturista si riverbera nel distopico mediometraggio che fa da sfondo narrativo al disco nuovo.
La differenza sta nell’inedita spudoratezza carnale dei contenuti: “Voglio essere scopata in vacanza, a un matinée, a un festival, come un animale” (ancora in “Screwed”). Una sessualità tradotta in esperienza di libertà, sotto il baluginare di luci rosse, tipo quelle che illuminano il duetto con Pharrell Williams in “I Got the Juice”, opposto al nitore del brano incaricato di aprire e intestare la raccolta, impreziosito ai cori dalla stagionata voce bianca di Brian Wilson. Delle varie presenze che popolano l’album, la più rilevante è quella fantasmatica di Prince, suo ispiratore, consigliere e partner musicale: la si percepisce distintamente in “Make Me Feel”, in pratica una versione aggiornata di “Kiss”, scandita da uno schioccare di lingua.
Risultante di tali vettori è un’opera straordinaria, insieme audace ed empatica: definitivo atto di consacrazione a diva della trentaduenne Janelle Monáe Robinson da Kansas City, figlia di padre camionista e madre bidella.