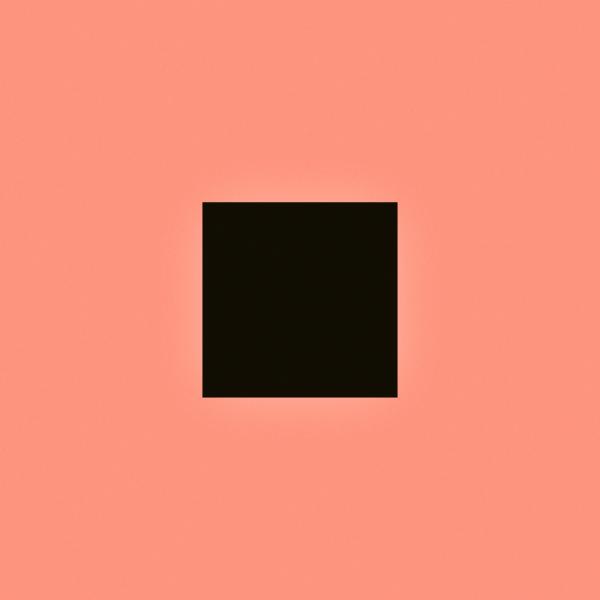Il divisionismo musicale di Beatrice Dillon
L’affascinante elettronica concettuale della londinese Beatrice Dillon, all’esordio con Workaround

Ascoltando di sfuggita l'album d’esordio di Beatrice Dillon intestato all’“espediente”, che segue un gruzzolo di uscite discografiche in vari formati (eccellente il “mixtape” del 2018 per RVNG Intl.), riesce difficile immaginare che l’autrice abbia discusso tempo fa, laureandosi al Chelsea College of Arts, una tesi sulla celeberrima Anthology of American Folk Music compilata nel 1952 da Harry Smith.
Soffermandosi però con maggiore attenzione sui dettagli che concorrono a tesserne la fitta trama, il paradosso perde consistenza. Workaround racchiude infatti un’ampia gamma di strumenti acustici, il cui suono tuttavia è stato incanalato nei circuiti di un laptop per finire sezionato e ricombinato in fogge differenti. A dispetto della quantità di elementi costitutivi, il mosaico ricavato ha sembianze rigorosamente minimaliste: diciamo musica da club stilizzata, per intendersi. In termini programmatici, la produttrice londinese ha scelto il canone dei 150 Bpm: più veloce della tipica cadenza house senza raggiungere l’ipercinesi della jungle. Prendiamo ad esempio “Workaround Two” (tranne tre, tutte le tracce della raccolta si riferiscono al titolo generale): scorre con grazia a ritmo di tabla (percosse dal maestro del Bhangra britannico Kuljit Bhamra), impreziosito dal languore di un sax nottambulo e dai vocalizzi soul dell’ospite statunitense Laurel Halo.
Se l’iniziale “Workaround One” pare evochi il Quarto Mondo concepito quarant'anni fa da Jon Hassell e Brian Eno, altrove l’essenzialità del risultato rimanda all’esperienza berlinese di Moritz von Oswald e Mark Ernestus con il marchio Basic Channel: è il caso di “Workaround Three”, dov’è impressionante il trattamento al quale è stato sottoposto il violoncello di Lucy Ralton, oppure dell’austera techno di “Square Fifths”, con un contrabbasso lavorato in chiave dub prosciugandone il timbro, anziché anabolizzarlo nella camera d’eco.
Alternando a episodi affabili – l’elegante swing di “Workaround Four” o l’apparenza quasi “pop” di “Workaround Seven”, ingentilito dall’arpeggio di kora del senegalese Kadialy Kouyaté – altri dall’aspetto viceversa severo (l’ectoplasma “technoide” di “Workaround Eight”, per dirne uno), Dillon elabora un complesso affresco sonoro, cui corrisponde l’eterogenea mappa geografica dei collaboratori: dal bristoliano Batu, astro nascente nel firmamento dance d’oltremanica, al cinese Jonny Lam, virtuoso della steel guitar abitualmente al servizio di Pharoah Sanders.
Solita a bazzicare i circoli dell’arte contemporanea attraverso partnership con il veterano Christian Marclay o la giovane pittrice tedesca Jorinde Voigt, è come se Beatrice Dillon avesse applicato alla materia musicale i principi del divisionismo, scomponendo i suoni e affidandone la ricomposizione alla sensibilità dell’ascoltatore. Perciò Workaround è un disco che affascina disorientando.