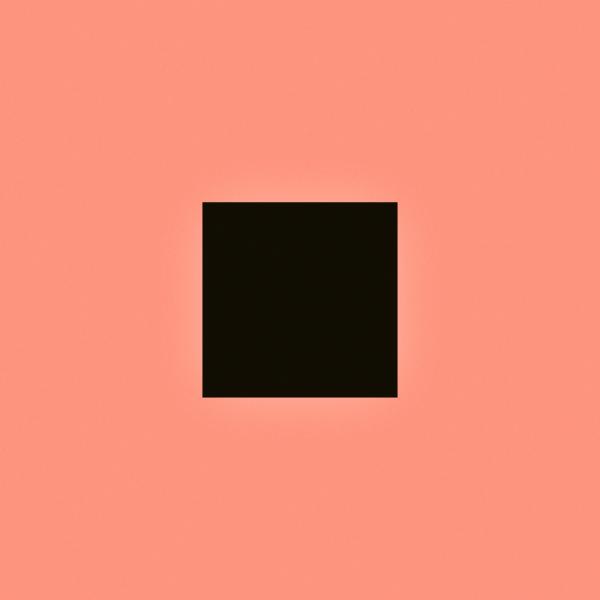DJ Shadow ombra di se stesso
Nel doppio album Our Pathetic Age DJ Shadow è ostaggio della propria ambizione

È eloquente il titolo del nuovo album di DJ Shadow, Our Pathetic Age, ovviamente riferito alla situazione attuale. E condivisibile la diagnosi, esposta dall’autore in sede d’introduzione all’opera: «La gente è schiava e sopraffatta dalla distrazione, rabbiosa e confusa, e disamorata delle istituzioni governative».
Ma la terapia? Nelle intenzioni del quarantasettenne produttore californiano, immaginiamo, contempla l’ascolto di questo album: «ciononostante speranzoso e vitale». È il sesto della serie per Josh Davis, che all’esordio come DJ Shadow creò un capolavoro fenomenale – Endtroducin’…, strabiliante mosaico sonoro realizzato maneggiando vinili in modalità taglia-e cuci – divenuto nel tempo paradigma con cui egli stesso si è dovuto confrontare, senza riuscire mai ad avvicinarsi al vertice raggiunto allora.
Il dilemma, in casi simili, è se si debba ricalcare il modello affermato, rimanendo ostaggi del proprio successo, o viceversa distanziarsene. Più delle volte scorse si ha la sensazione che nella circostanza l’Ombra abbia tentato di riformulare quel canone con mezzi differenti. Evidentemente in termini di ambizione, come dimostra l’entità del lavoro: un disco doppio, 23 brani in totale (bonus a parte) per circa 80 minuti di musica, con una metà in larga misura strumentale e l’altra imperniata sulle voci degli ospiti (una vasta e altolocata platea, esclusivamente maschile: vorrà dire qualcosa?). E poi in senso stilistico, tornando all’alveo originario dell’hip hop, soprattutto nella seconda sezione, dove svetta ad esempio il brillante cammeo dei De La Soul in “Rocket Fuel”, dotato di slancio da party “vecchia scuola”.
La sequenza d’interventi è aperta dal peso massimo Nas, in coppia con Pharoahe Monch, anche lui veterano newyorkese, per “Drone Warfare”, l’episodio più esplicitamente politico del lotto, cui segue l’efficace “Rain on Snow”, che prende nome da un brano anni Sessanta della cantante britannica Samantha Jones, interpolato al flow di un’ampia rappresentanza del Wu-Tang Clan: Ghostface Killah, Inspectah Deck e Raekwon. Ecco quindi in azione i Run The Jewels, già in vetrina nell’apice – “Nobody Speaks” – del precedente Mountains Will Fall e qui nuovamente convincenti in “Kings & Queens”. La molteplicità d’interpreti non giova comunque all’omogeneità dell’insieme e alcuni tra loro sembrano fuori luogo: Paul Banks degli Interpol in “Small Colleges”, per dirne uno, mentre se la cava meglio Samuel T. Herring dei Future Island, conferendo pathos all’esercizio di pop danzabile che intesta l’intera raccolta.
I problemi dell’album affiorano nel segmento iniziale, quando il protagonista se la deve sbrigare da solo. A tratti le cose funzionano e Shadow offre grooves adeguati alla sua fama, come accade nello spettrale esistenzialismo ambient di “We Are Always Alone” o sull’animata cadenza di “Rosie”.
Altrove invece si resta interdetti: di fronte al jazz futurista di “Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos, Law”, oppure assistendo al suo primo esperimento da compositore per ensemble orchestrale, il calligrafico “Firestorm”. Sono tuttavia i pezzi nei quali Davis armeggia con l’elettronica a deludere davvero: dall’indisponente irrisolutezza di “Intersectionality” al rumorismo cervellotico di “Juggernaut”. Una maggiore snellezza non avrebbe guastato: alla fine Our Pathetic Age fa così l’effetto di un pasto troppo abbondante.