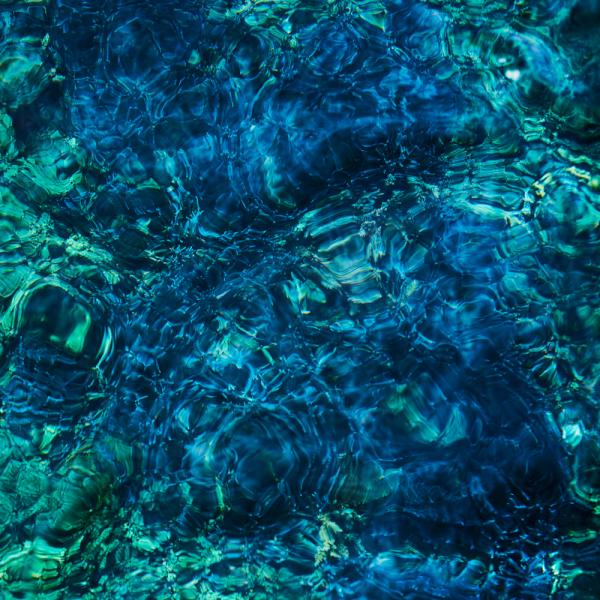Andy Stott, avveniristico anacronistico
In Never the Right Time il produttore di Manchester rende emotivo il suono elettronico

Chissà intendendo cosa Andy Stott ha attribuito l’espressione Never the Right Time – “mai il momento giusto” – alla sua nuova prova discografica. Figura piuttosto elusiva nella scena del suono elettronico contemporaneo, il produttore di Manchester – in attività da circa un decennio e mezzo – aveva raggiunto l’apice della carriera fra il 2012 e il 2014, pubblicando due album acclamati anche fuori dalla cerchia ristretta degli intenditori: Luxury Problems e Faith in Strangers.
In Never the Right Time pare voglia tornare a evocare quelle atmosfere, dopo un paio di dischi – Too Many Voices (2016) e It Should Be Us (2019) – nei quali si era riconnesso alle sonorità “dub techno” dei primi lavori, imparentati con l’austero minimalismo berlinese di scuola Basic Channel. L’evidenza maggiore di questa riconversione è rappresentata dalla voce di Alison Skidmore, già apprezzata in tali circostanze. Una presenza che merita di essere spiegata: durante l’adolescenza fu lei a impartirgli lezioni di pianoforte ed essendo altresì cantante lirica costituì una soluzione facilmente accessibile quando Stott decise di “umanizzare” la propria musica. Rieccola dunque impegnata al microfono fin dall’episodio che apre la sequenza, “Away Not Gone”, dove s’insinua in un nebbioso sfondo strumentale con intonazione resa diafana ed enigmatica da filtri ed effetti. La ritroviamo poi fluttuante su lunghezze d’onda analoghe all’epilogo, in “Hard to Tell”, scandito da ritmo indolente e imbevuto di spleen.
Negli altri episodi in cui affiora, il canto di Skidmore ne enfatizza la dimensione emotiva, sia aleggiando con grazia eterea – in quello che dà titolo alla raccolta, dal groove sommesso e il dissimulato slancio epico – sia esibendo fattezze aliene, come accade nella subacquea architettura glitch di “Don’t Know How”, mentre in “The Beginning” asseconda con empatia l’evoluzione degli arpeggi di sintetizzatore verso conformazioni vagamente “prog”.
In sua assenza, Stott sperimenta opzioni differenti: dal raffinato avant-clubbing di “Repetitive Strain” all’ambient dolente di “Dove Stone”, disegnando una mappa sonora variegata e avvincente. Che risulti o meno al passo con i tempi è – a conti fatti – del tutto irrilevante.