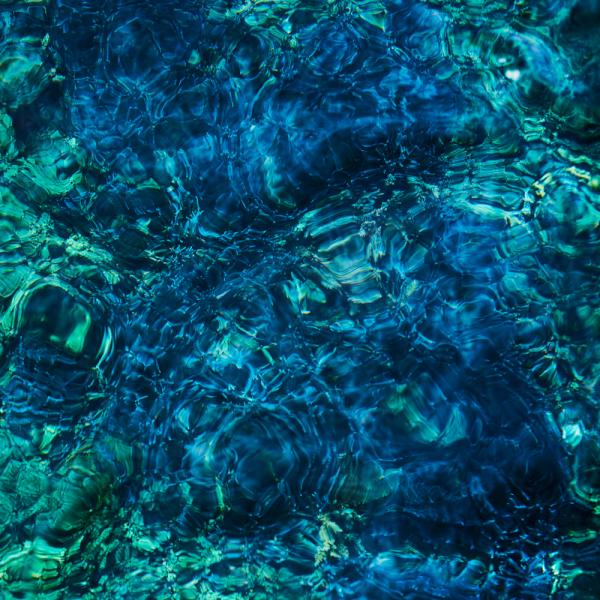Aeon Station, osservatorio sulle occasioni perdute
Il debutto da solista di Kevin Whelan: ex bassista nella cult band The Wrens

Un buon disco, questo debutto di Aeon Station, che rivela in trasparenza una trama degna di un romanzo (o un film) di formazione. «È passato un mucchio di tempo dall’ultima volta che hai avuto mie notizie», recitava l’incipit di "The House That Guilt Built", breve brano d’apertura di The Meadowlands dei The Wrens alludendo ai sette anni trascorsi fra quell’album – edito nel 2003 – e il precedente.
Il successivo disco della band americana non sarebbe mai uscito, benché annunciato ripetutamente, ancora nel gennaio scorso per bocca del chitarrista e cantante Charles Bissell. Frattanto l’eco di quell’indie rock d’alta scuola – «Luminoso pop letterario», aveva proclamato all’epoca il “New York Times” – non si era smorzata. Nel marzo 2006, recensendone un concerto londinese, “The Guardian” affermò: «Dal vivo i Wrens sono senz’altro una delle migliori band del pianeta».
Qualche settimana fa, la medesima fonte ha pubblicato un’intervista a Kevin Whelan, bassista e cantante anch’egli in quel gruppo di «martiri dell’underground», per usare la definizione del cronista incaricato di ricostruire la vicenda, sfociata in una separazione acrimoniosa della quale è diretta conseguenza Observatory, debutto individuale dell’interpellato sotto l’intestazione Aeon Station. Delle dieci composizioni incluse, la metà esatta costituiva la sua dote di repertorio nel disco fantasma: “Better Love” e “Queens” suonano appunto come la prosecuzione dei Wrens con altri mezzi, né potrebbe essere diversamente, vista la partecipazione dei reduci restanti, il batterista Jerry MacDonald e – alla chitarra – Greg, fratello maggiore di Kevin.
Domanda proprio "Queens" a un certo punto: “Quando è cominciata tutta questa fine?”. Risposta: molti anni fa.
Ad esempio dopo la tournée seguita a The Meadowlands: «Durante uno show ci eravamo detti: "Probabilmente non possiamo davvero fare meglio di così e dunque dovremmo chiudere la storia”», confessò una volta il minore dei Whelan.
Ovvero nel corso delle tribolazioni ulteriori, protrattesi per un decennio abbondante e causate dalla cocciuta pignoleria di Bissell, a sentire il bassista, che infine ha tagliato corto e si è messo in proprio: «Mi volto per dimenticare il passato che lascia dietro di sé tutte le strade interrotte verso le case e le speranze e i sogni che non si avvereranno (…) E quando ti accorgerai che me ne sono andato, sarà tutto finito in un ricordo conquistato a fatica», canta in “Leaves”, toccante ballata per voce e pianoforte destinata a un crescendo dai toni quasi melò.
Essendo frutto dell’esasperazione e delle frustrazioni in essa implicite, Observatory ha un gusto agrodolce, in particolare nei testi: “Mille turni di notte finiscono tutti con il sole, spaccando il capello in quattro per canzoni che non finiamo mai, dove sono i ricordi dei piani che facevamo?”, si ascolta in “Alpine Drive”, diafano epilogo della sequenza. Oppure: “Oggi è il giorno in cui siamo finalmente liberi dalla finzione di essere qualcosa che non abbiamo mai voluto”, trapela dalla melodia a cuore aperto di “Fade”.
Il linguaggio musicale è per certi versi anacronistico, soprattutto negli episodi più affini al canone della formazione madre, che ponendosi nella scia di Pixies e Pavement a fine Novecento ne sovraccaricò la poetica in senso emotivo: ricetta rielaborata poi con successo dagli Arcade Fire, volendo citare un caso celebre. Eppure, almeno a tratti, mostra di possedere qualità che lo pongono fuori dal tempo.