Nel 2024, il cosiddetto anno del centenario pucciniano, si è sviscerata la vita del lucchese sotto ogni aspetto, soprattutto dal punto di vista biografico anziché artistico. Come territorio, l’attenzione si è focalizzata principalmente sulla lucchesia, precipua zona di caccia, di svaghi e di composizioni.
Grazie alle attente e particolareggiate ricerche condotte da Massimo Signorini (Massimo Signorini, Puccini e… Livorno, Sillabe, Livorno 2024, pp. 324, 28,00 €), emerge una nutrita e pressoché costante presenza di Puccini a Livorno sin dall’epoca de Le Villi. I suoi soggiorni nella città labronica erano dovuti al voler presenziare sia le prove sia le recite delle sue opere, rappresentate al Nuovo Teatro degli Avvalorati (in seguito distrutto dai bombardamenti), Teatro Politeama (demolito nel 1968) e al Teatro Goldoni. I tre teatri ebbero per lunghi periodi la presenza di Puccini, che prese alloggio all’Hotel Giappone, considerando il numero di prove e di recite impressionante se confrontato con le attuali. Nel periodo analizzato da Signorini, tra il 1880 e il 1924, in una città piccola come Livorno erano attivi ben sette teatri, aumentati successivamente per il diffondersi del cinema. Le opere di Puccini rappresentate a Livorno furono duecentosettantasette (!), tra le quali primeggia Bohème (centocinquantatré); a seguire Tosca (cinquantasei), Manon (quarantanove), Butterfly (undici) e Fanciulla (otto). Sia le recite e i periodi dei soggiorni pucciniani a Livorno, sono ampiamente documentati da Signorini con dovizia di particolari: trascrizioni di articoli dei giornali locali, recensioni delle opere, lettere e riproduzione di rare locandine dell’epoca con precise citazioni di tutte le fonti, bibliotecarie, private e ipertestuali.
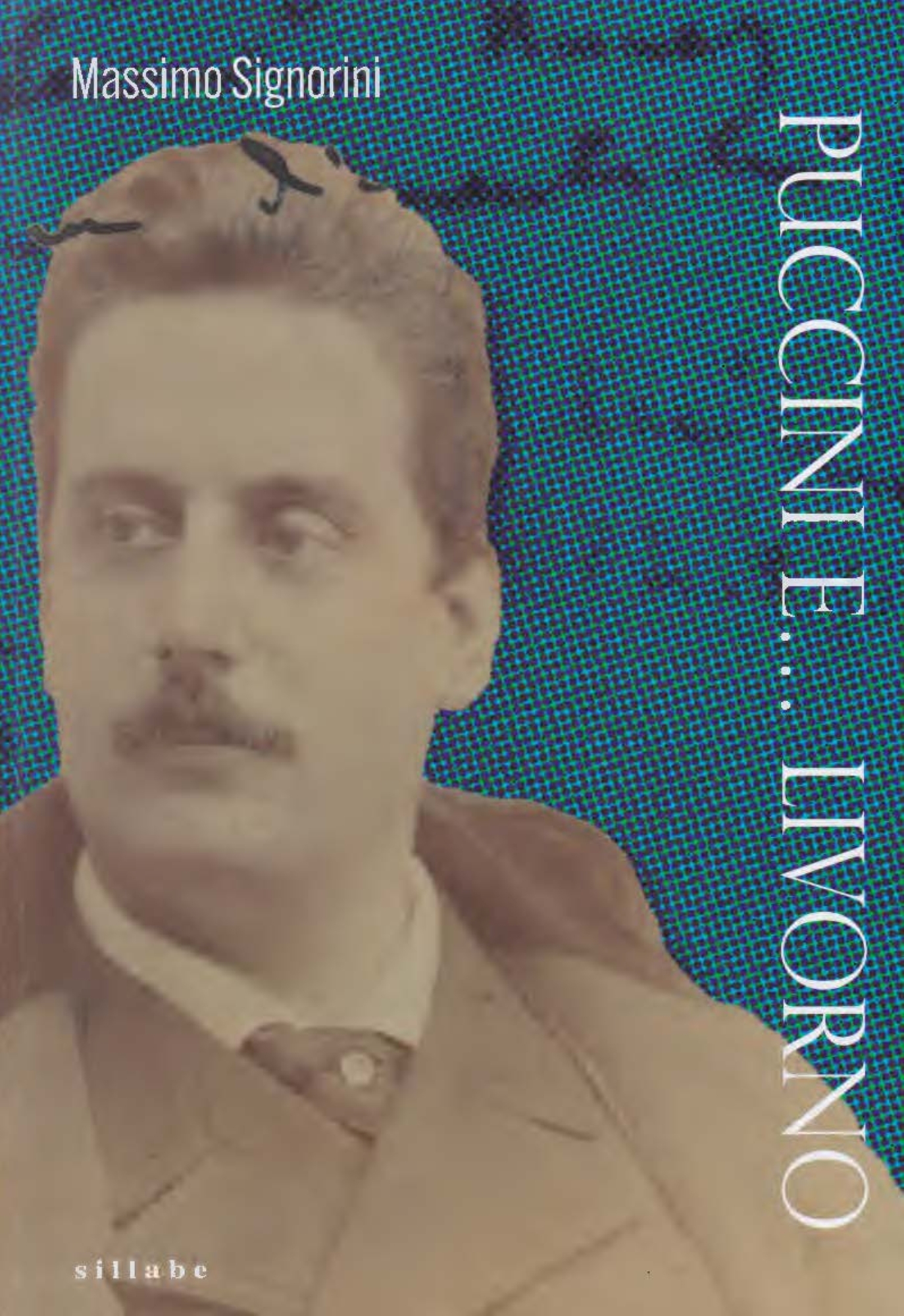
Anche se non inerente il periodo preso in esame, nel volume è riportata la trascrizione di una curiosa lettera finora inedita scritta il 17 aprile 1881 da Antonio Bazzini – all’epoca direttore del Conservatorio di Milano dove studiava Giacomo – alla di lui madre, Albina Magi. Il contenuto della lettera – conservata alla Biblioteca Labronica “F. D. Guerrazzi” di Livorno – informa la signora Magi sul progredire (scarso) del giovane studente. La risposta di Bazzini, sottintende a una precedente lettera inviata da Albina allo stesso Bazzini dove, oltre chiedere notizie sul profitto, avrebbe pure domandato al direttore la possibilità di trovare un’occupazione al giovane Giacomo. Ancorché curioso il modo di Bazzini nel recapitare il suo scritto alla signora Magi. Infatti, Bazzini la indirizza ad Alfredo Catalani presso l’editore Giovannina Lucca a Milano. Da ciò, si presume che Catalani si facesse latore della missiva durante uno dei suoi rientri a Lucca e che i due giovani compositori si conoscessero bene.
Un’altra scoperta, è il proliferare delle bande musicali; sia quelle militari sia le altre civili. E anche qui, entra in ballo il nostro lucchese. Tale proliferazione dei gruppi musicali, nel numero e nei pubblici concerti, aveva doppia finalità. Da un lato, la divulgazione della musica durante i concerti gratuiti; dall’altro, l’altrettanta proliferazione dei diritti d’autore, sanciti dall’allora recente Legge. Infatti, iniziarono a divenire numerose le trascrizioni per organico bandistico delle opere liriche, incluse quelle di Puccini. Su tali trascrizioni, è infatti sovente trovare le annotazioni di pugno pucciniano oltre le congratulazioni autografe rivolte ai maestri di banda. Tra l’altro, Puccini ebbe stretto contatto con la Banda del I Reggimento Granatieri di Sardegna sin dal 1886 ed era presente, nel giugno dello stesso anno, quando la citata Banda eseguì pubblicamente il primo atto de Le Villi; la notizia comparve pure sulla «Gazzetta Musicale di Milano» del 4 luglio 1886.
L’autore dedica pure ampio spazio agli ultimi giorni di Puccini a Bruxelles e il cordoglio della città di Livorno nell’apprendere la sua scomparsa.
Un libro di interesse non per i soli cittadini livornesi, ma pure per gli appassionati di Puccini e per chi voglia conoscere aspetti finora poco noti del lucchese. La lettura si presenta scorrevole, Signorini collega la sequenza delle trascrizioni come una piacevole narrazione; il linguaggio del testo è facilmente comprensibile e non per soli addetti ai lavori. Il volume è molto curato sia come contenitore sia come contenuto; dettagliata la bibliografia, numerose le chiose. Un indice analitico avrebbe migliorata la consultazione rendendola più rapida.



