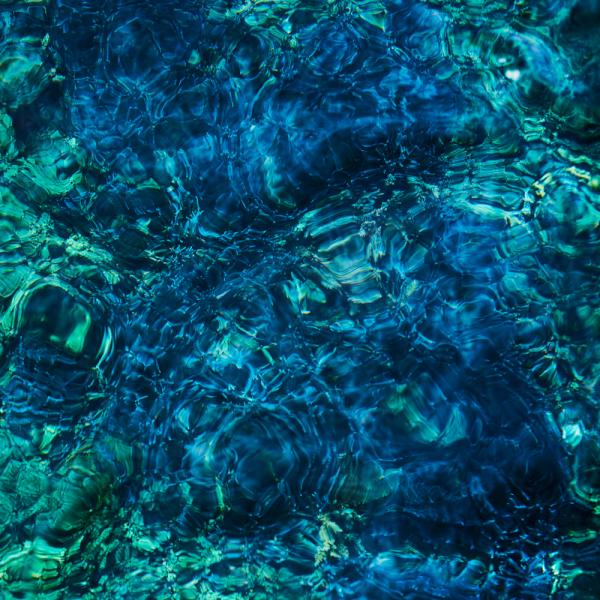Heimat, country e rock: il ritorno dei Wilco
Cruel Country è il nuovo (eccellente) doppio dei Wilco di Jeff Tweedy

Mettiamo subito un paio di punti fermi: Cruel Country non è un disco country (ci avevate creduto? Io sì ma solo fino al secondo singolo), e non è nemmeno lo sbandierato ritorno alle origini dei Wilco, ai giorni del vino e delle rose di Being There, o più indietro ancora al Midwest di frontiera degli Uncle Tupelo.
– Leggi anche: Wilco, la più incredibile live band in circolazione
Di sicuro però il dodicesimo album in studio della band di Chicago è una brusca sterzata – l'ennesima – rispetto al precedente Ode to Joy e al suo aplomb introspettivo e distaccato; ma anche rispetto ai formulari pop di Schmilco (da rivalutare) e dell'irrisolto Star Wars (irrivalutabile), o agli ultimi afflati sperimentali di The Whole Love.
E quindi, dato per assodato che a Yankee Hotel Foxtrot non si torna (a proposito: vent'anni tondi tondi) e che di A Ghost Is Born ce n'è già stato uno, dove diamine siamo capitati, stavolta? Difficile dirlo con esattezza. Perché c'è tanto di ogni cosa nei quasi ottanta minuti di un doppio – non succedeva dal 1996 del già citato Being There – che va ben oltre la falsa pista del titolo. La risposta più semplice, la prima che viene in mente (e forse anche l'unica sensata), è che Cruel Country è un disco di canzoni.
Ventuno in tutto. Fissate su nastro nel tepore informale del Loft, la casa-studio di Jeff Tweedy e compagni, durante una lunga serie di session dal vivo. Alla vecchia: stando insieme e lavorando insieme, condividendo pensieri, idee, spazi, ragionando sulla scaletta, sugli arrangiamenti, decidendo che lì sarebbe il caso di aggiungere una slide, qua un tappeto di tastiere e là invece un pianoforte. Il risultato? Un disco-mondo che ha la vastità di orizzonti di un'opera definitiva, di un best of immaginario, e il suono caldo, gioioso, confidenziale di una suonata tra amici; un The Basement Tapes in formato Wilco, con Tweedy sempre più Dylan (sua l'ombra da predicatore che si staglia sul muro dell'era post-Trump), il resto della band sempre più Band, il Loft di Chicago al posto della grande casa rosa e lo stesso cuore americano.
Un'idea di “country” – in inglese campagna, paese, nazione – che dal punto di vista concettuale si avvicina molto al significato della parola tedesca Heimat.
Per un'idea di “country” – in inglese campagna, paese, nazione – che dal punto di vista concettuale si avvicina molto al significato della parola tedesca Heimat, la patria portata al cinema da Edgar Reitz, il luogo al quale si appartiene, al quale si ritorna, dal quale ci si può allontanare solo geograficamente. Che per i Wilco, musicalmente parlando, è sempre stato quel groviglio di riferimenti che vanno dai Byrds di Sweetheart of the Rodeo ai Grateful Dead di Workingman's Dead e American Beauty, dai Flying Burrito Brothers a Will the Circle Be Unbroken, dai New Riders of the Purple Sage a Gram Parsons, John Prine, Jerry Garcia e Gene Clark.
Chiamatelo country-rock, se vi viene più facile, con un che di Americana se volete spingere lo sguardo oltre i Settanta e del prefisso “alt” non sapete che farvene; aggiungete la consueta attitudine power pop (Alex Chilton è ovunque, ma in sottofondo si sentono anche i soliti Beatles), tanta, tanta classe, un bel po' di imprevisti, e il disco grosso modo è fatto.
Bastano le iniziali “I Am My Mother” e “Cruel Country” per impostare le coordinate del viaggio. Le chitarre polverose e arrugginite, i sapienti tocchi di pedal steel di quel fenomeno di Nels Cline, la batteria asciutta, essenziale di quell'altro fenomeno di Glenn Kotche, l'epica antieroica dei testi («I love my country like a little boy / Red, white and blue / I love my country, stupid and cruel»): siamo a casa, non ci si può sbagliare. Stesso bagaglio e stessa direzione a bordo dell'ispiratissima “Ambulance”, forse il momento più dylaniano con il suo fervore religioso, della dolcissima “Please Be Wrong”, della spettacolare “A Lifetime to Find”, della dolente “The Plains”...
E poi c'è tutto il resto: il lato oscuro-sperimentale di “Empty Condor”, uno dei vertici della scaletta; le quadrature perfettamente Wilco di brani come “All Across the World”, “Mystery Binds” e “Tonight's the Day” (toh, c'è anche Neil Young); il Tweedy all'ennesima potenza di “Darkness in Cheap” e “Tired of Taking It Out on You” («Tear the tears out of your quiet face / I can't face the way I am with you»); la sognante “Many Worlds” («When I look at the sky / I think about stars that've died /Many worlds collide / None like yours and mine»), che poco dopo i tre minuti e mezzo si trasforma in una jam con i Fairport Convention.
Tanto di ogni cosa, dicevamo. In un disco decisamente Tweedy-centrico, inutile negarlo, con Jeff il canzoniere in conclamato stato di grazia, ma che suona Wilco dalla prima all'ultima nota. Era dai tempi di Sky Blue Sky, vale a dire dal 2007, che non si arrivava così in alto. Se a voi pare poco...