Era un capodanno di qualche anno fa. Tolo Marton mi aveva invitato per festeggiarlo con sua moglie e alcuni amici musicisti. Verso l’una prese in mano la chitarra e suonò a ruota libera tutto ciò che gli passava nelle vene. Poi, alle due del mattino, afferrò un bicchiere vuoto, uno di quelli da osteria, e con questo a far da dita, fino alle tre tirò fuori note, riff e arpeggi indimenticabili.
Prima di allora non avevo mai visto né sentito niente del genere. Fu un’esperienza fantastica.
Parto da qui per tracciare i contorni della figura umana ed artistica di Tolo Marton che per me, prima che musicista, è un amico. Il 13 settembre prossimo compirà 68 anni, un’età per la quale una persona, anche se giovane nello spirito, viene considerata vecchia. Questo non fa felice nessuno. Ma c’è qualcosa di buono nell’invecchiare perché a un certo punto uno sente di avere come la licenza, la libertà di dire e di fare tutto ciò che prima non si è detto e fatto per mancanza di coraggio o ritegno.
Se poi uno conoscesse da vicino Tolo, con quel suo tono di voce quieto e pacato, quasi dolce, non immaginerebbe mai che dietro a quella figura quasi “casalinga” ci possa essere un intraprendente musicista che sul palco spesso si trasforma in un sfrenato, graffiante e grintoso chitarrista. Ma dietro a tutte le apparenze e le opinioni che ognuno si può fare, ci sta solo quello che in fondo noi siamo veramente e pochi riescono a comprenderlo.
Chi non si vestirebbe da Arlecchino pur di fare soldi? Chi non scenderebbe a compromessi pur di avere successo? Ci vuole un carattere forte per saper rinunciare. Ci vuole molto coraggio per essere se stessi e andare contro corrente come fanno i salmoni per tornare da dove sono partiti.
Questa intervista, che per certi versi assurge a un biografia atipica, si propone di scavare nella vita di Tolo Marton, non tanto per decantarne successi e tracciarne il corso della sua carriera artistica, ma per conoscere più da vicino un uomo dal carattere schivo, timido e per certi versi introverso che, suonando la chitarra e nel fare musica, ha saputo dare voce alla propria anima senza cedere alle lusinghe del mercato.
Di nome fai Vittorio: chi ti ha dato il nomignolo Tolo?
«Io. Dall’età di due anni, quando qualcuno mi chiedeva il nome, non riuscendo a pronunciarlo dicevo Tolo. Da quel momento in famiglia tutti mi chiamarono Tolo e questo è rimasto».
«Dall’età di due anni, quando qualcuno mi chiedeva il nome, non riuscendo a pronunciarlo dicevo Tolo. Da quel momento in famiglia tutti mi chiamarono Tolo»
Com’è nato l’amore per la musica?
«All’inizio, negli anni Cinquanta, avevo cinque anni, è stata solo curiosità. Ero molto attratto dai suoni e dalle note. La prima esperienza con uno strumento e la musica la ebbi quando un’Epifania la Befana mi portò un pianino giocattolo con cinque tasti. Iniziai subito a metterci le mani e i miei fratelli più grandi si stupirono perché riuscivo a trovare le note delle canzoni. Per me fare musica è sempre stata una cosa istintiva perché riuscivo a decifrare le note musicali ad orecchio. In famiglia poi c’erano molti dischi che ascoltavano i miei fratelli, soprattutto il rock ’n’ roll e le canzoni degli anni Cinquanta, che giungevano anche a me».
Quando hai avuto la prima chitarra?
«Ho dovuto attendere fino al 1966 quando all’età di quattordici anni mi feci prestare da mio cognato una vecchia chitarra classica. In realtà mi sarebbe piaciuto suonare il pianoforte, ma in casa non avevamo un piano»
Chi ti ha insegnato a suonare?
«Il mio orecchio. Non ho mai preso lezioni, ascoltavo solo la musica e la decifravo con una certa sicurezza. Ascoltavo una canzone e poi la replicavo. Per capire le tonalità di un brano mi aiutava molto ascoltare le note del basso».
Perché la chitarra e non un altro strumento?
«In realtà la chitarra è stata casuale. Come ti ho detto prima, avrei voluto suonare il pianoforte. Dopo il pianino della Befana, grazie a mio fratello Paolo, che aveva un grande amore per la musica classica e cercava di trasmettermelo facendomela ascoltare, desideravo suonare il pianoforte».
«La chitarra fu un ripiego».
«Ammiravo immensamente mio fratello che per me è stato un punto di riferimento. Lui mi faceva ascoltare Beethoven, Bach, Schubert, Chopin e altri compositori perché capiva che avevo talento e una grande sensibilità per la musica. Lui mi portava al teatro e a vedere i concerti di musica classica. Ricordo una volta che mi portò a Venezia a vedere il pianista russo Svjatoslav Teofilovič Richter. Ascoltando questi autori, il pianoforte sarebbe stato una via obbligata e con lui lo studio della musica classica. La chitarra fu un ripiego».
Ma cominciasti a suonarla.
«Sì. Quando a quattordici anni uscì dal collegio e iniziai la quarta Ginnasio, ritrovai i miei vecchi compagni. I tempi erano cambiati e il panorama musicale era dominato dai Beatles e dai Rolling Stones. C’era un fermento di musica beat e complessini musicali che volevano emularli e quella musica entrò anche nelle mie vene. Poi un giorno un compagno portò a scuola una chitarra e durante la ricreazione me la fece provare; fu amore a prima vista».
Hai avuto anche una breve esperienza al basso…
«Sai, ascoltando le canzoni alla radio e nei dischi, assimilavo tutte le parti, sopratutto le note basse. Da lì riuscivo a capire qual era l’accordo, la tonalità di un brano perché il basso è uno strumento guida, mi aiutava ad orientarmi. Suonare oltre alla chitarra anche il basso, per me è stato naturale. Già a quei tempi con rudimentali registratori registravo brani che suonavo per poi riascoltarli e capire se gli avevo eseguiti bene. Questo metodo mi è servito molto».
Poi, dopo il Ginnasio sono arrivati i 3 anni di Liceo Classico.
«Sì, non che avessi chissà quali obiettivi con lo studio… La mia testa era presa solo dalla musica. Ma allora era quasi obbligatorio studiare per poi cercare di andare all’Università. Mi sono anche iscritto a Statistica a Padova, l’ho frequentata per un po’, ma sentivo che quella non era la mia strada. Ho dato qualche esame, ma il più delle volte, invece di andare a lezione, finivo nei negozi di strumenti musicali a provare chitarre per ore e ore. In quel periodo davo un esame all’anno per rinviare sempre il servizio di leva».
Avresti potuto lavorare nella libreria di famiglia…
«Sì, mio padre, come a tutti i fratelli, me l’aveva proposto. Per un periodo ho anche lavorato con lui in magazzino, ma mi sentivo inadeguato e pericoloso: più che essere di aiuto avrei potuto fare danni. Non avevo la cultura per lavorare in libreria. Contemporaneamente portavo avanti il mio discorso musicale, facendo progressi, ma senza pensare di fare il musicista. Sapevo che non avrei potuto vivere con quel mestiere, ma suonavo perché quello sapevo fare. In quel periodo mi domandavo cosa avrei dovuto fare nella mia vita ed ero preoccupato. Poi, pensandoci su, capii che già stavo facendo qualcosa. Suonavo. Facevo musica».
Prima di intraprendere la tua carriera solista hai fatto parte di molti gruppi musicali.
«Negli anni della scuola ho suonato con diversi gruppi riuscendo sempre a fare un salto di qualità. I primi gruppi gli ho costituiti io e suonavamo nei garage e nelle cantine. Allora suonavo il basso perché nel gruppo c’era già un chitarrista. Entrambi fummo poi ingaggiati da un gruppo storico di Treviso: La Nuova Generazione. Terminata questa esperienza ho messo su un gruppo mio, i Bestia, e ho preso in mano la chitarra, una Hofner e solo in seguito, nel 1970, una Stratocaster. Suonavamo in provincia di Treviso, ma a volte anche fuori dal Veneto davanti a trecento ma anche mille persone».
«Poi passai a I Puppies di Padova, un altro gruppo storico. Suonavamo tutte le domeniche alla Taverna di Fiesso d’Artico, davanti a ottocento, mille persone. A quei tempi più che fare concerti, si suonava in queste sale da ballo per la gente che veniva apposta per ballare. Si suonava il sabato sera, ma soprattutto la domenica pomeriggio. Nelle quattro ore di musica facevamo anche il liscio, tanghi e valzer, ma poi decidevamo noi cosa suonare. Proponevamo canzoni in voga, musica rock, cover di brani che più ci piacevano. In sette anni credo di aver eseguito almeno duecento cover».

«Per ogni uscita prendevamo dalle sette alle dieci mila lire, ed io in una settimana riuscivo a guadagnare anche cinquanta mila lire. Seppure vivessi sotto il tetto di mio padre, con quei soldi riuscivo a mantenermi e far fronte ai miei bisogni».
«Terminata l’esperienza con I Puppies, passai a Le Impressioni, altro gruppo di Treviso. Con loro si suonava soprattutto in un locale del Montello con un contratto di più mesi per tutte le domeniche. Ma si andava anche fuori, ad esempio in Emilia Romagna e lì ci guardavano come fossimo dei marziani perché non erano abituati ad ascoltare musica rock, ma rhythm & blues e liscio. La crisi energetica del 1973 ci causò dei problemi perché nelle sale da ballo ci toccava andare in treno, con strumenti al seguito. Nel 1974 il gruppo si sciolse e mi trovai senza lavoro e con l’Esercito che continuava a mandarmi solleciti per il servizio di leva».
«La crisi energetica del 1973 ci causò dei problemi perché nelle sale da ballo ci toccava andare in treno, con strumenti al seguito».
«Grazie a un musicista riuscì poi ad entrare in un’orchestra di Ferrara che faceva rhythm and blues e la prima disco music. Con loro suonai il basso e per sei mesi girai per tutto il Nord Italia. Ero un professionista pagato bene, ma dovetti accettare di suonare una musica che non mi piaceva in luoghi che non mi piacevano, ma soprattutto fui costretto, unica volta in vita mia, ad indossare una divisa: un costume da scena verde smeraldo, di seta».
Come sei entrato a far parte de Le Orme?
«Una volta uscito dall’orchestra di Ferrara, non ne potevo più di indossare quella divisa e suonare una musica che non mi piaceva, nel 1975 mi ritrovai di nuovo sulla piazza. Così un gruppo mi invitò a sostituire un chitarrista per suonare tutta l’estate in un locale di Jesolo. In quel momento Le Orme erano alla ricerca di un chitarrista. Vennero ad ascoltarmi e mi proposero di fare una prova con loro. Ci ritrovammo a settembre e in quell’occasione venne ad ascoltarmi anche il loro produttore, Gianpiero Reverberi, che appena mi vide mi chiese: “Dove sono i tuoi effetti?”, intendendo il pedale per fare distorsioni musicali, eccetera. “Non li ho” risposi. “Come non gli hai? Come fai a fare gli effetti speciali?” insistette lui. “Io li faccio con le mie mani” risposi sfrontatamente, ma una volta terminata la prova mi disse che avrei fatto parte del gruppo e sarei partito per l’America per andare ad incidere il nuovo disco».
La tua esperienza con Le Orme è durata solo il tempo di un album.
«Diciamo che è durata sei mesi. Il tempo di conoscerci, andare a Los Angeles ad incidere Smogmagica, tornare a casa e dirsi addio una settimana prima del tour che promuoveva il disco».

Che disco è Smogmagica?
«È un lavoro controverso. Devi sapere che quando mi proposero di entrare a far parte del gruppo, io credevo che Le Orme cercassero un chitarrista. In realtà quando eravamo in sala di incisione a Los Angeles, ma soprattutto vivendo con loro, ho capito che il gruppo era in crisi creativa. Non avevano un repertorio di brani già pronti, solo qualche idea. Per cui mi chiesero subito di pensare delle musiche per il nuovo disco. Le Orme facevano prog, un genere musicale che non mi apparteneva. Allora improvvisai della musica: una sorta di rock stile americano. I due brani che composi risultarono però difficili da accompagnare con dei testi in italiano. Così loro stravolsero la linea melodica che avevo scritto per accompagnarla a dei testi un po’ frivoli. Questi brani poi non piacquero al pubblico e un anno dopo loro diedero la colpa a me, cosa che mi fece molto male».
«Comunque sia Smogmagica contiene due brani belli e ben riusciti: "Amico di ieri", dove anch’io ci ho messo del mio con la chitarra e l’armonica, e "Los Angeles", un brano la cui struttura centrale era già stata abbozzata dagli altri componenti, mentre l’inizio e la fine li abbiamo pensati a Los Angeles. In questo brano la chitarra svolge una parte molto importante».
«Naturalmente lì con noi c’era anche il produttore Reverberi che ha suonato quasi tutte lui le parti alla tastiera e con la quale ho avuto dei momenti conflittuali. Lui, tipo molto severo e dallo sguardo che incuteva timore reverenziale, mi riprendeva asserendo che stonavo delle note, ma io replicavo dicendo che era una licenza poetica e che in quel contesto ci stava. Terminato il disco, mentre eravamo tutti in sala ad ascoltare com’era venuta l’incisione, finita l’ultima nota si è girato verso di me per dirmi “Bravo, bravo!”».
Cosa ha significato per te questa esperienza?
«È stata un’esperienza indimenticabile! L’America per me era un mito. Non avevo mai preso un aereo, ero il più giovane del gruppo e mi ritrovai a Los Angeles a vivere per due mesi in una delle più belle ville di Laurel Canyon, un quartiere nella zona di Hollywood. Di giorno c’era il lavoro in studio e i servizi fotografici, ma alla sera, specie con Tony Pagliuca, si andava a vedere concerti importanti (avevamo i biglietti gratuiti), fra questi, anche uno di Bruce Springsteen. Inoltre, Armando Gallo, giornalista e corrispondente, che viveva a Los Angeles, ci faceva da cicerone portandoci in giro per la città».
Perché è durata così poco l’esperienza con Le Orme?
«Io dovevo essere il loro chitarrista, cosa che per me rappresentava molto per la mia carriera di musicista. Avevamo inciso Smogmagica che stava vendendo bene e anche per me erano arrivati dei buoni proventi. Con il gruppo mi ritrovai poi a febbraio per le prove del tour. Lì cominciarono i problemi. Il giorno stesso, ancora prima di mettere mano agli strumenti, discutemmo su come avrebbe dovuto essere lo spettacolo Rockspray; una parodia del prog che secondo Tony Pagliuca era un genere in via di estinzione. Visto che doveva essere uno spettacolo un po’ scherzoso, l’attenzione passò poi a come ci saremmo dovuti vestire. Mi dissero che io dovevo essere Arlecchino e sarei dovuto uscire per primo, saltando sul palco con la chitarra in mano per aprire il concerto con "Laurel Canyon". “Cosa? Ma se da bambino neanche a Carnevale mi sono mai messo in maschera!” Iniziammo le prove, ma ogni giorno veniva fuori la questione. Così io replicavo chiedendo a Tony se lui aveva imparato le parti alle tastiere, visto che in studio le aveva suonate Reverberi. Lui si arrabbiava e gli altri lo sostenevano perché ero l’ultimo arrivato».
«Io replicavo dicendo che non potevo mascherarmi da Arlecchino perché mi sarei sentito a disagio e che questo mio imbarazzo sarebbe stato controproduttivo. Proposi di trovare dei figuranti, ma loro replicarono dicendomi che se non l’avessi fatto avrei dovuto uscire dal gruppo. Doveva essere solo una provocazione per farmi cambiare idea e invece non fu così. A una settimana dall’inizio del tour si presentarono con un avvocato che tentò di persuadermi asserendo che lasciandoli causavo dei danni al gruppo e per questo avrei dovuto rinunciare ai proventi del disco. Non lo so, può darsi che fosse un loro estremo tentativo per farmi rimanere, ma decisi di andarmene e lasciarmi alle spalle tutto ciò che significava per me essere il chitarrista de Le Orme».
Come fecero senza di te?
«Trovarono un giovane e bravo chitarrista, Germano Serafin, anche lui di Treviso. Una settimana dopo la mia uscita andai a vederli a San Donà di Piave. Il concerto iniziò proprio come programmato, con Germano che esce vestito da Arlecchino e attacca con "Laurel Canyon". Io ero in mezzo al pubblico con la gente che gridava verso il palco “Bravo Tolo, bravo Tolo…”. Prova ad immaginare come mi sentivo… Immagino che per non tradire le aspettative e non fare brutta figura, quella sera non presentarono Germano Serafin. A quanto pare non lo fecero neanche in altri concerti, visto che ancora oggi incontro persone che mi dicono di avermi visto suonare con Le Orme nel 1976, in questo o quell’altro posto, credendo ci fossi io dietro la maschera di Arlecchino. Ancora oggi questa cosa mi fa un male che non puoi immaginare!».
E dopo Le Orme?
«Nella primavera del 1976 mi trovai praticamente senza lavoro. Nelle sale da ballo non c’era più richiesta di gruppi musicali perché era entrata in scena la disco music e i disc jockey. Inoltre non riuscì più a rinviare il servizio di leva e in autunno mi chiamarono, anche perché a maggio c’era stato il terremoto in Friuli e avevano bisogno di personale. Nel 1977 iniziai ad organizzarmi i primi concerti da solo: suonavo nel cinema parrocchiale, nelle sagre paesane e nei posti più disparati. Nel frattempo cominciarono a nascere i primi music-club, locali dove si proponeva l’ascolto di musica dal vivo. Formai il mio primo gruppo, i Super Blue (nome ispirato da un brano di J.J. Cale) e cominciai a proporre pezzi miei. Contemporaneamente fui invitato da Guido Toffoletti a suonare con la sua Blues Society e per due anni suonai con lui partecipando anche alla prima edizione di Pistoia Blues».
Il tuo primo disco solista è del 1981.
«Sì, è un Extended Play composto da quattro brani, lavoro che ebbe buone recensioni e passò anche nelle radio della RAI. Qui si può dire che iniziò la mia carriera. Seguirono poi altri due dischi Let Me Be (1982) e One Guitar Band (1983). Poi iniziarono a giungere richieste di concerti per Festival e sagre paesane (oggi “Feste della birra”) che volevano musica per i giovani e lì cominciai anche a guadagnare e fare della musica il mio lavoro.
Hai avuto un chitarrista che ti ha influenzato di più?
«Molti. Per fare la musica che faccio io, ho dovuto e voluto ascoltare tutti i chitarristi che hanno fatto la storia della musica: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Alvin Lee, Johnny Winter, B.B. King, Muddy Waters, Carlos Santana, Rory Gallagher, Nils Lofgren, solo per elencarne alcuni».
Tra questi ce n’è uno che ti piace di più?
«Rory Gallagher. Dal punto di vista umano lui è stato il mio chitarrista di riferimento. Il suo carattere un po’ timido, schivo e introverso, un po’ simile al mio, me lo faceva sentire vicino. Mi infatuai proprio di Rory, mi identificai con lui ed ero un suo fan. Però ce n’è anche un altro: Jimi Hendrix. Non si può che prescindere da lui per suonare la chitarra. È stato il più grande chitarrista. Genio e innovatore della chitarra elettrica, ha rivoluzionato la musica. Uno spartiacque della chitarra, perché per me esiste un prima e un dopo Hendrix».
Con quale musicista ti sarebbe piaciuto suonare?
«Con Steve Winwood, l’ex tastierista dei Traffic. La sua classe, il suo buon gusto musicale, mai fuori dalle righe, la sua capacità compositiva, ne fanno un gradissimo musicista. Pensa che dieci anni fa lo andai ad ascoltare in un concerto e quando lo sentii mi dissi: “io sarei il chitarrista perfetto per lui”. Con un tastierista così potrei toccare il cielo. Pensare di fare parte di un suo gruppo per me sarebbe un sogno».
Nei tuoi concerti proponi spesso brani di Rory Gallagher.
«Sì, almeno un paio. Come ti ho detto, per me è stato la mia grande passione da giovane. In questi ultimi anni è subentrata in me una sorta di nostalgia per gli anni della gioventù, sentimento che mi porta a suonare brani degli anni Setttanta. Mi piaceva molto il suo stile originale e imprevedibile, fuori dagli schemi. Rory era pieno di grinta e creativa, un musicista che sul palco creava pathos e trascinava il pubblico. Riproporre i suoi pezzi mi fa star bene».
C’è un disco nella storia della musica pop-rock che reputi imperdibile?
«Questa è una di quelle domande alla quale ci si vorrebbe sottrarre per la difficoltà della risposta. Comunque… tutta la discografia dei Beatles, tanto per cominciare. Poi alcuni dischi dei Rolling Stones, di Hendrix, di Joni Mitchell, di Miles Davis e dei Cream, ma più in generale tutta quella musica che va dal 1963 al 1970 perché c’è stata una rivoluzione culturale e la musica era libera. Però non riesco a dirti il disco che mi porterei nell’isola deserta».
Una volta mi raccontasti di un tuo brano che ricordava uno dei Pink Floyd…
«Sì, quando stavamo registrando Smogmagica, gli altri componenti de Le Orme mi chiesero se avevo dei brani da proporre. Da tempo ne conservavo uno nel cassetto: un arpeggio di chitarra di vecchia data. Proposi questa idea che poi si sviluppò in "Laserium Floyd". All’inizio il brano si doveva chiamare solo "Laserium", ispirato al planetario di Los Angeles. Terminato il disco fummo invitati ad una cena durante la quale ci fecero sentire in anteprima il nuovo album dei Pink Floyd, Wish you Were Here. A un certo punto, mentre scorrevano le note di "Shine On You Crazy Diamond" e sorseggiavamo del buon vino, tutti ci guardammo in faccia sorpresi. “Ma questo è Laserium” fu il coro di voci che si alzò. Così, contro la mia volontà, gli altri, per paura di venire accusati di plagio, decisero di aggiungere al titolo la parola Floyd per farla figurare come un omaggio ai Pink Floyd».
Prima Ian Paice, poi Roger Glover, il batterista e il bassista dei Deep Purple, ti hanno invitato a suonare con loro. Come ti sei trovato?
«Benissimo. Ma anche con Don Airey, il tastierista del gruppo. Questi sono musicisti dalla quale si ha solo da imparare. Può non sembrare vero, eppure sono delle persone semplici, che non si danno arie e ti mettono a tuo agio. Ogni volta che ho suonato con loro ho proposto brani miei, oltre ai successi dei Deep Purple, e il fatto che abbiano accettato di buon grado ha significato molto per me».
Spesso i tuoi fan ti definiscono un chitarrista rock-blues; in realtà con la tua musica ti sei avventurato anche nel country, nel rock psichedelico, nelle melodie, nelle ballate e forse anche in altre sonorità.
«È vero. Propongo sempre musica diversa perché, musicalmente parlando, sono molto curioso. Mi piace proporre suoni e stili nuovi, altrimenti mi annoierei a fare sempre la stessa musica. Nutrirsi di musica diversa è normale. Altrimenti sarebbe come mangiare per tutta la vita pastasciutta e bistecca».
Usi effetti o altri congegni per ricavare suoni particolari dalla chitarra?
«Diciamo che faccio largo uso delle sonorità che posso ricavare con le mie dita. Poi, se voglio enfatizzare di più una sonorità attraverso una distorsione, allora non escludo anche l’utilizzo dei pedali. Ma nel mio caso si può proprio dire che suono con le mani. Comunque sia è la fantasia del musicista che detta dove deve muoversi con le mani nello spazio tempo di un secondo. Non sono uno che si prepara uno schema, improvviso molto pur viaggiando attraverso canoni molto semplici».
Quale dei tuoi dischi ritieni il più riuscito?
«L’ultimo, My Cup of mMusic, ma ci aggiungerei anche One Guitar Band. Sono quelli che ritengo più sinceri, personali e intimi perché realizzati a casa mia e sono quelli alla quale ho dedicato più tempo. In comune hanno che tutta la musica che si sente l’ho suonata io senza l’utilizzo della batteria».
E il tuo brano migliore?
«"Alpine Valley", che mi è venuto durante un sogno mentre ero in Texas, ma anche T"wo-five-two-four-o", il mio vecchio numero telefonico, "See the time e Flamica", brano con sonorità da film».
Il concerto che ricordi con più piacere?
«In questo momento…, quello della scorsa settimana (marzo 2019) in centro a Treviso. Sarà perché nella mia città non ci suono mai, sarà perché è andata bene e mi sono divertito un sacco a suonare con la band, sarà perché anche il pubblico si è divertito, sta di fatto che quel concerto me lo ricordo con grande piacere. Sai, di concerti belli ne ho fatti tanti, ma vivendo molto il momento, tendo sempre a ricordare l’ultimo. Poi, a dire il vero, ci sarebbe anche quello a Londra quando spaccai tre corde della chitarra perché ero troppo teso per la paura. Dopo aver rotto tre corde, all’inizio del quarto pezzo mi dissi: “Ma io sono venuto a Londra per rompere le corde? No, sono venuto per farmi ascoltare”. Da quel momento ho ripreso a suonare bene e la gente non terminava più di chiedermi dei bis».
E quello con Ginger Baker, il batterista dei Cream?
«Nell’aprile del 1984 ricevetti una telefonata dal promoter del tour italiano di Ginger Baker. “Ciao Tolo, domani c’è il concerto di Ginger Baker a Spinea, ma Roberto Ciotti è indisposto e non può suonare. Puoi sostituirlo?” “Domani? Mi piacerebbe ma come faccio? Non so che repertorio fa …, la vedo dura. Chi canta?” chiesi. “Devi cantare tu e suonare la chitarra. Sarete in trio”. Ero più preoccupato che contento. Come potevo accettare una proposta così importante all’ultimo momento? Mi pareva di fare un salto nel buio. Il promoter mi chiese poi qual era il mio cachet. Gli dissi che era quello solito. “No, ti do la metà” replicò lui. “Perché la metà?” chiesi, ma poi accettai perché in fin dei conti suonavo con uno dei miei idoli».
«Il pomeriggio del giorno dopo giunsi a Spinea con la mia vecchia Peugeot. Scaricai la chitarra e l’amplificatore e li montai sul palco, per provare. Ma provare cosa? Chiesi aiuto al bassista che alzò le spalle con un’espressione che sembrava dire “problema tuo”. Poi il manager mi dice che devo parlare con il batterista. “Hi Mr Baker, I’m Tolo, I am your guitarist for today. May I ask you which songs you woud like to play?”»
«Lui, Ginger, mi degna appena di uno sguardo, senza proferire l’ombra di un titolo. Gli dico che conosco diversi brani dei Cream, ma conosco solo un paio dei loro testi. “I do not play Cream songs” mi risponde seccato e senza voler provare. Poco prima dell’inizio del concerto ero disperato perché non sapevo cosa dovevo cantare e suonare. Alla fine del lungo concerto, nella quale sia il bassista che Ginger avevano dato tutto per la gioia del pubblico, mentre stavamo smontando gli strumenti si avvicinò il manager dicendo: “Ginger vuole vederti, vai”. Entrai nella roulotte, lui si alzò in piedi e sorridendomi mi tese la mano. “You are great!” disse riempiendomi di gioia e soddisfazione».
«Il giorno dopo mi telefonò di nuovo il manager dicendomi che Ginger voleva continuare il tour con me. “Va bene, ma questa volta mi dai il cachet che ti ho chiesto” dissi. “No Tolo! Suonare in questo tour con un nome così ti serve per la tua carriera” replicò lui. “Vuoi sapere un cosa? Prima di tutto ciò che mi serve è rispetto. Chiamati un altro chitarrista”. Alla fine il tour del leggendario batterista dei Cream fu cancellato.
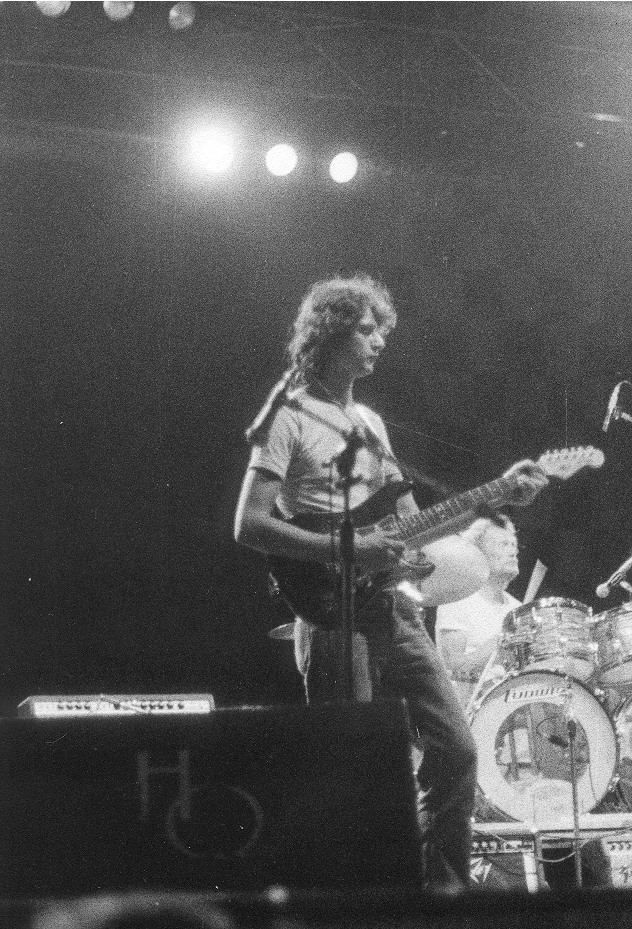
Nel 2010, dopo 35 anni, c’è stata la reunion con Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca.
«Questa reunion fu voluta dalla manager della PFM. che aveva in programma di organizzare un grande evento a Roma sulla musica orog. Oltre al Banco del Mutuo Soccorso, la PFM e altri gruppi, voleva che ci fossero anche Le Orme. Chiese espressamente che ci fossi anch’io, cosa che per me è stata una sorta di riscatto. Ero felicissimo. Bisogna però anche ricordare che prima di allora sia Tony Pagliuca che Aldo Tagliapietra mi avevano invitato a suonare con loro. Della faccenda di Arlecchino ci avevo messo una pietra sopra».
«Sul palco di Roma venimmo poi presentati non come Le Orme, ma come Tagliapietra-Pagliuca-Marton. Continuammo poi a suonare insieme, c’era in programma anche un disco, ma dopo sei mesi tutto finì per dissidi e incomprensioni fra loro due».
Nei tuoi concerti appari spesso con un cappello in testa: è un portafortuna o una questione di look?
«Tutto è iniziato nel 1992 quando mi feci crescere la barba e mio figlio mi regalò un cappello con scritto jazz. Stavo partendo per l’America e avevo deciso di cambiare il mio aspetto. Volevo in qualche modo nascondermi un po’ dagli sguardi della gente. L’impatto con il pubblico, specie quand’ero giovane, mi ha sempre intimidito».
Nel panorama musicale italiano vieni considerato uno dei maggiori chitarristi, eppure non hai avuto il successo che forse meritavi. Pensi sia dipeso solo dal tuo carattere schivo che ti ha tenuto lontano da manager e compromessi che il jet set musicale pretende?
«Penso sia dovuto al mio carattere che mi fa apparire come una persona difficile. In realtà sono una persona gentile, corretta e rispettosa, ma non un ruffiano, “dote” che aiuterebbe di più a far carriera. Così, per quanto riguarda la musica, oggi non è importante la qualità, fare un pezzo che duri nel tempo, ma tirare fuori qualcosa che si costruisce in studio, pensato per la massa, canzoni che si dimenticano nell’arco di qualche mese. Questo è il successo! A queste logiche io non sono mai voluto cedere. Non riesco e non posso fare qualcosa se non mi sento a mio agio. A oggi non ho un manager, né una casa discografica e faccio più fatica di un tempo nel ricevere proposte di concerti».
«La libertà di suonare ciò che senti tuo è impagabile».
Hai dei rammarichi come musicista?
«Ho fatto sì delle scelte contro i miei interessi, ma preferisco stare bene con me stesso piuttosto che essere un musicista di successo e provare disagio nel fare quello che non mi piace. La libertà di suonare ciò che senti tuo è impagabile».
Tutta la vita hai “solo” suonato. Ti sembra poca cosa?
«No, è già tanto. Magari tutte le persone facessero solo quello che sono portate a fare. Mi sarebbe piaciuto fare molte altre cose, ma non le ho fatte perché non ero in grado di farle. Avrei voluto viaggiare molto, ma sono una persona che non ha il senso dell’orientamento. Ho difficoltà nel muovermi e trovare riferimenti. La musica invece è l’unico luogo in cui mi so orientare».
Per la musica hai dovuto sacrificare un po’ la famiglia: rifaresti ancora questa scelta?
«Sì, anche perché ho avuto la fortuna di avere una moglie e dei figli che mi hanno sempre supportato nel mio lavoro. Le decisioni che ho preso le abbiamo sempre ponderate assieme. Certo è che chi fa musica, necessariamente si trova a dover trascurare un po’ la propria famiglia. Si è spesso fuori casa e non si hanno orari. Ma la musica è stata una scelta di vita: l’unico lavoro per cui ero portato».
Saltuariamente tieni dei seminari musicali. È un’esigenza, una moda?
«Nessuna delle due. Mi invitano e io vado. In giro c’è un gran numero di scuole di musica e tanti aspiranti musicisti. Mi piace poter insegnare a suonare la chitarra. Di solito sono chitarristi che già suonano e io cerco di dare loro qualcosa che non viene insegnato nelle scuole. Condivido la mia esperienza sperando che possano poi proseguire con un loro stile».
Cosa hai provato quando nel 1998 hai ricevuto dalle mani del papà di Jimi Hendrix il 1° premio per la tua composizione "Alpine Valley" e come miglior interprete di Hendrix?
«Un senso di imbarazzo unito a una gioia indescrivibile. L’imbarazzo e anche il disagio sono sentimenti che provo quando vengo festeggiato: sono innati in me. Quando ero a Seattle, non sapevo di venir premiato, e quando ho sentito il mio nome, la prima cosa che ho detto è stata: “Oh, no…”».
«Quando suono so dove sono e dove devo andare, so cosa devo fare, come reagire, so tirarmi fuori da una difficoltà, posso cambiare direzione all’istante, navigare a vista».
«Poi però è prevalsa la gioia. Però due anni prima, al concorso di chitarra, me la sentivo che avrei vinto questo premio. Oltre ai cinquemila dollari e altri regali, ricevetti da Al Hendrix una chitarra Stratocaster, copia fedele della chitarra di Jimi».

Cos’è per te la musica?
«La musica è il territorio, l’ambiente in cui riesco ad orientarmi meglio. Quando suono so dove sono e dove devo andare, so cosa devo fare, come reagire, so tirarmi fuori da una difficoltà, posso cambiare direzione all’istante, navigare a vista. Per me la musica è un viaggio, è la mia vita».
E Tolo senza la musica?
«Impossibile! Ho dato tanto alla musica, ma anche lei ha dato tanto a me. È una questione di sopravvivenza. Posso rimanere anche giorni senza suonare, ma nella vita il mio rapporto con le altre persone non può che prescindere dalla musica. Lei mi ha guidato e aiutato nei rapporti con gli altri. Con il mio carattere timido non so come sarebbe andata senza la musica».
Ti piace di più comporre nella tua solitudine o il pubblico dei concerti?
«Entrambe le situazioni. Nei concerti il pubblico è una comunità nella quale tu ti trovi in compagnia con qualcuno che vuole sentirti suonare. Ti senti al centro dell’attenzione e questa è davvero una bella sensazione. Ricordo che quando ero giovane e frequentavo una compagnia di amici, la mia timidezza mi escludeva dai discorsi. Allora prendevo la chitarra e suonavo per ore, dialogavo con lei, ma avrei voluto che qualcuno condividesse con me il piacere della musica. Avere un pubblico è davvero gratificante perché si suona per gli altri, mentre a casa suono per me stesso ed è appagante avere delle intuizioni e comporre».
«Quello che mi piace di più è poter scegliere cosa proporre, e se poi la risposta del pubblico è positiva, se lo vedo felice, allora mi sento ripagato. Ma non sempre va così. A volte, dopo due ore di concerto mi sento prosciugato di tutta l’energia senza aver ricevuto niente in cambio di quanto ho dato».
Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta il rock ha vissuto il suo momento di espressione migliore. Nel frattempo la musica ha preso altre strade. Pensi ci sia ancora spazio per esprimersi col rock?
«La musica rock dagli anni Cinquanta in poi ha preso strade, vesti, forme e linguaggi diversi. La parola rock intende qualcosa di duro, pesante, ma io la vedo anche come una ribellione, qualcosa che ha a che fare con i giovani. Finché ci sarà ribellione ci sarà rock. Finché ci sarà qualcuno che metterà in discussione il già fatto, visto e sentito, ci sarà rock. Il rock per essere tale deve essere sempre nuovo e libero, lontano dalle briglie delle case discografiche, dalle mode e dalle abitudini del pubblico. Perché non muoia il rock deve rompere schemi ed essere innovativo. Prendere cose del passato mettendoci del nuovo. Più che un’analisi questa è una speranza. Se devo essere sincero il rock se non è morto è messo molto male».
«Ci vuole una rivoluzione, non solo musicale, ma culturale! Altrimenti è la musica che muore».
«Bisogna che i nuovi musicisti abbiano il coraggio di sperimentare e non di proporre musica trita e ritrita spacciandola per nuova. Ci vuole molta creatività, ma i discografici impongono musica usa e getta”, che abbia successo subito e faccia cassa; se poi questa non è musica con la M maiuscola, a loro poca importa. Guarda oggi, ci sono molti giovani che vogliono andare a fare l’esame a X Factor con una cover. Ci vuole una rivoluzione, non solo musicale, ma culturale! Altrimenti è la musica che muore».
Per un musicista invecchiare è come per un’altra persona?
«Sai, a un musicista può succedere di non andare in pensione. Lui suona per tutta la sua vita perché la musica è la sua passione. Poi quando si invecchia s’invecchia. Si ha paura delle malattie, di rimanere soli, della morte, ma suonare è un buon antidoto ed è vero che ti fa sentire giovane. Comunque posso dirti che invecchiando ho acquisito più saggezza e consapevolezza in quello che sto facendo e per ora mi sento ancora in forma. Da giovane ero più spontaneo e molto incosciente, mi buttavo con foga nella musica, a volte con risultati non proprio buoni, con la maturità riesco a produrre musica più interessante, ma a tratti meno spontanea».
Hai avuto dei problemi di udito e ti sei curato con l’ago puntura… Avesse potuto farlo anche Beethoven…
«Sì e in parte il problema è ancora presente e riguarda le frequenze che ho perso nella conversazione con le persone. Ma le note musicali le sento ancora, anche se le frequenze che ho perduto mi storpiano un po’ il reale ascolto del suono della mia chitarra. La mia chitarra viaggia su frequenze medio alte e non sento un suono puro: spesso non mi piace il suono della mia chitarra, mentre un tempo quando suonavo il suono mi piaceva di più. L’agopuntura mi è servito, soprattutto per la conversazione. Premesso che dalla sordità non si guarisce, se Beethoven avesse avuto i mezzi che ci sono oggi, chissà cosa avrebbe potuto fare. Considera che dirigeva l’orchestra immaginandosi la musica che ne scaturiva».
Qualche tempo fa mi hai confidato un sogno: partire per l’America e rimanerci per almeno un anno a suonare in ogni dove; è sempre vivo questo tuo desiderio?
«Sì. Ho sempre desiderato di tornare a suonare in America e oggi ancor più di prima perché in Italia mi sento trascurato. Speravo di avere più soddisfazioni, non parlo del pubblico, ma dagli addetti ai lavori. Ho la sensazione che negli USA potrei esprimermi meglio, ma soprattutto venire considerato per quello che veramente sono. Come dicevo prima, io non riesco a scendere a compromessi; a dover fare e subire ciò che l’industria discografica ti impone».
Come immagini l’America dei tuoi sogni?
«Come una grande opportunità. Mi piacerebbe scrivere musica anche per altri interpreti e perché no, anche per il cinema. Desidererei trovare un management, qualcuno che apprezzi la mia musica e che mi aiuti dove io non sono capace, ad esempio nel propormi».
Pensi di riuscire a realizzare questo tuo sogno?
«Non lo so. Dipende tutto da me. Se riesco a trovare la forza, il coraggio e vincere le mie paure forse partirò. Dovrei davvero provarci. Me lo dico tutti i giorni, ma poi…».
«Attendo la nascita del mio prossimo nipotino e poi, all’inizio del 2020, o parto o il mio sogno svanirà per sempre».
«Forse dovevo rimanerci di più negli anni Novanta quando mi premiarono a Seattle. Adesso mi sto dando un tempo. Attendo la nascita del mio prossimo nipotino e poi, all’inizio del 2020, o parto o il mio sogno svanirà per sempre. Ma credimi, vedere gli altri miei nipotini, specie quello di un anno e mezzo che ogni volta che vado a trovarlo corre subito a prendere la chitarra giocattolo per darmela in mano, be’, mi commuove di gioia».



