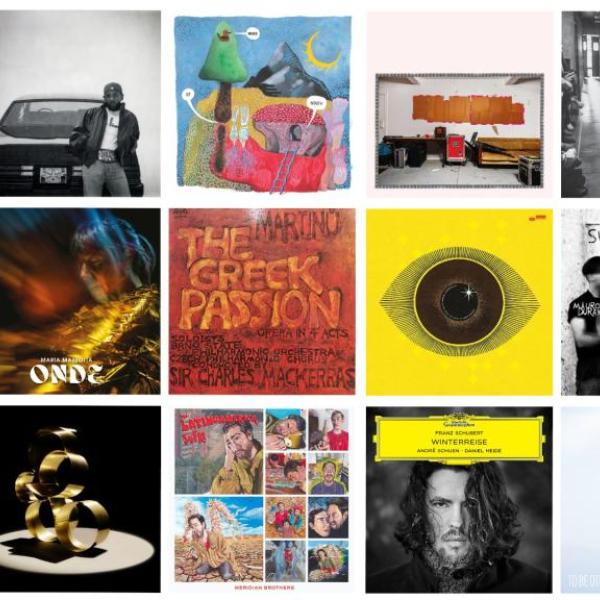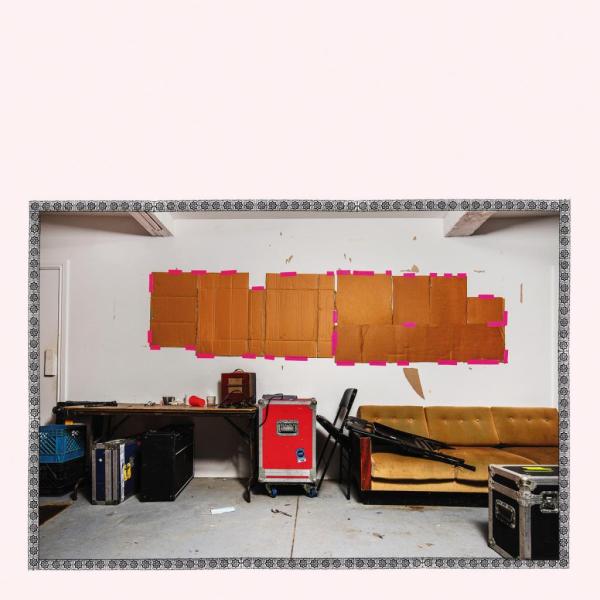La vampata di sdegno è stata fulminea, rabbiosa. Una reazione violenta e istintiva, a segnalare un'insofferenza ormai diffusa. Tutti contro Spotify e Daniel Ek, amministratore delegato (CEO, per dirla all'americana) della piattaforma di streaming battente bandiera svedese (299 milioni di utenti, il 29% in più rispetto a un anno fa, per 1,89 miliardi di euro di fatturato nel secondo trimestre del 2020).
– Leggi anche: Il CD sta morendo, ed è un problema
Colpa di una breve intervista concessa a Music Ally a margine del bilancio pubblicato a fine luglio, e in particolare di un paio di contestatissimi passaggi sul presente e sul futuro del mestiere di musicista. «Non puoi registrare un disco ogni tre o quattro anni e pensare che sia sufficiente». E ancora: «Quelli che non guadagnano con lo streaming sono gli stessi che vorrebbero continuare a pubblicare musica nel modo in cui è sempre stata pubblicata». Niente di che, a dirla tutta: considerazioni da manager che come orizzonte ha il mercato globale (con lo sbarco in Russia e nell'Est Europa sono 92 adesso i Paesi raggiunti oggi da Spotify) e come metro di giudizio le milionate di click che si trasformano in milionate di euro. Non a caso nella famigerata intervista viene citato come esempio virtuoso l'ultimo disco di Taylor Swift, Folklore, che ha da poco battuto il record annuale di ascolti giornalieri sfondando quota 98 milioni: non esattamente un target alla portata delle masse.
«Quelli che non guadagnano con lo streaming sono gli stessi che vorrebbero continuare a pubblicare musica nel modo in cui è sempre stata pubblicata» – Daniel Ek
Quel che ci interessa però, al di là dei (discutibili) contenuti e delle valutazioni di ordine etico-morale (doverose ma secondarie), è l'evidente problema di pulpito, diciamo così, alla base dell'irritazione collettiva: inaccettabile per i più non è stato il merito, non sono stati i perché snocciolati con il piglio dell'illuminato da Daniel Ek, ma il fatto che la predica su come un musicista debba o non debba comportarsi per mettere assieme il pranzo con la cena sia arrivata da chi, secondo la narrazione che va largamente per la maggiore, sfrutta il lavoro altrui e affama gli artisti riempiendosi le tasche.
Spotify è il male assoluto, la fine della musica (cito a memoria da un paio di recenti articoli dei catastrofisti di turno), l'orizzonte degli eventi oltre il quale ci sono solo impoverimento e desertificazione.
– Leggi anche: ECM su Spotify: cinque secondi di silenzio
Per fortuna c'è Bandcamp a rischiarare la notte in cui tutte le piattaforme sono nere. Anche se Bandcamp, che ha sede a Oakland, in California, non è una vera e propria piattaforma di streaming ma un servizio di promozione e distribuzione on-line. «A musical company», l'ha definita l'amministratore delegato Ethan Diamond in una chiacchierata con NPR, «a record store and a music community». Che affronta il problema dei problemi, garantire un introito agli artisti ai tempi dell'ascolto liquido, da un'angolazione completamente diversa rispetto al gigante svedese.
Talmente diversa che il sempre più frequente accostamento tra Bandcamp e Spotify assume spesso i contorni dello scontro di civiltà, della sfida impari tra un amorevole Davide paladino delle nicchie e un mostruoso Golia al servizio dei poteri forti e dell'industria. Come se i due modelli fossero diametralmente opposti e alternativi, come se l'uno escludesse l'altro in una perfetta e insanabile dicotomia. In realtà non è proprio così. Certo, la distanza c'è ed è notevole, lo vedremo a breve. Eppure la conflittualità non è poi così marcata. Lo dimostra, tra le altre cose, la costante crescita di entrambi. In un presente del quale sono figli legittimi e in un rapporto di contiguità problematico finché si vuole ma tutt'altro che bellicoso.
Spotify ha un valore di mercato di 45 miliardi di dollari, il triplo rispetto al gruppo Warner Music e una dozzina di miliardi sopra la quotazione del colosso francese Vivendi, del quale fa parte la Universal.
Spotify ovviamente giganteggia per numeri e volume d'affari (si parla di un valore di mercato della società che oscilla stabilmente attorno ai 45 miliardi di dollari. Tanto per avere un'idea dell'ordine di grandezze, il triplo rispetto al gruppo Warner Music e una dozzina di miliardi sopra la quotazione del colosso francese Vivendi, del quale fa parte la Universal). I maggiori introiti provengono dagli abbonamenti, sottoscritti da una consistente e crescente fetta degli utenti (138 milioni, il 27% in più rispetto a un anno fa, con l'obiettivo dichiarato di scollinare i 150 entro la fine dell'anno). Un bel gruzzolo, che al netto degli utili, delle spese e delle tasse, che si portano via circa il 48% della torta (calcolo approssimativo), viene poi diviso tra chi della musica messa a disposizione dalla piattaforma detiene i diritti (case discografiche, distributori digitali e artisti).
Come? Secondo un criterio puramente matematico, ovvero attribuendo un valore preciso a ogni singolo ascolto. Facile a dirsi, un po' meno a calcolarsi. In primis perché non ci sono dati ufficiali: il riserbo sulla questione è pressoché inscalfibile. E poi perché c'è tutta una serie di parametri statistici e geografici in continuo mutamento da prendere in considerazione (un click negli Usa non ha lo stesso valore di un click in India). Per farla breve, diciamo che se non siete Taylor Swift o la Universal, che ha di recente sottoscritto un nuovo accordo separato («e non l'avrebbero fatto se non fossero soddisfatti», il commento di Ek), si va da 0,003 a 0,005 dollari ad ascolto (0,0025-0,0042 euro). Una miseria. Della quale solo una parte, al netto di ciò che spetta a casa discografica e distributore, arriva effettivamente nelle tasche dell'artista.
Spotify paga da 0,003 a 0,005 dollari ad ascolto (0,0025-0,0042 euro), della quale solo una parte, al netto di ciò che spetta a casa discografica e distributore, arriva effettivamente nelle tasche dell'artista.
Capite bene insomma che Spotify non è un paese per piccoli ma uno spietato moltiplicatore di disparità. Che tra l'altro prevede dei meccanismi di sperequazione progressiva che premiano i soliti noti: più sei cliccato, più il margine sul singolo click aumenta. A tutti gli altri le briciole e la frustrante consapevolezza che non c'è modo di guadagnare cifre se non significative, per lo meno non umilianti (le fotografie di assegni da zero virgola pubblicate da musicisti anche discretamente famosi hanno fatto più volte il giro del web).
Altro che consentire a un milione di creativi di vivere dei profitti della loro musica, come ancora recita lo statuto di Spotify: mai come oggi la filantropica dichiarazione d'intenti, anche alla luce dell'assenza di correttivi efficaci e di una politica improntata a una più equa redistribuzione e a una totale trasparenza, sa di beffarda utopia. E a poco vale lo sbandierato aumento annuale, da 30.000 a oltre 43.000, del numero di artisti in quota top-tier, ovvero coloro che da soli generano il 90% del traffico (meno del 3,5% del totale, che dovrebbe avere superato di un bel po' gli 1,2 milioni dichiarati a fine 2019): il meccanismo è intrinsecamente perverso e al di sotto di una certa quota di visibilità (molto, molto alta) non c'è modo di mettere il naso fuori dall'acqua.
Spotify non è un paese per piccoli ma uno spietato moltiplicatore di disparità.
Perché allora il numero di brani caricati quotidianamente continua ad aumentare (siamo sopra i 60 milioni)? Perché ci si affanna per stare su Spotify? Perché bisogna esserci, vi risponderanno i più. O magari perché non lo hanno deciso loro ma le etichette, il produttore o il distributore. E poi per una questione di praticità e di rappresentanza: un player universale e un link da girare a chi vuole (o deve) ascoltare. Comodo, no? Tanto chi spende lo fa a prescindere da Spotify e dal fatto che tutto (non è vero: ma questa è un'altra storia) sia ormai gratuitamente a disposizione di tutti.
Il che ci porta direttamente a Bandcamp. Spazio strutturato in modo che al centro ci sia chi produce contenuti e non solo chi ne usufruisce. Lasciando che sia l'artista a gestire in autonomia il proprio angolo di piattaforma, a fissare il prezzo per il download delle singole tracce o dell'intero album, a decidere cosa mettere in streaming gratuito e cosa no. Senza obblighi, senza intermediari, senza la necessità di appoggiarsi a distributori digitali. Con in più la possibilità di interfacciarsi e di comunicare con i propri follower riuniti in comunità virtuale. Follower che a loro volta, in una logica di sistema che via via si è fatta sempre più social, hanno a disposizione un profilo privato visualizzabile e seguibile dagli altri utenti e che funziona come una sorta di diario di bordo, con l'elenco dei brani-dischi acquistati e una lista pubblica dei desideri.
Tutto molto spartano e statico ma straordinariamente pratico e intuitivo. Anche nel caso in cui si opti per l'acquisto fisico. Già, perché uno dei servizi più apprezzati e maggiormente in crescita è quello che permette agli artisti di mettere in vendita cd e vinili (ma anche gadget di ogni tipo); in crescita a tal punto che in quel di Oakland hanno da poco deciso di provare a occuparsi direttamente della stampa e della distribuzione di vinili a determinate condizioni (30 giorni di tempo per raggiungere l'obiettivo delle 250 copie prenotate, poi scatta il pressing).
Come guadagna Bandcamp? Offrendo servizi aggiuntivi a etichette e musicisti (abbonamenti “pro” che vanno dai 10 ai 50 dollari al mese), e soprattutto trattenendo il 15% sulle transazioni digitali e il 10 su quelle fisiche.
Come guadagna Bandcamp? Offrendo servizi aggiuntivi a etichette e musicisti (abbonamenti “pro” che vanno dai 10 ai 50 dollari al mese), e soprattutto trattenendo il 15% sulle transazioni digitali e il 10 su quelle fisiche. Il resto, al netto di una quota compresa tra il 4 e il 6% che se ne va in spese (anche Paypal e gli altri vogliono la loro parte), spetta all'artista. Al quale basta vendere un paio di dischi per portarsi a casa il controvalore di due anni di Spotify. Se poi il giro si allarga e la comunità di follower cresce, magari anche grazie alla spinta delle playlist o degli approfondimenti che periodicamente vengono pubblicati, c'è il rischio di riuscire davvero a vivere della propria musica.
Qualche esempio? L'acclamato Untitled (Black Is) del collettivo londinese Sault al momento è stato comprato-scaricato da più di 5100 utenti; sono quasi 3000 invece quelli che hanno messo le mani su Universal Beings del batterista jazz Makaya McCraven. I calcoli fateli voi, ma non stupisce che dal 2007 Bandcamp abbia distribuito la discreta somma di 584 milioni di dollari, e che attualmente viaggi alla media di circa 16 milioni di dollari al mese.
Su Bandcamp a un artista basta vendere un paio di dischi per portarsi a casa il controvalore di due anni di Spotify.
Prosperando in quel settore di mercato a forma di lunga coda che sfugge alle maglie larghe della rete di Spotify. Un vicino scomodo, dal ghigno sinistro e minaccioso, ma sostanzialmente pacifico e lontano. Non solo per i numerosi zeri di distanza, ma anche per via di un paio di differenze macroscopiche.
La prima riguarda il target. Difficile immaginare che il profilo di chi garantisce le milionate di click a Taylor Swift sia sovrapponibile commercialmente a quello di chi compra il vinile di Makaya McCraven o scarica l'ultimo inedito di Tim Berne. I vasi restano comunicanti, d'accordo, ma in linea di massima, visto che sono i grandi numeri poi a pesare sui bilanci, la cesura sembra netta: da una parte una fruizione orizzontale, molto più passiva, e un oceano sconfinato di utenti in rapidissimo e brulicante movimento (non a caso servono 30 secondi di ascolto consecutivo per far muovere il contatore degli stream); dall'altra un approccio verticale, mirato, che presuppone delle scelte e dei tempi lunghi.
Anche perché le due piattaforme, e qui siamo alla seconda differenza sostanziale, non potrebbero funzionare in maniera più diversa. Se Spotify è pensato per essere agile, immediato, pervasivo, per arrivare ovunque e per adattarsi a qualunque dispositivo, Bandcamp è lento, goffo, ingombrante; il primo intrattiene il più a lungo possibile, intrappola in una selva di link, di suggerimenti, di playlist e podcast (la nuova frontiera: 1,5 milioni di possibilità da Harry Potter a Michelle Obama e Alessandro Barbero), il secondo accompagna bonariamente verso il momento dell'acquisto, facendo affidamento sulle intenzioni di chi decide di aprire i cordoni della borsa.
Se Spotify è pensato per essere agile, immediato, pervasivo, per arrivare ovunque e per adattarsi a qualunque dispositivo, Bandcamp è lento, goffo, ingombrante.
Insomma, due pianeti diversi. E una conflittualità cristallizzata che simbolicamente ricalca in digitale uno schema di opposizione classico: l'eterna lotta dell'artista per liberarsi dal giogo schiavizzante dell'industria. Da questo punto di vista in molti sembrano voler affidare a Bandcamp il compito di portare avanti una battaglia che dura da decenni e che si ripropone in forme e modi sempre diversi ma l'uno dopo l'altro metabolizzati e assorbiti dal mercato (pensate al punk, al grunge, all'illusione della rivoluzione indie).
Una romantica forzatura? Probabilmente sì, ma è presto per i giudizi definitivi. L'equilibrio non è mai stato così precario e l'irruzione di un terzo attore, le onnipotenti piattaforme, non potrà non avere conseguenze a breve e a lungo termine. Ma non saranno certo le prese di posizione dei vari Peter Gabriel, Sufjan Stevens e Bjork, tanto per citare alcuni dei big che hanno deciso di passare a Bandcamp, a spostare l'asse di rotazione di un sistema che poggia ancora saldamente sulle spalle delle majors, la cui capacità di adattamento è stata forse sottostimata ai tempi in cui si parlava con troppa disinvoltura di coma irreversibile.
Che fare dunque? Disperare? La buona notizia è che le possibilità di strategie alternative, di percorsi diversi, di arrivare al cuore delle comunità di ascolto, si moltiplicano anche per chi sta ben al di sotto della soglia di sbarramento. C'è vita oltre lo streaming, e persino oltre Spotify.
Grazie a Marco Valente per la chiacchierata e i consigli.