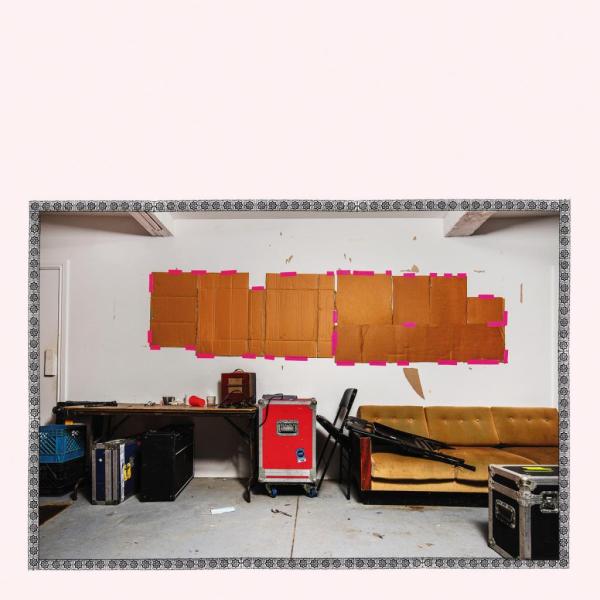Per una curiosa coincidenza temporale, nel giro di poche settimane sono stati pubblicati due dischi con lo stesso titolo: Black Classical Music. Uno è a nome dell’ensemble Esecutori di metallo su carta, l’altro da parte del batterista inglese Yussef Dayes.
– Leggi anche: 19' 40'', ovvero l'anticlassica
Ambiti stilistici e geografici ben distinti – lo diciamo per fugare ogni sospetto plagiario – ma il gioco del destino e delle parole è a volte utile per provare a rovesciare qualche prospettiva che l’abitudine e la velocità degli accadimenti rischiano di fossilizzare nella percezione collettiva. Curiosamente nella descrizione presente sul sito della loro encomiabile “collana di musica su abbonamento” 19'40'', gli Esecutori di metallo su carta si definiscono – coerentemente all’approccio antiaccademico che Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro hanno dato al progetto – un ensemble di musica “anticlassica”.
Nel caso di Dayes invece, come affermato apertamente nella presentazione del disco, è il grande crogiolo dell'espressività afroamericana, quello del jazz, del blues, della diaspora caraibica, a meritare l’appellativo di “musica classica nera”.
Qualcosa dunque che sfugge, che è sfuggito, che deve essere risemantizzato, reimmaginato, accomuna due dischi così diversi: in quello degli Esecutori di metallo su carta si affronta uno stimolante programma cameristico di compositori afrodiscedenti, nomi che in alcuni casi sono ormai, vivaddio, riconosciuti, ma che vi sfido a trovare spesso nei programmi concertistici; nel disco di Dayes – che possiamo inserire in quella ampia tendenza cosmic-diasporica del recente jazz inglese – ci troviamo di fronte a un variegato affresco a groove variabile, saturato di featuring come si conviene nello spirito comunitario di queste pratiche.
Nel disco degli Esecutori di metallo su carta si parte con la sonata per strumento a tastiera con violino del “Mozart nero” francese Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George (siamo ancora in pieno Settecento), si prosegue con una gustosa trascrizione per percussioni e basso di un lavoro pianistico di Blind Tom Wiggins, per giungere a due maestri come Samuel Coleridge-Taylor (di cui ci eravamo già occupati qui) e William Grant Still, la cui classica “Summerland” viene trascritta per sax alto e piano.
Di Robert Nathaniel Dett vengono proposte per vibrafono e piano due delle otto Bible Vignettes, mentre di John Wesley Work III, insigne studioso del folklore nero, si riscoprono due deliziosi momenti da Scuppernong, Three Pieces for Country Folk. Di Julius Eastman, felicemente “sdoganato” negli ultimi anni con alcune delle sue più memorabili composizioni, viene ripresa la sorprendente “Macle” per 4 (qui 5) voci, una bellezza.
Il lavoro si chiude con una composizione per violino di George Walker, primo afroamericano a vincere il premio Pulitzer per la musica, qui trascritta per il vibrafono dal bravissimo Sebastiano De Gennaro.
Un lavoro rigoroso nel suo approccio estremamente personale, in grado di aprire connessioni, di svelare i dettagli più visionari, di riportare in superficie quello che le dinamiche di diffusione avevano posto in secondo piano. Eccellente.
Il registro per raccontare il disco di Dayes è necessariamente differente: qui le composizioni sono nuove e originali e lo status di “classico” nero è riservato parimenti alle fonti di ispirazione e all’esito, che vuole in qualche modo eludere le tassonomie popular più abituali.
Esito che è innanzitutto frutto di un’attenta produzione, un po’ sulla scia di quanto sta facendo da un po’ Makaya McCraven, nonché di quella capacità metabolica a 360° del jazz inglese meticciato che ne sta facendo la fortuna trasversale presso comunità anche molto differenti di ascoltatrici e ascoltatori.
– Leggi anche: Jazz, chiamiamolo con il suo nome
Si va infatti dal solare e muscolare hard-bop della title-track d’apertura alla raffinata “Raisins Under The Sun” con la presenza dell’immancabile Shabaka Hutchings, passando per giardini incantati di broken beats come “The Light” e arrivando con molteplici cambiamenti di atmosfera a cose più fusion come “Tioga Pass” con il basso di Rocco Palladino, già abituale collaboratore di Dayes.
L’impressione è di essere di fronte a un disco ottimamente costruito, in cui il drumming di Dayes funziona come un fenomenale collante in grado di dare coerenza alle idee più esili così come ai momento più ispirati, che non sono pochi, anche se come spesso accade si poteva fare tranquillamente a meno di una ventina buona di minuti.
Il messaggio diventa così quasi una conferma: per questa generazione di musicisti – e come è anche del tutto naturale che sia in un contesto di totale fluidità dei generi – l’orizzonte di riferimento è ampio e i maestri della tradizione jazz siedono accanto ai mille ritmi della diaspora africana e alle mille declinazioni groove-oriented delle popular music più o meno recenti.
Una sorta di esperanto in cui il dichiarato riferimento a una classicità nera dal forte afflato metabolico è certamente pertinente e riposiziona paradossalmente fuori dagli altarini un po’ scomodi della mitopoiesi novecentesca tutta una serie di urgenze che non smettono di tornare a interrogare chi fa musica e chi l’ascolta.
Che queste due accezioni di black classical music – quella di riscoperta di un lignaggio compositivo afro-discendente e quella di ampio riferimento per nuove generazioni di artiste e artisti desiderosi di confrontarsi con le grandi strade della black music – siano venute fuori, anche un po’ casualmente, nello stesso momento è un segno comunque tangibile della forza dei linguaggi neri, della loro capacità di inabissarsi e riemergere ogni volta con potenzialità rinnovate.